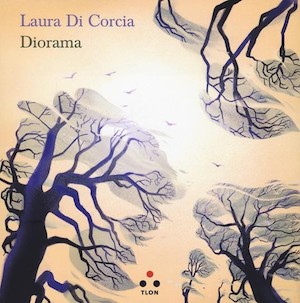Laura Di Corcia torna alla poesia con la raccolta Diorama (edizioni Tlon, pp. 104), prefazione di Filippo Tuena e come suggerisce lo stesso titolo, subito si spalancano agli occhi del lettore molteplici visioni temporalmente lontane, divenendo la pagina difatti una sottilissima filigrana, oltre la quale si muove la rappresentazione sempre nuova della scena tempo-mondo. Si perché la poetessa srotola parallela nelle pagine, alla storia dello spirito, quella del suo operare concreto che muta continuamente le linee del paesaggio terra: «… // Le città germogliano / bucano il tempo / dimenticano le chimere / ammassano nelle campagne / le paure / …».
Certo nel libro ogni poesia porta nel suo dna il racconto del quotidiano, che è anzitutto indagine antropologica, quasi riflessione a tutto tondo dell’individuo su sé stesso. Ma tale quotidianità, ha impressa una sua diacronia, venendo anche da quel tempo mesopotamico lontano millenni, dove la civiltà della scrittura è scaturita e da dove però sembrano rincorrersi, come incise in un pittogramma sempre attuale, anche le violenze contemporanee che proprio in quelle terre e in particolare nella città curda di Kobane, simbolo di resistenza, sono tornate col loro carico di sinistra simbologia.
Ecco però, da questo pozzo oscuro, accendersi una speranza, che come in un cerchio lega volti femminili così lontani: quello saggio e compassionevole della donna mesopotamica, vecchia più di quattromila anni, con l’altro della soldatessa combattente e resistente in Siria: «Aspettami fra il Tigre e l’Eufrate. / Ovvero quel punto della terra / triangolo da cui parte la retta/della storia // io sono una guerriera silenziosa / … // aspettami, dico, e troverò il modo / di ricostruire tutto // …». Quasi ci suggerisce la poetessa, che la progressione storica, non porti a un ampliamento della spiritualità, anzi mini alle fondamenta il tempo del sottosuolo e del silenzio, dentro il quale nacquero le più alte favole e certo il medioevo viene scelto in alcuni versi non a caso, perché momento importantissimo di convergenza dell’antico che si sta diradando, con i suoi fantasmi però così vitali e il nuovo sistema di pensiero che con le sue zampine raziocinanti, la sua scolastica, inizia ad attecchire.
Ma proprio in quel limbo, sembra ancora resistere in certe pagine, l’esperienza della piena spiritualità, confusa dai più per stregoneria, portatrice invece di reciproco riconoscimento e di un pensiero così attualizzabile sulla piena eguaglianza dei sessi. E il libro torna come a sbalzi, di continuo sul crinale della sofferenza, in special modo femminile, che prende forme sempre nuove, riacutizzandosi poi laddove la fiamma della spiritualità appunto si attenua: «… // Essere una donna significava / non poter piegare il tempo / ripiegarsi sul grembo / avere le parole, e sprecarle / lungo il fiume, gettarle per terra / insieme al sale // …».
E nel tempo odierno dei materialismi sfrenati ed etero diretti dalla ideologia dell’utile, questa dimensione effimera si ingrandisce e invade come detto, il sacro spazio del silenzio e della riflessione, cosicché in questo circuito ben oliato dalla modernità, ogni specie tende a essere reificata, mercanteggiata e infine strattonata: «… / …Partecipate voi al banchetto osceno, cibatevi. Vendete le merci sotto i porticati e ancora una volta sparite nel giallo. Ma lasciatemi vivere di questa innocenza tremenda, di questo modo di stare attaccata alle cose, di non sentirmi e dirmi sola // …». La violenza allora è sull’uscio, un’ombra pronta ad allungarsi sulle nostre esistenze, già da sempre ondeggianti sul crinale di una ontologica precarietà.
Ma vi è anche in Diorama la riflessione molto sentita, sullo strumento attraverso il quale il pensiero su di noi si è andato edificando: la scrittura. Occorre allora maturare questa consapevolezza: tutto era già prima della stessa, che ebbe però il merito di dare a questo tutto una misurazione, una ponderazione, ma anche talvolta una errata visione. Ecco ciò che la poetessa ci suggerisce: nel momento in cui il segno si getta sul foglio, porta alla luce ciò che sempre è, perché dà ad esso rappresentazione: «Quando iniziò la scrittura era tutto parallelo. Indistinto si muoveva tutto piallato. / Il sasso era il sasso, il vento il vento. / Non c’era niente di predeterminato. // Poi è arrivata la storia a prendere ai fianchi l’epoca bianca / …».
Nella parte finale del libro, Laura Di Corcia è capace con un guizzo di rendere la dismisura del tragico in cui siamo immersi, anche attraverso una chiara operazione nella pagina di sottrazione della profluvie linguistica mono argomentativa, che ci sta divorando in modo schizofrenico. Difatti il suo verso, anche dentro una pandemia senza fine, è lì nelle ultime pagine, a dar forma a quella semplice vita, fonte di riflessione e mistero, che era prima dell’uomo e che dopo l’uomo, caduta anche la sua scrittura, permarrà: «… // E ora aspettiamo che l’erba spontanea / rinasca fra i binari / che mostri che resistere / è mettere il naso nel verde del mondo /».
Bibliografia
Laura Di Corcia, Diorama, Roma, Edizioni Tlon, 2021