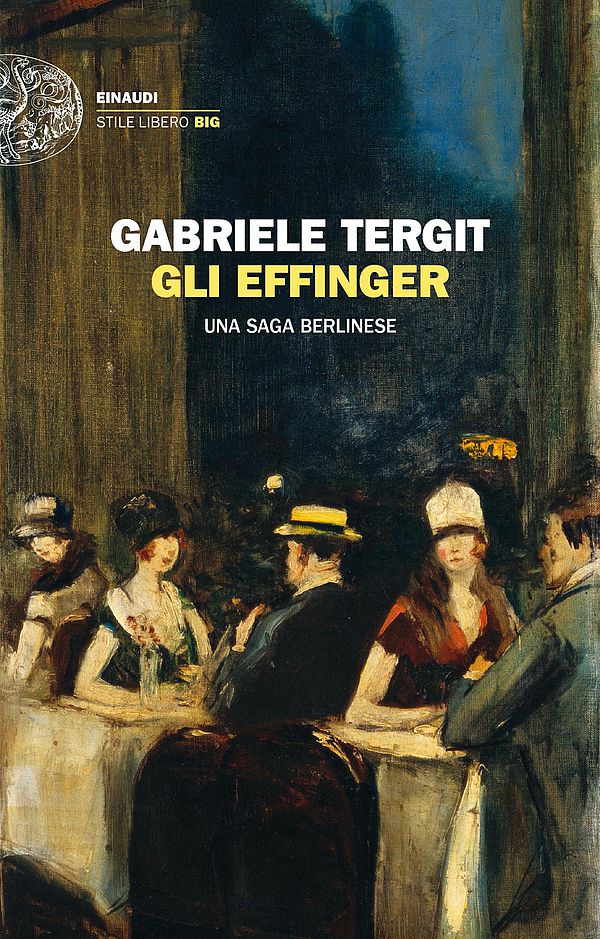Non è solo un viaggio nel tempo, ma la suggestiva rievocazione di un mondo scomparso, un atto d’amore verso il proprio passato travolto da drammatici eventi. Il romanzo dell’ebrea berlinese Gabriele Tergit, Gli Effinger, che Einaudi propone nell’ottima versione di Isabella Amico di Meana e Marina Pugliano con un’interessante postfazione di Nicole Henneberg, ripercorre attraverso quattro generazioni settant’anni di storia tedesca, dall’epoca di Bismarck al 1948. E porta in scena la provincia bavarese come la grande borghesia di Berlino, il mondo intellettuale e quello godereccio delle feste e dei ricevimenti con una vivacità sorprendente e una sottile arte nel costruire dialoghi e personaggi che raccontano un’epoca attraverso le disavventure della loro vita.
Del resto la Tergit, nata nel 1894, il cui vero nome era Elise Hirschmann, si era già affermata come giornalista e cronista giudiziaria, poi come scrittrice nel 1931 con il romanzo di successo Käsebier conquista il Kurfürstendamm pubblicato dal grande editore Rowohlt, il cui protagonista è un cantante popolare, una star che il pubblico abbandona nell’arco di una sola stagione. Anche lui vittima di quella illusoria pubblicità che ben presto troverà spazio nell’infame propaganda del ministro nazista Joseph Goebbels.
L’anno dopo, quando iniziò a scrivere la sua saga berlinese, che qualcuno definì i «Buddenbrook ebraici», non poteva prevedere che quel manoscritto, a cui lavorò fino al 1950, se lo sarebbe portato in giro per il mondo dopo aver abbandonato l’amata Berlino nel marzo del 1933, giusto in tempo per sfuggire alle camicie brune che penetrarono in casa sua. Con il marito, l’architetto Heinz Reifenberg, e il figlio di cinque anni, fuggì dapprima in Cecoslovacchia, poi in Palestina e infine a Londra, dove rimase fino alla morte nel 1982. A fatica riuscì a pubblicare nel 1951 il romanzo dell’esilio in cui proiettò, oltre a dettagli autobiografici, gesti e vicende di una comunità destinata allo sterminio. Eppure, a quel tempo, il libro passò quasi inosservato. La tragedia tedesca era ancora troppo recente perché il pubblico potesse adeguatamente affrontarla.
È comunque sorprendente la varietà di personaggi, spesso contrapposti, che animano queste pagine tra le mille sfumature di una classe sociale facoltosa e amante della bella vita
Ma la Tergit parlava anche di un mondo proiettato verso lo sviluppo e la modernità, non indifferente tuttavia alla tradizione e ai valori del passato, ben simboleggiati nella figura del vecchio Mathias, lo stimato orologiaio di un paesino della Baviera, ebreo ortodosso e padre del giovane e intraprendente Paul, che come il fratello Karl riuscirà a trasferirsi nel 1882 a Berlino diventando col tempo un solido industriale. Inizia a fabbricare viti in una piccola officina, per poi ingrandirsi, costruire motori a gas e infine automobili. Successo economico e ascesa sociale vanno di pari passo: ambedue s’imparentano con la famiglia del banchiere di corte Emmanuel Oppner in affari con il suocero Goldschmidt. Karl, che si ritiene baciato dalla fortuna, ne sposa la figlia Annette, mondana e vanitosa, mentre sua sorella Klärchen, tutta casa e famiglia, si unisce a Paul, un gran lavoratore, responsabile e premuroso verso i propri dipendenti. Lui pensa con nostalgia alla lontana provincia, dove tutto era più facile, e non bisognava lottare per la propria posizione e identità sociale. Coltiva però una tradizione capace di guardare al futuro, come faranno i figli degli Effinger, da Marianne impegnata nel sociale e con un deciso orientamento democratico, alla vivace cugina Lotte, che chiuderà con la vita borghese per dedicarsi al teatro da cui sarà cacciata all’arrivo dei nazisti. Figure che propongono il tema della donna in un’ottica femminista che stava a cuore alla stessa Tergit.
È comunque sorprendente la varietà di personaggi, spesso contrapposti, che animano queste pagine tra le mille sfumature di una classe sociale facoltosa e amante della bella vita. C’è la moglie di Ludwig Goldschmidt, la bella e raggiante Eugenie originaria di Pietroburgo, che frequenta la Costa Azzurra e organizza grandi pranzi domenicali nella sua splendida casa nella zona residenziale del Tiergarten, ben diversa dalla cognata Selma, la rigida prussiana che detesta ogni atteggiamento da parvenu. Mentre sua figlia Sofie affascinata dalle tele di Renoir e Monet che ha potuto ammirare dallo zio Waldemar, giurista insigne e collezionista d’arte, decide di dedicarsi alla pittura, a Parigi e a Monaco, inseguendo però i sogni di sempre: l’amore vero e un ruolo all’interno della società, che la sorella Annette ha acquisito coltivando il lusso e il piacere di una vita dispendiosa.
Tra gli uomini della famiglia accanto al banchiere Emmanuel, gran borghese, amico di Bismarck, spicca soprattutto la figura di Waldemar, amante dell’illuminismo del pensiero liberale, pronto a risolvere le situazioni familiari più complesse e a sostenere il ruolo essenziale degli ebrei nel mondo tedesco. Tra i più giovani si distingue per la sua simpatia e bellezza James, figlio di Karl, seduttore incorreggibile, che si troverà sbalzato in guerra, come il fratello Erwin, tra l’Alsazia e i Balcani, capace di resistere con il suo vitalismo a qualsiasi avversità. Matura nel romanzo quasi inavvertitamente, il confronto fra generazioni su temi sociali, politici e religiosi, in una varietà di voci e idee che s’intrecciano o contrappongono in brevi flash mettendo a fuoco l’identità di personaggi incalzati, nel corso del tempo – protagonista vero di tutto il romanzo – da conflitti mondiali, grande depressione, lotte sociali e nazismo. E tutto si trasforma in racconto, costante fluttuazione fra storia individuale e collettiva, mentre le luci di Berlino si spengono sul tragico destino degli Effinger. Paul e altri membri della famiglia, fra cui l’anziano Waldemar, vengono deportati e uccisi, mentre la casa dove aveva vissuto con Klärchen, come tutte le abitazioni della Bendlerstrasse, dove oggi sorge la Filarmonica, è rasa al suolo.
Forse la vita riprenderà in quella bella primavera del 1948, si augura nel breve epilogo la vecchia cuoca Frieda, ma è ormai sfigurata da un dolore perenne e dal silenzio di milioni di vittime innocenti.
Bibliografia
Gabriele Tergit, Gli Effinger. Una saga berlinese, Torino, Einaudi, 2022.