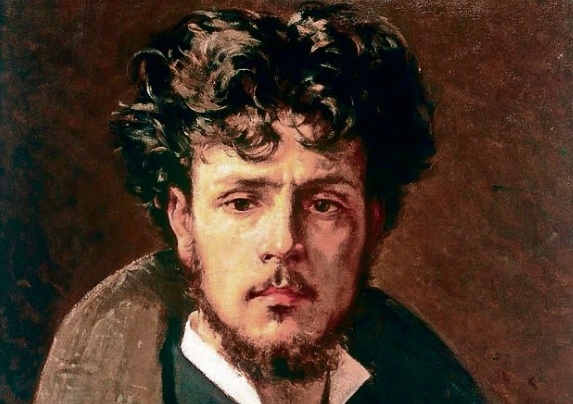Tra il voltagabbana e il voltamarsina corre un confine di Stato. Ragioni misteriose, note forse soltanto ai più agguerriti linguisti, hanno fatto sì che in Italia i traditori voltino, metaforicamente, un semplice soprabito da lavoro, mentre nella Svizzera italiana si rovesci addirittura un frac, quella marsina imposta dall’omonimo conte belga (Jean de Marsin) alle truppe stanziate in Fiandra nel XVII secolo. Quale ne sia l’origine, è certo che in Ticino «voltamarsina» è divenuto espressione proverbiale soprattutto dopo la pubblicazione del romanzo di don Francesco Alberti (1882-1939), apparso nel 1932 e trasformato nei primi anni Novanta in un fortunato sceneggiato televisivo.
Il sacerdote nato in Uruguay ma originario del Malcantone, fratello della pedagogista Maria Boschetti, è una delle riscoperte recenti portate alla luce dal progetto «Lugano Città Aperta» e dalla creazione del Giardino dei Giusti di Lugano, come correttamente ricorda Armando Dadò nel colophon di questa nuova edizione, uscita per le cure di Flavio Catenazzi e con una prefazione di Davide Adamoli. All’Alberti giornalista e direttore del «Popolo e Libertà», all’antifascista della prima ora, all’uomo di radio e al curato di campagna andrebbe aggiunto infatti ‒ è l’invito dei curatori ‒ il tassello non meno importante del romanziere, un capitolo aperto dal Voltamarsina e chiuso solo pochi anni più tardi, a ridosso della morte, con Diavolo di una ragazza! (1939), che pure meriterebbe rinnovata attenzione.
«Voltamarsina, mai!». Il refrain delle prime pagine del libro, incentrate su questioni politiche lontane anni luce dalle presenti, guarda a un’epoca in cui il Canton Ticino era ancora saldamente diviso in due schieramenti distinti, conservatore e liberale. A cavallo tra Otto e Novecento il terzo polo, socialista, era ancora di là da venire e tutte le battaglie si scioglievano di fatto in favore dell’uno o dell’altro fronte, tra clericali e anticlericali (con leggerissime sfumature), non senza gli accadimenti estremi di schioppettate notturne e persino, talvolta, con morti e feriti.
La politica accende anche i protagonisti del romanzo, lo stradino Tomaso e il rivale «Spuzzetta», ma non ne determina la vera natura, che non si esaurisce nel mero scontro ideologico ed è più vicina semmai a quella dei personaggi di un romanzo d’appendice: questa la chiave di accesso all’opera di Alberti, uscita a puntate sul «Popolo e Libertà» e anche per questo concepita per catturare il lettore con continui colpi di scena e repentini cambiamenti di prospettiva.
Confrontato ad altri romanzi del tempo, dentro e fuori i confini della Svizzera italiana, Il Voltamarsina conserva infatti una freschezza e una piacevolezza di lettura che va riconosciuta tra i meriti del suo autore, capace di alternare una lingua alta, a tratti persino desueta («lenocinio», «giulebbe», «adontarsi»), e affondi antropologici favoriti dall’utilizzo di un lessico dialettale («Donca cuntèe su…», «A sem già scia», «L’è rivò cumè un cucumer e u va via cumè un Toni»), accolto in toto nel testo e spiegato in nota quel tanto che basta per restituire al lettore il sapore di un’epoca passata, tra «i dolci colli del dolcissimo Malcantone».
Nella sua introduzione, utile a ricostruire il contesto in cui il libro si colloca, Flavio Catenazzi rispolvera pubblicazioni coeve ad opera di sacerdoti che seppero fare un uso intelligente, con risultati a volte anche pregevoli, del linguaggio letterario a fini pastorali e didattici, un ambito al quale anche l’Alberti appartiene. Il modello di riferimento erano naturalmente I promessi sposi, al punto che nel libro si potrebbe seguire con facilità una pista manzoniana (Catenazzi segnala alcune tappe) fatta di stilemi e di strutture narrative appresi alla scuola del grande scrittore lombardo, specie quando si tratti di gestire le azioni o le parole dei personaggi.
Su questa linea, si sarebbe tentati di fare un passo ulteriore e ascrivere le ambizioni di Alberti a un manzonismo «alla seconda», fatto non tanto (non solo) di prelievi mirati, o di schemi consolidati da cui trarre ispirazione, ma anche di allusioni sottili rivolte a un lettore che si suppone ben preparato sulla storia di Renzo e Lucia: «Don Roberto Ferroni, parroco di Collinazza, se ne stava nel pancone, vicino al camino, rileggendo le Egloghe, secondo le vecchie tradizioni classiche non spente ancora, in quei passati tempi. Ma don Roberto non aveva bisogno di chiedersi: “Chi era costui?”…».
Man mano che la storia si allontana dal misfatto iniziale, cioè la colpa dell’urna e il nome infamante di «voltamarsina», il cuore del problema si sposta verso una più generica questione di fedeltà: alla religione degli avi, alla casa, alla patria (memorabili le pagine sull’esercito svizzero: don Alberti fu anche un apprezzato cappellano militare), persino a un’idea di amore che si sarebbe tentati di definire tale, non fosse per quel pudore consueto, indicibile, così tipico della tradizione paesana.
Resta da dire del personaggio femminile, una Rosa non priva di spine che deve meno alla Lucia di Manzoni e più alla Luisa di Fogazzaro, anarchica e ribelle come quella, forse meno assoluta, ugualmente ferita nell’animo (anche a lei morirà una figlia). Alla fine, rientrati i rivoli della storia in un matrimonio a lungo desiderato, il voltamarsina Tomaso è l’unico veramente capace di grandi fedeltà, misurate su una scala diversa da quella un po’ arida delle antiche contabilità di partito.