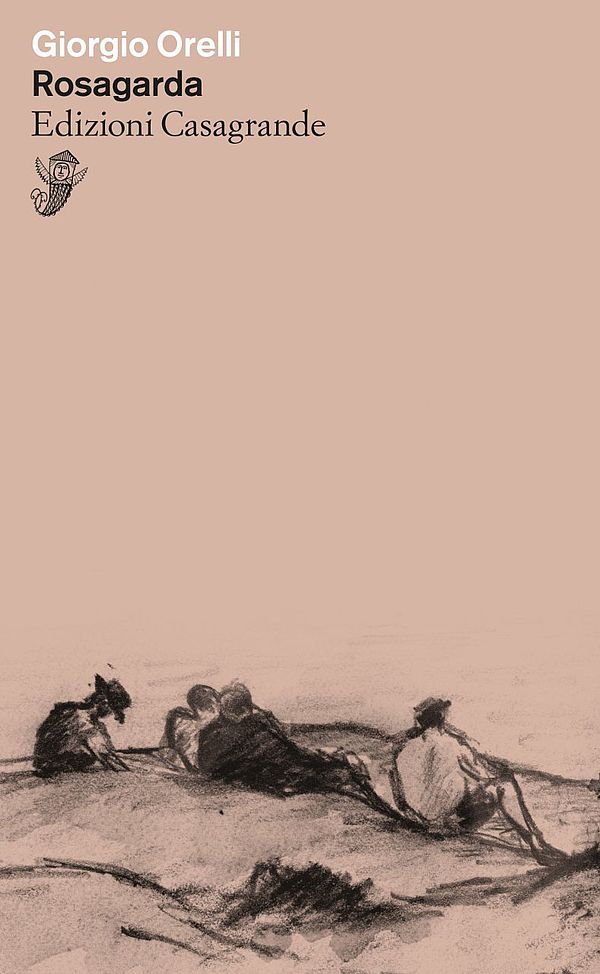Il 25 maggio Giorgio Orelli avrebbe compiuto cento anni. Scomparso il 10 novembre 2013, aveva continuato a lavorare alacremente fino a quell’estate, con l’energia e la voglia di vivere che spesso difettano in molti giovani. L’ultima volta che, non senza titubanza, osai andare a trovarlo mi chiese cosa stessi facendo «di bello». «Tre cose abbastanza grosse» gli risposi ringalluzzito, pronto a sciorinare dettagli, piste, ipotesi interpretative, insomma il nocciolo dei saggi storico-letterari cui stavo attendendo in quei mesi (nemmeno ricordo più quali). «Io sei!» ribatté lui con sorriso gentile di vittoria: «sei libri! non si finisce mai, Montorfani, è un lavoro a tempo pieno». Intendeva il lavoro sulla parola, come assai bene intitolarono il convegno in suo onore andato in scena l’anno successivo a Bellinzona, cogliendo nel pieno la vocazione attorno alla quale era andata ruotando, in varie forme ma con esiti sempre altissimi, la sua intera esistenza non solo letteraria.
Di quei sei metaforici «tavoli», il doppio di quelli pascoliani, qualcosa è uscito postumo negli ultimi anni grazie alla prudente disponibilità della famiglia e alle ancor più attente cure filologiche di Pietro De Marchi. Abbiamo avuto così la sua postrema silloge poetica, L’orlo della vita, in appendice all’Oscar Mondadori pubblicato nel 2015, e i racconti di Pomeriggio bellinzonese (Casagrande, 2017), cui si associa oggi una seconda anta del dittico, le prose brevi – ma non poi così tanto – dedicate alla Leventina. Da qualche parte nello studio di Ravecchia restano uno studio su Pascoli, il tormentato dossier sul Fiore attribuibile, chissà, a Dante Alighieri, e la famosa Suite in là con gli anni, testi per i quali bisognerà forse esercitare ancor maggiore prudenza prima di pensare a una loro divulgazione. Ma già così, con questi ultimi gustosissimi pezzi, ci sarà materia per anni a venire.
Rosagarda, come segnalano i curatori, è il toponimo poco noto di un pascolo situato tra Rodi e Prato Leventina, paese d’origine della madre di Orelli e luogo ideale se non della sua infanzia (divisa tra Airolo e Locarno) certo delle estati giovanili, insomma l’immagine simbolo – quasi la «Rosabella» di Quarto potere – di un mondo alpestre cui l’autore ha sempre associato valori morali e timide saggezze ataviche, ma anche stramberie e piccoli crimini tipici della meschinità umana: un mondo intero contratto in poco spazio, non però una bolla di vetro con la neve finta, un paesaggio fuori dal tempo e dalla storia come quello al quale sembrerebbe alludere l’infelice titolo proposto dal «Corriere della Sera» nel dare negli scorsi giorni la notizia (Il Canton Ticino ascolta lo sbadiglio del gallo, «La Lettura», 16 maggio 2021).
Per sincerarsene basterebbe seguire, nei tre racconti che compongono il libro, il continuo filone della morte che, con tutte le sue varianti semantiche (l’assenza, il distacco, lo scampato pericolo, la mancanza di comprensione e comunicazione, l’oblio, la difficile persistenza della memoria, il sofferto dialogo tra le generazioni), attraversa l’opera dalla prima all’ultima pagina.
Mentre sbadigliavano galli – vero, è citazione orelliana – il Ticino degli anni Quaranta-Settanta subiva una delle accelerazioni più brusche della propria storia e di tutto questo traspare non poco nelle pagine di Orelli, sempre così attente a cogliere ogni più piccolo sommovimento sismico della superficie antropologica e sociale: «Alla fontana in mezzo al villaggio mi sono accorto che dopo la rapida pulizia di questi anni le case fanno fatica a darsi la mano e sono meno allegre. Cede all’asfalto l’erba; amica dei nostri piedi nudi, dei nostri giuochi non solo infantili. Non si vede anima viva e anche a me sembra d’essere vivo per miracolo, uno che c’è e non c’è».
Corvi planano minacciosi su autostrade costruite da poco, mentre sopra la testa del poeta cacciatore (un cacciatore poetico, potenziale, che mai ammazzerebbe una bestia per quanto dannosa) si schiantano Hunters nella valle del Tremorgio, i «sarcofaghi volanti» emblemi dell’annoso dibattito attorno alle necessità, e alle spese, dell’aviazione militare elvetica. Mi chiedo allora, adocchiando le prime recensioni che iniziano a uscire in Italia, se un diverso accompagnamento di questi testi (più nella forma di un commento contestualizzante che di filologia pura e dura) non avrebbe fatto loro un migliore servizio: nessun lettore al di sotto di Ponte Chiasso capirebbe mai il tenore emotivo del «viaggio» dell’alpigiano leventinese fino alla capitale Bellinzona in cerca del «segretario di concetto» (diciamo un vice-ministro) e molti dei termini stessi propri della cultura alpestre (la «boggia», la «barca») finiscono per non parlare più nemmeno a chi quelle montagne oggi attraversa volentieri per diporto.
Importerà forse a nessuno che il «Richino» il cui nome si sventola a un certo punto quale minaccia di ritorsioni sia il Consigliere federale ticinese Enrico Celio, in carica dal 1940 al 1950, elemento sintomatico di una realtà piccola, intrecciata, ancora rurale e familiare eppure già quasi moderna nei suoi ritmi e sicuramente molto politicizzata (nonché sofferta) nei suoi rapporti con la Svizzera transalpina. In pagine che si aprono non a caso, tra il serio e il faceto, con il ricordo della rivolta anti-urana del 1755, durante la quale fu giustiziato un antenato dell’autore.
Un’ottima chiave interpretativa a queste prose così ricche e dense, anche di storia, la offre Matteo Terzaghi nella sua bella postfazione, che richiama giustamente il sovrapporsi dei tempi cronologici e il gusto tutto italiano per un’affabulazione improvvisante e piacevole, quasi caotica nel suo festeggiare la vita attraverso le parole, per mezzo di «facezie» e «storielle». Davvero delle suites, queste pagine di Orelli, ma non come le rigorose serie paratattiche delle ronde di danze settecentesche, che staccavano di netto un pezzo dall’altro come tante monadi, e più simili semmai alle modulazioni jazzistiche in cui un tema ne richiama un altro, lo varia, lo abbandona, solo per riprenderlo poco più avanti, quasi per caso, quasi senza un disegno apparente (pescando persino al di fuori del perimetro di questo libro, verso altri testi anche poetici, come ebbe a intuire per primo Massimo Danzi).
Un Orelli-Wagner, dunque, abile concertatore di Leitmotive, o un Orelli-Offenbach nei brani più popolari e delicatamente erotici. Mai però autore di semplici sequenze di innocui e coloriti aneddoti, come pare di intuire qui e là, perché il gallo, terminato lo sbadiglio, a volte perdeva la testa e finiva magari in padella. Quando questa non restava desolantemente vuota.