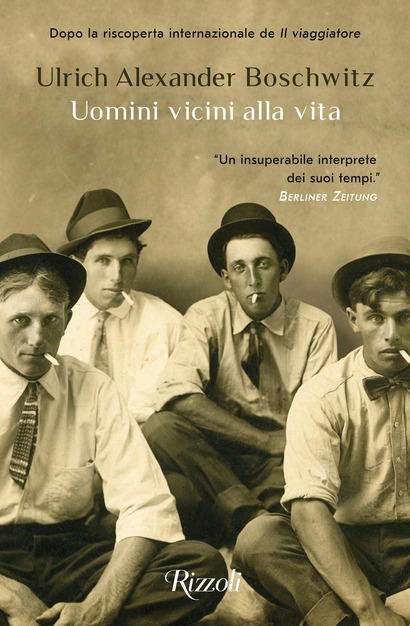Pubblicare un ottimo romanzo a ventidue anni e restare per decenni sconosciuto è un triste, paradossale primato. Sembra impossibile che un libro come Uomini vicini alla vita dell’ebreo Ulrich Alexander Boschwitz, che Rizzoli propone ora nella vivace traduzione di Marina Pugliano e Valentina Tortelli, uscito nel 1937 in svedese, sia passato inosservato. Come, del resto, la sua seconda opera, Il viaggiatore, che lo scrittore pubblicò in inglese a Londra con lo pseudonimo di John Grane nel 1939. Era la storia di Otto Silbermann, uno stimato commerciante ebreo obbligato a fuggire nel novembre del 1938, il giorno dopo la Notte dei Cristalli, che passa da un treno all’altro per non essere catturato dai nazisti. Un esule in patria, un emigrato nelle ferrovie del Reich.
Erano anni difficili non solo per la letteratura, e il giovane Ulrich, nato in una famiglia benestante a Berlino nel 1915, l’anno stesso in cui il padre morì al fronte, migrava anch’egli, con la madre, da un paese all’altro per sfuggire alla violenza nazista. Prima in Svezia, poi in Belgio e Francia e infine in Inghilterra, dove però, allo scoppio del conflitto, fu dapprima internato come «straniero nemico», poi deportato in Australia. Di ritorno, nel 1942, la nave su cui viaggiava venne affondata da un sottomarino tedesco e Boschwitz scomparve nelle acque dell’oceano insieme al dattiloscritto del suo ultimo romanzo.
Per il mondo culturale tedesco rimase un perfetto sconosciuto. Solo grazie a Peter Graf, che ne rivide anche gli originali, i suoi due romanzi vennero pubblicati in Germania un paio di anni or sono. E fu subito chiaro che quel giovanissimo e talentoso scrittore era figlio del proprio tempo: ne aveva colto umori e problematiche, più dai libri forse che dalla realtà. In effetti Boschwitz sembra aver assorbito con il latte materno, come qualcuno ha detto, molti scrittori dell’epoca: da Joseph Roth a Döblin, da Horvarth a Kästner. Anche i suoi personaggi in effetti sono proiettati in una realtà urbana attraversata da profonde inquietudini e lacerata da scontri sociali, crisi finanziaria e disoccupazione.
Sono vittime di una società senza speranze: accattoni, clochard, figure scaturite da un’epoca di miseria, che un tempo avevano dignità e lavoro. Come Fundholz che raccatta qualche soldo per strada ed è felice se riceve una zuppa o una salsiccia affumicata. E dire che c’era stato un tempo in cui guadagnava, possedeva una casa e aveva una moglie. Ma da allora era trascorso un secolo e adesso faceva il mendicante e gli toccava dormire negli scantinati o sulle panchine. Per di più aveva sempre alle costole quel barilotto di Tönner, un matto innocente ossessionato dalla fame. Ai due si aggiunge Grissmann, bigliettaio sui tram ora disoccupato, che ogni tanto progetta qualche furto. Quando poi conosce il cieco Sonnenberg che la moglie Elsi accompagna sempre a Wittenbergplatz a vendere fiammiferi, pensa che non sarebbe male portargli via la donna. Anche se lui è piuttosto mingherlino e quell’altro un marcantonio divorato dall’ira, vittima di ingiustizia, che la guerra ha condannato per il resto dei suoi giorni alla cecità.
Ci pensa la signora Fliebusch, ormai sui sessanta, a portare in scena qualche guizzo stravagante: è convinta di non capire più il mondo, disorientata di fronte a quella città dove rombano grossi autobus e stridono i tram di passaggio, mentre da macchine e camion erompe una musica cavernosa. Ma soprattutto, convinta di vivere ancora nell’anteguerra e ignara della drammatica inflazione, non capisce come siano svaniti i sessantamila marchi che aveva sul conto e dove sia finito il marito Wilhelm, quell’uomo bello e forte, che dicono sia stato ucciso da una granata in guerra. Impossibile, ribatte lei. E così lo va a cercare persuasa che tutti la stiano ingannando.
I personaggi che Boschwitz muove sulla scena del romanzo con grande disinvoltura e una certa dose di umorismo si ritrovano poi, tutti insieme, per ragioni diverse, nell’osteria Fröhlicher Waidmann, dove accanto ai disoccupati e agli ubriaconi ci sono ragazze in cerca di clienti e, sul tardi, gente della buona società che cala dai quartieri borghesi per vedere come si diverte il popolino. Qui troviamo anche Minchen Lindner, un corpo da vamp e un animo da «ragazza innocente» che un tempo faceva la commessa in un negozio di profumi, poi licenziata ha pensato bene di farsi mantenere da un maturo direttore di fabbrica. Così riesce anche a provvedere a suo padre che lì all’osteria dimentica fra grappe e birre il suo passato di ufficiale giudiziario finito in carcere.
Il Fröhlicher Waidmann gestito dal robusto signor Hagen, marito della proprietaria, diventa a un certo punto il microcosmo di un mondo al capolinea. In una sala appartata si riunisce perfino la corale Liederkranz von 1929 composta da ruffiani e sfruttatori pronti a cantare solo quando arrivano le sirene della polizia.
Qui si raccolgono e confrontano destini, qui ha luogo il drammatico scontro finale fra Sonnenberg e il furbastro Grissmann che balla con sua moglie e spera di portarsela via. A nulla valgono i consigli di Fundholz: il cieco sospettoso e furibondo afferra il rivale che impaurito estrae un coltello e glielo conficca in gola. Così, ricorda l’autore, la rivolta contro la vita diventa rivolta contro sé stessi. Boschwitz scrive un grande libro sull’impossibilità di ridare un senso alla speranza. Uomini e donne travolti dalla propria miseria e disperazione la cui filosofia si ritrova nelle parole di Fundholz: «Meno si pensa alle cose impossibili da cambiare, meglio è».
Forse solo la bella Minchen e il giovane Wilhelm, conosciuto nel locale, sembrano guardare oltre: lei ha un po’ di risparmi e insieme potrebbero aprire un negozio di generi coloniali. Mentre alla povera Elsi, ormai di nuovo sola e abbandonata, la vita appare sempre più «sporca e grigia». Chissà se andrà meglio a Fundholz che, seguito da quel bietolone di Tönnchen, si rimette in cammino con una sensazione di leggerezza. Peccato che Boschwitz non abbia avuto a suo tempo l’attenzione che meritava. Era giovanissimo ma aveva già capito come girava il mondo. E forse qualcosa racconta ancora a noi oggi, testimoni di una profonda crisi sociale, tra problemi economici e drammatiche migrazioni.