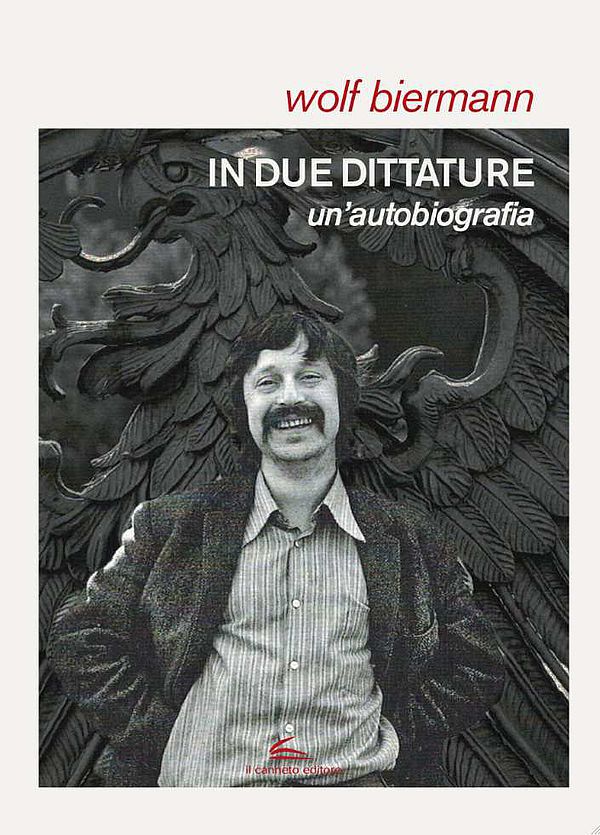Lo scrittore svizzero Christian Kracht si muove nel tempo e nello spazio con grande disinvoltura. E la sua fantasia si affaccia volentieri sulle pagine di altri autori imitando e manipolando con originalità. Il suo primo romanzo, Faserland, del 1995, diventato presto un libro di culto, soprattutto presso i giovani, in una fase di ripresa della letteratura pop, richiamava Bret Easton Ellis, mentre Imperium, la sua opera finora più famosa del 2012, prende a prestito lo stile di Thomas Mann.
Nato a Saanen nel 1966 ma cresciuto in giro per il mondo fra Stati Uniti, Canada e Francia, Kracht è stato corrispondente dall’India per il settimanale tedesco «Der Spiegel», compiendo numerosi viaggi nei paesi asiatici, e più tardi commentatore stabile del quotidiano «FAZ».
Non è del tutto casuale pertanto che anche nel suo ultimo romanzo, I morti, che ora La nave di Teseo pubblica nella bella traduzione di Francesca Gabelli, gli eventi si snodino fra la Svizzera, la Germania nazista e il lontano Giappone con un breve, drammatico epilogo a Hollywood. E anche la dimensione storica si dilata e invita il lettore nella Berlino dei primi anni Trenta quando il cinema sonoro stava ormai prendendo il sopravvento su quello muto. Per di più, il racconto segue la struttura drammaturgia del Teatro-Nō, i suoi tempi di narrazione, che nella prima parte danno rilievo alle esperienze infantili dei due protagonisti, il regista svizzero Nägeli e il funzionario ministeriale Masahiko Amakasu.
Ma Kracht non si lascia sfuggire, in apertura, una sequenza da film dell’orrore: il suicidio rituale di un giovane ufficiale giapponese che voleva punirsi per aver commesso una manchevolezza, ripreso da una cinecamera nascosta. Così il mondo di celluloide inghiotte fin dall’inizio la realtà e sembra preannunciare il vuoto che si nasconde dietro. Poi la storia inizia oscillando fra Berna e Tokyo, fra quel padre svizzero che spesso colpiva il piccolo Emil sul viso perché non mangiava, e quello nipponico, professore di germanistica che traduceva Heine e le suonava a suo figlio finito nel miglior collegio del paese dove subì infinite umiliazioni. Così al termine degli studi non ebbe dubbi: diede fuoco alla scuola e al suo passato osservando soddisfatto da una collinetta il fuoco riparatore. E tuttavia Masahiko era una sorta di genio che a nove anni conosceva già molte lingue, studiava il sanscrito, scriveva complessi algoritmi e componeva musica: un mostro che «faceva accapponare la pelle» persino ai genitori.
Due protagonisti lontani anni luce che Kracht accosta in un plot apparentemente lineare ma ricco di incredibili sorprese. Il regista Nägeli riceve l’incarico dal governo attraverso l’uomo più potente del cinema tedesco, Alfred Hugenberg, proprietario della Universum Film AG, di andare in Giappone a girare un film di propaganda nazista con l’attore Heinz Rühmann. Offerta allettante se si pensa che per la UFA, proprio lì a Berlino, in un primo tempo, lavoravano un po’ tutti, da Lang a Pabst, da Wiene a Sternberg. E in quella grande capitale balzano fuori dal cappello del prestigiatore Kracht, personaggi improbabili: il sociologo e critico Kracauer, amico di Bloch e Benjamin messi al bando in quella nazione «rigida e instabile», e l’ebrea Lotte Eisner, critica cinematografica famosa per le sue stroncature, con i quali Nägeli si ritrova in un teatro di varietà vicino a Nollendorfplatz, dove non mancano Hugenberg e compagni nazisti.
Una kermesse in cui realtà e fantasia si confondono, così come più tardi, in quell’elettrizzante «polifonia della modernità» che è Tokyo, comparirà Charlie Chaplin a un ricevimento della delegazione americana. Un piccolo e simpatico roditore, forse una volpe, pensa il funzionario Amakasu, che intende contrastare il potere di Hollywood, consapevole che «cinepresa e mitragliatrice» siano assai simili, così come, dall’altra parte del globo il collega Hu-genberg sosteneva che il «cinema è la guerra combattuta con altri mezzi».
Masahiko sogna un rilancio del film giapponese e punta, sia pur con scetticismo, le sue carte su quel regista che gli amici nazisti gli hanno mandato e che riuscirà a girare in qualche modo una sua pellicola, che dia forma, per così dire, «a una metafisica del presente, in tutte le sue sfaccettature», riuscendo a estrarla dalle profondità del tempo. Ha un titolo che la dice lunga: I morti, come il romanzo di Kracht, dove i capitoli sembrano sequenze montate per una proiezione.
Con un finale in cui le novità ancora si susseguono incalzando il lettore ora alle prese con l’assassinio del primo ministro Tsuyoshi Inumai (uno dei pochi fatti storici del romanzo), poi con la crisi fra Nägeli e la fidanzata Ida, una giovane attrice sedotta dal fascino dell’intraprendente Amakasu, con il quale s’imbarcherà per l’America in compagnia di Chaplin e del suo factotum giapponese Toraichi Kono.
Ma Kracht ha deciso di stupirci fino in fondo con il suo temperamento manierista, il suo linguaggio ricercato e il suo stile prezioso e un po’ dandy. Come se giocasse rincorrendo immagini sullo schermo che non sono altro che luce in movimento. E nel suo bricolage cerca la luce crepuscolare dell’ispirazione che qui infine s’inabissa nel vuoto e nella morte.
Resta l’immagine un po’ grottesca di Chaplin che, pistola in mano, obbliga Amakasu a gettarsi in mare, e quella, disperata, di Ida, sola e senza prospettive nella mecca del cinema, che scivola giù dalla grande insegna «Hollywoodland» su cui era salita in preda alla disperazione. Per un istante anche il lettore, perplesso e turbato, entra nel regno dei morti, «quel mondo intermedio – confessa Kracht come parlando del proprio romanzo – in cui sogno, film e ricordo si perseguitano a vicenda».