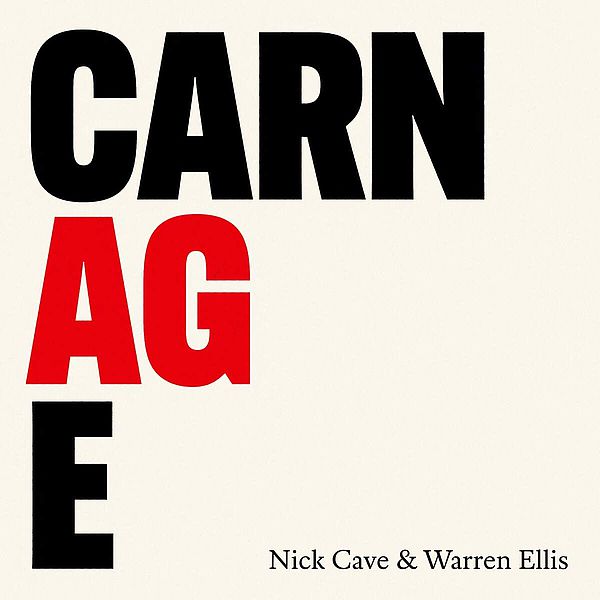Sono passati solo due anni dall’ultimo capolavoro (lo straziante Ghosteen) inciso da Nick Cave con i suoi The Bad Seeds, e non vi è dubbio sul fatto che si sia trattato di anni che hanno causato gravi mutamenti nelle percezioni non solo dell’artista, ma di ogni abitante del pianeta; ed ecco che, sulla scia di una pandemia che ha irrimediabilmente stravolto ogni rapporto umano, Cave effettua oggi un attesissimo ritorno con un album che il lockdown della primavera 2020 ha spinto a realizzare a quattro mani con il solo Warren Ellis – certo il membro dei Bad Seeds a cui l’artista si sente da sempre più affine, tanto da aver firmato insieme a lui svariate colonne sonore, in uno sforzo congiunto di songwriting che, negli ultimi anni, ha dato vita a piccole gemme minimaliste.
Così, rispetto agli exploit con i Bad Seeds al completo, questo Carnage si presenta come un album dal sapore vagamente più sperimentale, in cui sonorità elettroniche e dal gusto quasi industrial si combinano con l’abituale tensione narrativa e l’elettrizzante intensità del cantato e delle liriche di Cave, dando vita a una miscela quasi inquietante, in qualche modo reminiscente di Skeleton Tree (2016). La natura «bouleversant» di Carnage si palesa infatti fin dalla traccia d’apertura, l’intensa Hand of God, così come in Shattered Ground – entrambi pezzi dolenti e aspri, pervasi dal recitativo ipnotico tanto amato da Nick; mentre White Elephant – tipico esempio di brano ossessivo, in cui il cantato inquisitorio di Cave si esprime in frasi dure e taglienti – diventa una sorta di flusso di coscienza in cui l’apparente, illusoria calma conferita dal ritmo cadenzato tradisce la crudezza di liriche che, inaspettatamente, culminano in una coda finale in stile quasi da musical (così fuori posto da risultare ancor più destabilizzante).
Tuttavia, la title track si presenta invece come un brano molto più delicato: un vero capolavoro di ballata, struggente e malinconica, che combina immagini oniriche e realtà terrena; il che sottolinea come l’intero album rappresenti un continuo, altalenante passaggio tra la dolcezza cantautorale del Cave più mistico e introspettivo e l’eterna durezza e asperità della materialità. Basti pensare a un pezzo come Albuquerque, che sembra riportarci all’improvviso all’atroce rimpianto del già citato Ghosteen, concept album incentrato sull’elaborazione della morte del figlio adolescente Arthur: «quest’anno non arriveremo da nessuna parte, tesoro, a meno che io non ti sogni laggiù».
La stessa, reverenziale tensione verso una sorta di forza superiore o divina la ritroviamo nell’evidente sacralità di Lavender Fields, metafora sull’adilà in cui la presenza di coloro che sono passati oltre si fa più vivida che mai, facendo dei «campi di lavanda» una specie di portale tra il mondo dei vivi e quello dei morti – agli occhi di Cave, una semplice stazione d’attesa. Allo stesso tempo, tuttavia, ecco che Balcony Man offre invece la magia di un incontro surreale e inaspettato, eppure toccante nella sua anticonvenzionale comunione d’anime e intenti; e in effetti, alla luce del fatto che il leitmotiv di quest’album è la frase ricorrente «c’è un regno nel cielo», molto di quanto Cave canta assume un significato ancor più suggestivo, al punto da fare del CD una riflessione sull’eterna dicotomia tra carne e spirito.
In effetti, Carnage esemplifica perfettamente l’evoluzione che l’arte di Cave ha mostrato negli ultimi anni: chi lo segue fin dagli esordi sa bene come Nick abbia inaugurato la sua ormai ultraquarantennale carriera con le sfumature post-punk dei The Birthday Party, per poi passare al cantautorato introspettivo «art-folk-rock» di alto livello – in una formula destinata a conservare le medesime sfumature gotiche e l’immaginario disturbante (e sovente un po’ greve) che hanno finito per diventare il marchio di fabbrica dell’artista. Almeno fino al 2019, anno in cui un disco inaspettato come Ghosteen ha rivelato la nuova direzione del songwriting di Nick: dopo la morte di Arthur, il desiderio viscerale di dare un senso alla tragedia si è tradotto nella necessità di traslare i toni inquietanti e nichilisti di un tempo in qualcosa di differente e ben più elevato, al punto che il songwriting di Cave si è ammantato di una metafisicità quasi soprannaturale, toccando vette d’intensità difficilmente raggiungibili; e l’evidente maestria dell’artista australiano ha fatto sì che il passaggio da un universo narrativo all’altro avvenisse in modo assolutamente disinvolto e naturale.
Proprio in questo, in fondo, sta la grandezza di Carnage: nella sua natura sospesa fra due estremi, a cavallo tra il nichilismo gotico di un tempo e le aperture spirituali di oggi, quest’album conduce l’ascoltatore lungo sentieri di raro splendore e intensità, in cui il più lacerante rimpianto lascia il posto a una taciuta meraviglia davanti alle bellezze di cui, nonostante tutto, l’animo umano – con tutto il suo bagaglio di ricordi, sogni, speranze e aneliti – è ancora capace.