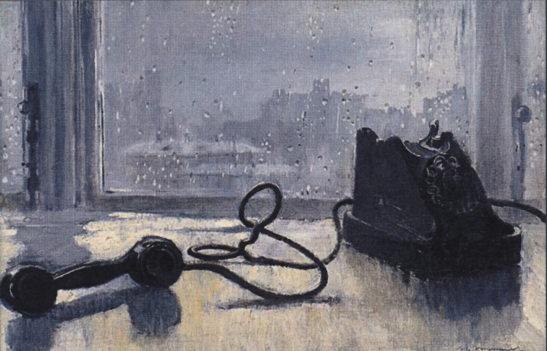Vengo subito a un primo «dunque», come se avessi prima parlato di tanti, tantissimi libri che sembrano dirci: ma leggimi, perché non mi leggi? Il dunque: propongo la lettura di Rachel Polonsky, La lanterna magica di Molotov. Viaggio nella storia della Russia, trad, di Valentina Parisi, Adelphi, Milano, 2014, pp. 434. euro 28: libro che ripaga i soldi spesi.
Vi troverà, il lettore che vuole, ogni tanto, dent per dent, latino interdum, che vuole uscire dai confini nazionali o dai libri «italiani», vi troverà piacere e stimoli vari a «crescere». È un libro che fino dal titolo e sottotitolo ci porta nella Russia, non solo quella della letteratura. Ci sono sì gli scrittori, per molti di noi dal nome nuovo. Il libro della Polonsky è come un romanzo dove però, invece di personaggi inventati, si incontrano scrittori, uomini politici e altri. Insomma, non è libro da riassumere, è libro da (non si prenda in sinistra luce il verbo) «consumare». Di cui nutrirsi. Cominci pure il lettore dalla pagina 162, tre quarti, dove si incontrano, dopo un anche, «Anche i fratelli Valilov…»: Sergej che è fisico e Nikolaj biologo. «Miravano entrambi alla virtù e alla saggezza nella scienza..»
Particolarmente ammirevole è, per me, Nikolaj: pagina 170: «Arrestato nel 1940 (nulla dirò io, di purghe russe), Nikolaj Vavilov fu interrogato in una prigione dell’NKVD a Mosca e tenuto in piedi ininterrottamente per dodici ore, finché non gli si gonfiarono le gambe, tra l’agosto 1940 e il luglio 1941 verrà ascoltato quattrocento volte. Quando le truppe di Hitler si avvicinarono a Mosca fu trasferito nel carcere di Saratov». Lì visse un anno «senza poter fare il bagno, né esercizio fisico, ossia nella “cella della morte” priva di finestre dove pativa la fame – stretta, sovraffollata, posta in un seminterrato, soffocante d’estate, con una lampadina accesa giorno e notte. Vavilov riuscì a portare un po’ di disciplina nelle cose – ricordava un altro recluso. Cercava di tirar su di morale i suoi compagni… aveva organizzato corsi di storia, biologia e industria del legname. Ciascuno di loro faceva lezione a turno. Dovevano parlare a voce bassissima». Prima di morire nel 1943, era nato nel 1887, Nikolaj Vavilov fece in tempo a tenere più di cento ore di lezione ai suoi compagni di cella.
C’è il ritratto di Mosca, la città dove «il cielo sembra non avere mai fine». In questa città, osservò il grande «lettore» tedesco Walter Benjamin, quando vi giunse nel 1926, «In questa città si sente sempre il vasto orizzonte della pianura russa».
Torno alla pagina 162 perché Mosca e la Russia fanno tornare alla memoria un pensiero di Pascal sull’immensità dell’universo «il cui centro è ovunque ma la sua circonferenza da nessuna parte». Cui va aggiunto un pensiero di Platone, secondo il quale se il colore del cielo fosse scarlatto invece che azzurro, «nell’uomo predominerebbe una disposizione d’animo sanguinaria». Segnalerei la commovente «storia» di Varlam Salamov (1907—1982): vedi la pagina 292 e seguenti.
«La sua fanciullezza era trascorsa tra le grida paterne: “Smettila di leggere”; “Posa quel libro”; “Spegni la luce”. Dopo l’assoluta fame di libri sperimentata per decenni nel Gulag, percepiva quella stessa fame come la sua esistenza. Non c’è cosa più dolce, scriveva, della vista di un libro non letto».
«In Cherry-brandy – racconto il cui titolo allude ai versi di Mandel’stam – Salamov immagina il poeta mentre sta per morire di fame nel Gulag. L’uomo che un tempo aveva definito la vita “Un dono prezioso, inalienabile” giace al gelo in una baracca, le dita bianche esangui gonfie per la fame, appoggiate al petto (…) Questo pensiero così acuto e terribile da renderlo disposto a litigare, insultare, battersi, perquisire (se solo ne avesse avuto la forza) evoca altri pensieri ancora (…) l’idea che la sua vita passata sia stata un libro. Quando il poeta mangia la sua ultima razione di pane (“qualcosa di prodigioso, uno dei tanti prodigi di quel luogo”, premendolo con le dita bluastre contro le gengive sanguinanti (…) gli altri prigionieri gli dicono di serbare un po’ di pane per dopo. Le ultime parole del poeta sono: “Dopo quando?”(…)».
Il libro della Polonsky rende un po’ di giustizia a molte vittime delle «purghe», incomparabilmente meglio del mio riassuntino. Nikolaj Vavilov, per concludere con il suo nome, subì, prima della morte, undici mesi di torture. La morte gli era comminata «in un processo farsa durata un minuto, senza testimoni né difensori, per attività sovversiva trockista e spionaggio». (p.160)