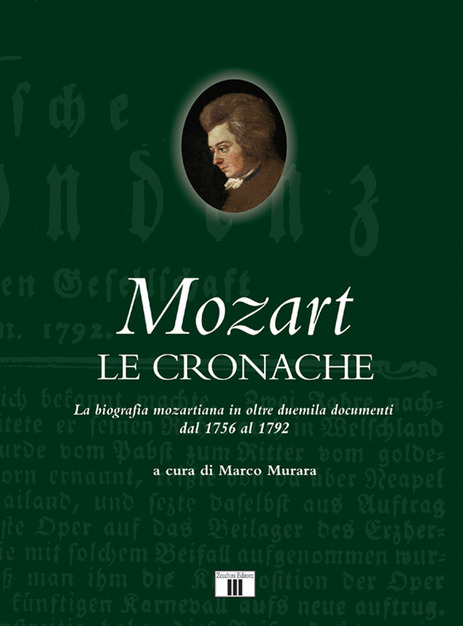Alle 10 e mezza del mattino del 28 gennaio 1756 il registro del Duomo di Salisburgo riportava il battesimo di Johannes Chrysostomus Wolfangus Theophilus, «nato il giorno prima alle ore 8 della sera». Diverrà immortale con il terzo nome in lingua tedesca, Wolfgang, in omaggio al nonno materno, associato al quarto in altra versione latina, Amadeus.
Il registro specifica inoltre: «figlio legittimo dell’illustre signor Leopold Mozart musicista della camera e di Anna Maria Pertl coniugi». Siamo all’alfa di una mole straordinaria di fonti primarie, Mozart – Le cronache (a cura e con note doviziose di Marco Murara), due volumi che presentano per la prima volta in traduzione italiana qualsiasi riferimento al nome sacro di «Mozart» apparso durante la vita del compositore in libri, giornali, diari, appunti di viaggio, lettere, documenti ufficiali, prime edizioni. 2003 documenti che spaziano dalla culla fin oltre la bara, coprendo il periodo delle esequie e della successione ereditaria, con l’inventario dei beni del de cujus, la lista dei libri e delle partiture trovate in casa al momento della morte, il catalogo delle opere redatto dall’autore.
I documenti sono inframmezzati da una cronologia puntuale che li inserisce nel tempo biografico, con i quali si segue passo per passo il quotidiano della famiglia Mozart. Una vita piena di difficoltà, a partire da quelle che assillano il padre Leopold alla nascita del secondogenito non ancora miracolo prodigioso. Leopold chiede al Principe arcivescovo di Salisburgo, suo datore di lavoro, l’esenzione dall’accisa per una caraffa di vino al pasto, «pari a 6 secche all’anno, nonché di condonarmi i 6 fiorini e qualche kreutzer ancora in arretrato da pagare all’ufficio principesco delle accise (…). Gabelle principesche, tasse, imposte, perdite di cambio» riducevano il salario al lumicino.
Si comprende come l’illustre genitore gestisse con lesta disciplina l’inaspettato Dono celeste, organizzando l’ostensione europea dei suoi figli. Nei viaggi che portano Mozart padre e figli dalla sovrana imperatrice Maria Teresa a Vienna, attraverso le corti principesche degli Elettori di Germania, fino alla presenza di Luigi XV a Versailles e di Giorgio III a Londra, Leopold e la sorella Nannerl segnano tutti i luoghi visitati, le case in cui sono ricevuti, i teatri frequentati, i nomi dei musicisti conosciuti e dei viaggiatori con cui hanno condiviso la carrozza, fino alle locande in cui hanno alloggiato, spese e incassi sostenuti incluse.
«Il povero piccolo», scrive nel diario il funzionario di corte Karl von Zizendorf, «suona a meraviglia, è un bambino spiritoso, vivo, affascinante, sua sorella suona in maniera magistrale ed egli la applaude». (13 ottobre 1762). Un altro consigliere, Konrad von Pufendorf, scrive una poesia natalizia augurando al seienne Wolfgang «che il corpo sostenga la forza della tua anima / e che tu non vada, come il bambino di Lubecca, troppo presto nella tomba» (si riferiva a un fanciullo che stupì l’Europa parlando a 10 mesi, leggendo poco dopo, dimostrando una memoria prodigiosa; «morì a soli 4 anni»).
Ogni fase della vita di Mozart viene alla luce, soprattutto quella drammatica presa di coscienza della dura realtà che porterà il Piccolo Orfeo cresciuto ad affrontare l’incomprensione e la noncuranza: ad esempio nell’infelice viaggio in una Parigi interessata solo alle dispute operistiche fra partigiani di Niccolò Piccinni e di Christoph W. Gluck. «Qui per sfondare, bisogna essere astuti, intraprendenti, audaci. Per la sua fortuna vorrei che avesse la metà del suo talento e il doppio di diplomazia (…) qui tutti i ragionamenti sulla musica fanno pietà» (così il diplomatico Friedrich Melchior von Grimm a Leopold Mozart nel 1778).
I documenti parlano chiaro: lo stesso duro pane toccherà a Wolfgang quando deciderà di vivere del proprio lavoro: «arduo non tanto essere padrone del proprio talento ma non avere un pubblico e una società disposti a riconoscerlo e a retribuirlo adeguatamente» e Vienna «non lo farà per Beethoven e non si accorgerà di Schubert», così Angelo Foletto nell’Introduzione a questa formidabile raccolta documentaria che ci svela «le orme ancora calde di un’esistenza camminata anzi, corsa sotto il segno della predestinazione, dell’orgoglio d’artista e della paura di non farcela ad essere degno del proprio talento».
Dopo tanti palpiti, tanto genio, tanta vita, l’inesorabile documento omega: il registro parrocchiale del Duomo di Santo Stefano a Vienna che segnala «un funerale di 3° classe» per Johannes ecc. Mozart, «deceduto per febbre miliaria acuta» a 36 anni. Computi numerici squallidi acclusi: «8 fiorini e 56 kreutzer», per la fossa comune nel cimitero di Sankt Marx; «4 e 36», per il carro funebre.
Chiudono gli atti di suffragio, messe, concerti, adozioni, la pensioncina accordata alla vedova Konstanze dall’imperatore Francesco II, il compianto sparso sulle riviste musicali europee. Dalle ceneri si sprigionava quella «forza produttiva» in cui Goethe riconosceva il genio «capace di presentare cose degne di mostrarsi al cospetto di Dio e della natura e che perciò hanno un seguito duraturo nel tempo»: «tutte le opere di Mozart sono tali», documenti compresi.