Lo chiamavano il «Beckett delle Alpi». Fin dal suo primo romanzo, Gelo (1963), con al centro un anziano pittore confinato in un paesino di montagna e nei labirinti della sua mente allucinata, l’austriaco Thomas Bernhard amava personaggi ossessivi e maniacali per i quali la vita è un’eterna sconfitta e un balbettio inconcludente. E anche il suo esordio teatrale nel 1970 con Una festa per Boris presenta su una scena scarna, quasi metafisica, un interno dove non filtrano voci né presenze esterne e la vita non ha accesso. Da allora in poi romanzi e commedie faranno di Bernhard, nato nel 1931, uno dei più originali scrittori della seconda metà del Novecento.
Sorprende quindi scoprire che la sua attività letteraria iniziò con alcune raccolte di poesia, di cui la prima, Sulla terra e all’inferno (1957), è uscita ora presso l’editore Crocetti nella bella traduzione di Stefano Apostolo e Samir Thabet con una postfazione di Franz Haas. In realtà la poesia fu per lo scrittore non solo un terreno di sperimentazione, ma anche il libero spazio in cui dare forma alla propria percezione dell’esistenza altalenando fra città e campagna, fra le proprie radici e la curiosità verso il mondo, in cui si mescolano disagio e insofferenza e non di rado un opprimente senso di esclusione. Era affascinato dal grande conterraneo Georg Trakl e dal suo accorato espressionismo che rischiò di offuscare la propria immagine della realtà. «Se non avessi mai conosciuto Trakl, – ammise – sarei andato più lontano».
Tuttavia fin da allora la sua impronta era assai personale: versi che ribaltano l’idillio della campagna in cui per alcuni anni aveva vissuto con i nonni materni, un tono incalzante e aggressivo che retoricamente si affida al gioco delle iterazioni; poi una sorta di risentimento quasi cosmico e l’ossessione della morte dietro cui si nasconde forse il destino di quel padre suicida mai conosciuto e la sua stessa malattia polmonare che lo obbligò a lunghe degenze in sanatorio. Da sempre Bernhard si percepiva al centro di una lotta troppo impari – di fronte all’onnipotenza di società e destino – per essere adeguatamente condotta. Per questo più tardi muterà strategia: la sua scrittura ritmica e cadenzata ricca di contrappunti e di tonalità diverse, dal drammatico all’umoristico, riuscirà a rendere più leggere e coinvolgenti le vane farneticazioni dei suoi personaggi.
Ma il giovane poeta non conosce distanza né riparo: viaggia nel regno oscuro del dolore e della morte, si esilia dalla natura («Io sono indegno di questi monti e campanili, / indegno di una singola notte stellata», si legge in Offerta di novembre), percorre città europee – da Vienna a Parigi a Venezia – con lo sguardo di chi rifugge la modernità e non trova quiete, se non, stranamente, nell’accesa spiritualità presente in non pochi componimenti della terza sezione del libro, La notte che mi trafigge il cuore. Qui si legge: «…la mia anima dorme, / e sopra si muove la mano di Dio»: un riposo che lo scrittore abbandona ben presto incalzato dalle sue invettive sul mondo che qui generano immagini stravaganti, una sorta di corpo a corpo con la realtà che s’inabissa nel buio e sotterra speranze.
Bernhard si muove tra la ribellione, anche linguistica, e la ricerca di un riparo affettivo sulla scia delle «profonde orme dei padri» che la sua anima mortale «ripercorre a ritroso». Ma ritrova ben poco al di là del suo furore, la vera energia per contrapporsi al mondo negli anni seguenti. E anche per la madre, una donna dal greve, triste destino, ha parole dolenti: «Tu vieni sempre quando io sono stanco. Ti ripago / della mia vita con la paura».
Quest’inizio letterario consegnato alla poesia (tra il 1957 e il ’63 uscirono altre tre raccolte) sembra già l’epilogo di un’odissea senza futuro. Una vita apparentemente priva di ubi consistam, ma in realtà sempre più sorretta, nel tempo, dal gesto provocatorio e salvifico della scrittura in un incessante monologo sulla follia del mondo.
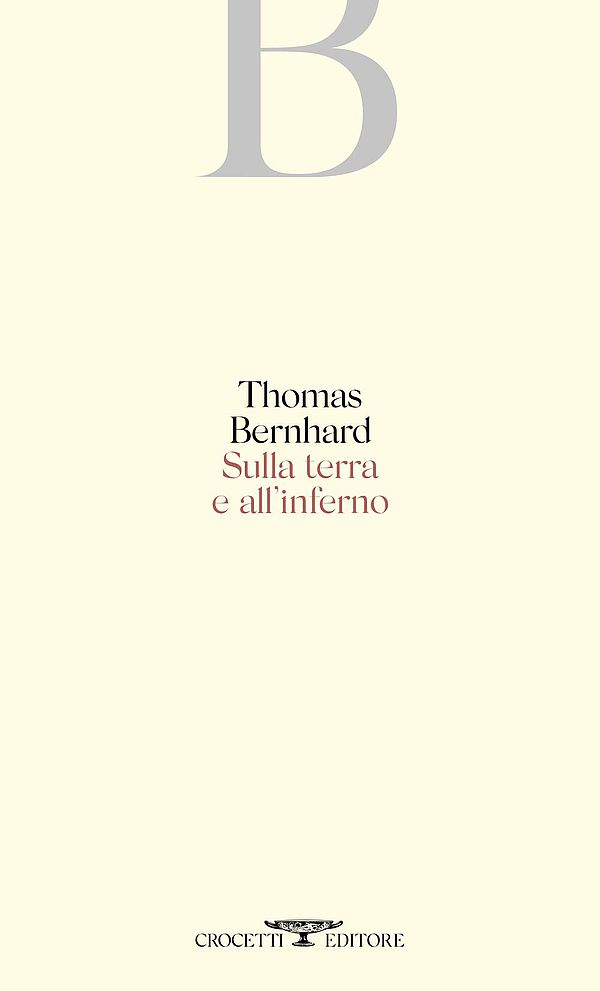
Bibliografia
Thomas Bernhard, Sulla terra e all’inferno, traduzione di Stefano Apostolo e Samir Thabet, Crocetti editore, pagg. 235, € 17
Scrittura liberatoria e salvifica
Crocetti ha da poco pubblicato Sulla terra e all’inferno, raccolta poetica di Thomas Bernhard del 1957
/ 02.11.2020
di Luigi Forte
di Luigi Forte





