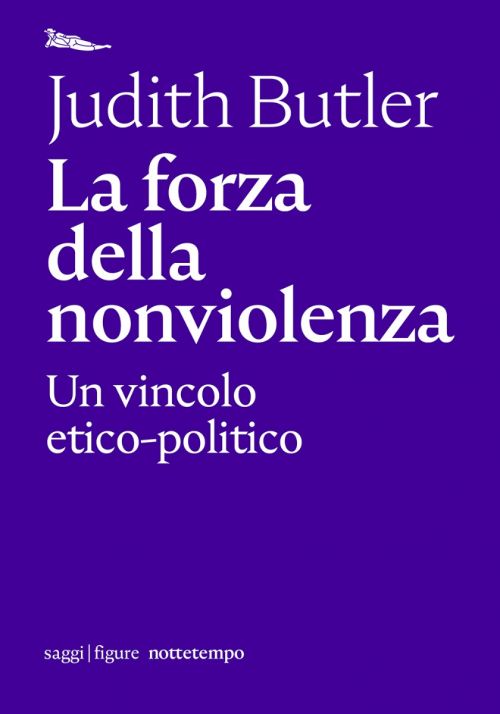In seguito all’attacco a Capitol Hill, una delle critiche mosse da media e opinione pubblica si è incentrata attorno alla differenza di trattamento a stampo razziale: perché la polizia, ci si è chiesti, ha tardato ad agire? E soprattutto come mai nella stessa Washington la reazione di fronte a una manifestazione pacifica di Black Lives Matter non si è fatta attendere, portando all’arresto di 14mila persone? Con questa premessa mi approccio all’ultimo libro della filosofa e femminista americana Judith Butler, La forza della non violenza, pubblicato in Italia da Nottetempo. Un libro più che mai attuale, specie alla luce dei fatti avvenuti a inizio anno negli Stati Uniti. La filosofa apre la trattazione con un quesito: che cos’è la violenza? Come definirla? Esiste una violenza giusta, ineludibile?
Si capisce che le questioni aperte dalle domande siano enormi e che la risposta non sia facile. Potremmo però cominciare con il dire, con Benjamin, che è sempre il Potere a stabilire cosa sia la violenza, a dettarne i contenuti e a perimetrarne la circonferenza. E che lo stesso passaggio dallo stato di natura a quello civile sia sempre non un abbandono della violenza, ma una violenza esso stesso, seppur una violenza, forse, necessaria. Se a stabilire cosa sia la violenza è sempre il Potere, ogni atto contro il Potere stesso e le sue basi sarà catalogato come violenza, mentre ci sarà uno sguardo diverso, più accondiscendente di sicuro, verso le forme di violenza compiute dal Potere stesso. È giusto a questo punto aprire una parentesi: una riflessione interessante che il libro porta in luce sin dalle prime pagine è quella sullo stato di natura, un concetto fumoso, anche se dato per assodato, sul quale conviene soffermarsi un attimo. Da Hobbes in avanti, siamo piuttosto predisposti a prendere come certezza inattaccabile che durante questo mitico stato di natura, gli uomini si aggirassero come monadi, esseri egoistici atti a prendere quanto più possibile per se stessi, pronti a pestare i piedi se non a massacrare il proprio simile, senza mai valutare un orizzonte minimamente comunitario. Siamo proprio sicuri che prima (dello stato di diritto) la vita fra gli esseri umani fosse così orrida? Partendo dal presupposto che l’uomo non inizia il suo percorso nel mondo da adulto, ma da bambino, la sua vita è sin dagli albori caratterizzata dalla dipendenza dagli altri. Perché, quindi, prima dello stato civile queste relazioni di dipendenza reciproca non avrebbero dovuto portare a forme di convivenza pacifiche? Perché si vuole vedere della natura solo il lato egoistico e distruttivo, quando non autodistruttivo?
Un altro punto importante che emerge dalla lettura del testo di Butler, è quello che riguarda l’interconnessione della riflessione sulla violenza e quella sull’uguaglianza. E la filosofa per sviscerare questo tema porta alla luce una tematica nuova, quella della dignità di lutto. Cito: «Ciò su cui vorrei insistere è che le persone possono essere piante, o almeno essere degne di lutto, solo se la loro perdita viene riconosciuta come tale; e la perdita, a sua volta, può essere riconosciuta come tale solo se le condizioni del suo riconoscimento vengono stabilite preventivamente all’interno di un linguaggio, di un canale comunicativo, di un qualche tipo di campo culturale e intersoggettivo». Butler vive una realtà sicuramente più complessa e spietata della nostra, europea, una realtà, quella americana, dove la polizia non esita a sparare a un nero o ad una nera anche se avanzano forme di protesta pacifiche. Abbiamo visto, di recente, l’omicidio di George Floyd: la goccia che ha fatto traboccare l’acqua dal vaso e che ha dato origine al movimento dei Black lives matter. Sembrano cose inaudite, alle nostre latitudini, ma sempre in questi casi è facile sentirsi candidi e proiettare psicanaliticamente la violenza su un altro soggetto. Se pensiamo – e il libro affronta questo tema – alle migliaia di morti in mare, non possiamo non renderci conto che in questo caso la cartina di tornasole suggerita da Butler, ovvero la dignità di lutto, mostra un mondo dove la morte di molte persone vale meno rispetto alla morte di una sola persona che si sente parte della propria comunità. Lasciar morire persone che sperano in un futuro migliore sui fondali marini, non curarsene, addirittura avviare campagne d’odio nei loro confronti, non è una forma di violenza? Perché le nostre vite – e quindi le nostre morti – dovrebbero valere di più? Quesiti su cui è giusto riflettere.