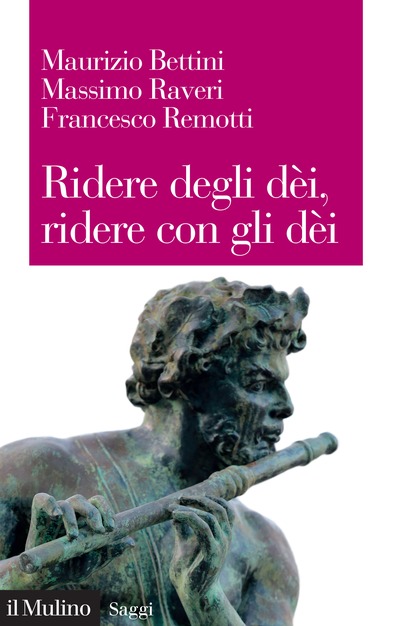«Dio rise: cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha (sette volte), e avendo Dio riso, nacquero i sette dèi che abbracciano il mondo; poiché sono essi che apparirono per primi. Quand’egli scoppiò a ridere, apparve la luce e rischiarò tutto. Scoppiò a ridere per la seconda volta: tutto fu acqua. Al terzo scoppio di risa apparve Ermes. Al quinto il Destino. Al settimo, l’anima».
Più volte in questo Ridere degli dèi, ridere con gli dèi si richiama lo spunto tragico dell’attentato a «Charlie Hebdo» del gennaio 2015. Fin dalle prime righe, come episodio esemplare da cui osservare il rapporto tra sacro e umorismo che anima l’intero libro, e poi nell’immagine dello «scherzo finito in tragedia», che apre il testo centrale di Maurizio Bettini dedicato a Ridere degli dèi nell’antichità classica. La vicenda del terrorismo islamico che irrompe in quel modo assoluto nell’attività del giornale è l’avanguardia estrema e deviata nelle sue conseguenze della tradizionale seppure diversamente misurata incompatibilità tra religioni abramitiche e riso, cui i tre studiosi di questo libro (oltre a Bettini, Massimo Raveri e Francesco Remotti) dedicano sacrosanta attenzione.
Ma le sezioni certamente più sorprendenti a occhi – come si può dire? – giudaico-cristiani riguardano le religioni che invece con il riso hanno un rapporto profondo e fondante, per le quali il ridere degli dèi, tra dèi, con gli dèi e addirittura degli dèi è pratica generale che può stare insieme al rispetto della sacralità. Sono le religioni dell’antichità greca e romana, del buddismo e dei maestri zen, dei sistemi teologici che spesso non hanno un nome ma che le tradizioni di studio (tra esse, parte dell’africanistica antropologica) hanno ormai l’abitudine di classificare nella varietà delle joking religions. Religioni (anche) scherzose, dove il mondo è diverso e «funziona in un altro modo» anche nel rapporto con il divino.
Certo, un libro come questo ha due pregi più vistosi degli altri: quello ovvio della potenziale ricchezza infinita dell’esemplificazione anche curiosa (nelle fonti scritte e in quelle orali) e quello della necessità di porsi di fronte a un ragionamento sull’essenza generale del riso e della comicità, e sul significato di queste pratiche per l’uomo e l’umanità. Per le forme del riso, qualsiasi approccio ha ormai radici teoriche nel mitico saggio di Henry Bergson (Il riso. Saggio sul significato del comico, del 1961), che procede, come tutti gli studi di quell’epoca, per sentenze assertive e negli intenti definitive: così, in linea con la parola del maestro, «il comico non esiste al di fuori di ciò che è propriamente umano».
Per gli esempi, senza andare a cercare in Africa, nel Nord America e in Giappone (lo farà, gli raccomandiamo fortemente di farlo, il lettore di questo libro), le culture classiche sorprendono tra il molto altro per mentalità che emergono con nettezza: prima fra tutte, la similitudine tra dèi e umani nella romanità, dove la divinità è significativamente «vicina» al mondo terreno («con il dio si possono stabilire praticamente tutte le relazioni che sono attive fra gli uomini» e «gli dèi sono esplicitamente considerati “cittadini” a tutti gli effetti», abitano nelle nostre stesse città). Una mescolanza che concede per esempio la demistificazione del divino ma anche un politeismo che risponde alle diverse «porzioni» della condizione umana, a fronte delle quali il credente dispone di altrettante divinità: a ogni tormento, insomma, il suo dio, fino ai più piccoli particolari e quindi all’affollamento.
Nel Parlamento degli dèi di Luciano di Samosata (secondo secolo dopo Cristo), il decreto finale è una specie di misura un po’ «sovranista» con il programma di espellere le «divinità straniere che vi si sono surrettiziamente introdotte, oltretutto riempiendo il cielo di confusione, schiamazzi e lingue barbare». Anche perché «per l’aumento della popolazione celeste, l’ambrosia è venuta a mancare e il nettare ha raggiunto l’incredibile prezzo di una mina alla tazza».