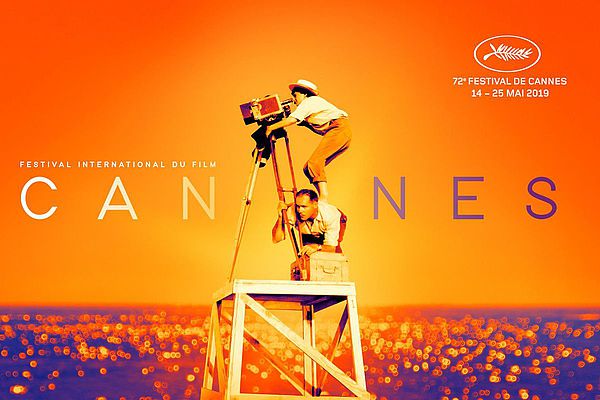Quello di Cannes non è il festival cinematografico più vecchio al mondo. In quanto ad anzianità è preceduto infatti da un dato inamovibile: quel 1932, anno della prima Mostra del Cinema a Venezia. Poi, è vero, la lunga rivalità fra i due maggiori incontri di cinema al mondo è stata compromessa dalle dure vicende storiche affrontate. Il Festival di Cannes avrebbe infatti dovuto inaugurarsi il primo settembre del 1939: ma la dichiarazione di guerra alla Germania del 3 settembre da parte di Francia e Gran Bretagna rimandò la scadenza di quel genere di faccende ad epoche meno tragiche. Al 1946: che vedeva però, in concomitanza, il debutto del Festival di Locarno. E concedeva la possibilità a quest’ultimo di togliersi un capriccio: rivendicare di aver acquisito l’eredità della Rassegna internazionale del Film di… Lugano. Ricca delle sue due edizioni del 1944 e 1945, prima dell’avvenuta cessione alla consorella lacustre della Svizzera Italiana; seguita al rifiuto, in votazione popolare, di proseguire la manifestazione luganese in una struttura open air del Parco Ciani.
A settantaquattro anni di distanza tutto ciò appare simpaticamente folcloristico: e Cannes, nel frattempo, si è involata. Forte di una presenza mediatica e di tappeti rossi ad altri impensabili, di una base logistica e d’accoglienza incomparabile, del sole di maggio sulla Costa Azzurra. E, non da ultimo, dall’ambizione culturale che contraddistingue da sempre il supporto statale francese al cinema. Unico neo il TIFF, la rassegna canadese di Toronto che da qualche anno si è incollata alle date di Venezia in settembre, e qualche pensiero ha iniziato a farselo; meno vincolata com’è dalla sua formula non competitiva.
Rimane Venezia, penalizzata da tutto quanto costituisce la forza di Cannes: ma provvista di recente di un proprio uovo di Colombo. Un calendario (e una libertà rispetto ai condizionamenti in Francia sull’avvento di Netflix) che le permette di anticipare, come una vera e propria testa di ponte, le scelte americane destinate agli Oscar nel marzo seguente.
Essendo a maggio, a Cannes non rimane allora che non ricadere nel cattivo gioco: appoggiandosi ai suoi 40’000 professionisti accreditati, quasi 5’000 giornalisti, 200’000 spettatori, 20’000’000 di euro. Di un budget, che finge però d’ignorare le ricadute indirette che giungono dagli yacht ancorati nella baia come dall’infilata di palazzi cinque stelle affacciati sul Mediterraneo da Montecarlo a Saint-Tropez. L’eventuale corsa ai ripari sembra comunque assicurata dalle premesse del programma: con un equilibrio fra la selezione di grandi nomi (quelli che poi finiscono per indurre una parte degli spettatori a lamentare la presenza dei soliti «abbonati») e le rivelazioni.
L’ultima notizia ha permesso sonni più tranquilli al delegato Thierry Frémaux: 25 anni dopo la Palma d’Oro a Pulp Fiction e al termine di quattro mesi in sala di montaggio, Quentin Tarantino ha confermato la partecipazione di Once Upon a Time... in Hollywood (con Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Brad Pitt e via dicendo), uno dei film più attesi dell’anno. Un’altra Palma, di sei anni fa, per lo splendido La Via d’Adèle, Abdellatif Kechiche si aggrega pure in tempo massimo con il seguito (di quattro ore) del suo ultimo, non sempre impeccabile Mektoub, My Love.
Quella dei «palmati» rimane allora una caratteristica di Cannes: dei 21 film in competizione quest’anno cinque sono di registi che hanno ricevuto una, o addirittura due Palme d’Oro: oltre a Tarantino e Kechiche, i fratelli Dardenne del Belgio (Le Jeune Ahmed), il britannico Ken Loach (Sorry We Missed You) e l’americano Terrence Malick (Une Vie Cachée). Ma addirittura tredici sono le opere selezionate quest’anno firmate da registi abituati alla Competizione: lo spagnolo Pedro Almodòvar, l’americano Jim Jarmusch, l’italiano Marco Bellocchio (con Il traditore, ritratto del pentito Tommaso Buscetta), il sudcoreano Bong Joon-ho, il francese Desplechin (Roubaix), il canadese Xavier Dolan (ritornato a casa, dopo avere girato Mathias et Maxime), il palestinese Elia Suleiman, oltre al brasiliano Kleber Mendonça Filho, autore nel 2016 di un Aquarius da non dimenticare.
Alcuni casi potrebbero quest’anno rivelarsi problematici, primo fra tutti quello di Pedro Almodòvar con il suo Douleur et gloire: fedelissimo oltre ogni encomio a Cannes, questo grande esponente del cinema contemporaneo ha avuto vari riconoscimenti minori, ma mai una Palma d’Oro. Non è il solo, mi direte, ma è scocciante. Anche se successe a dei monumenti come Ingmar Bergman, Hitchcock, Bresson, Godard, Tarkovski o Cimino.
I nomi nuovi? Quello delle quattro realizzatrici, ad esempio, una in più rispetto agli ultimi due anni. Della senegalese Mati Diop vedremo Atlantique, cronaca dell’emigrazione in prospettiva femminile, di Jessica Hausner l’austriaca dell’ottimo Lourdes, si vedrà un film fantastico, di Céline Sciamma, da molti portata alle nuvole, Portrait de la jeune fille en feu. Di un’altra francese, Justine Triet, Sybil.
Talvolta alla fine di Cannes si protesta dicendo che il meglio stava nelle sezioni parallele: ebbene quest’anno spuntano dalla massa Ferrara, Dumont, Honoré, Cavalier, Bernal, Serra, Herzog, Bonello, Zlotowski, Takashi Mijike, Lav Diaz, Guadagnino, Balagov. Ma è proprio sulla qualità di quella «massa» che prospera Cannes.