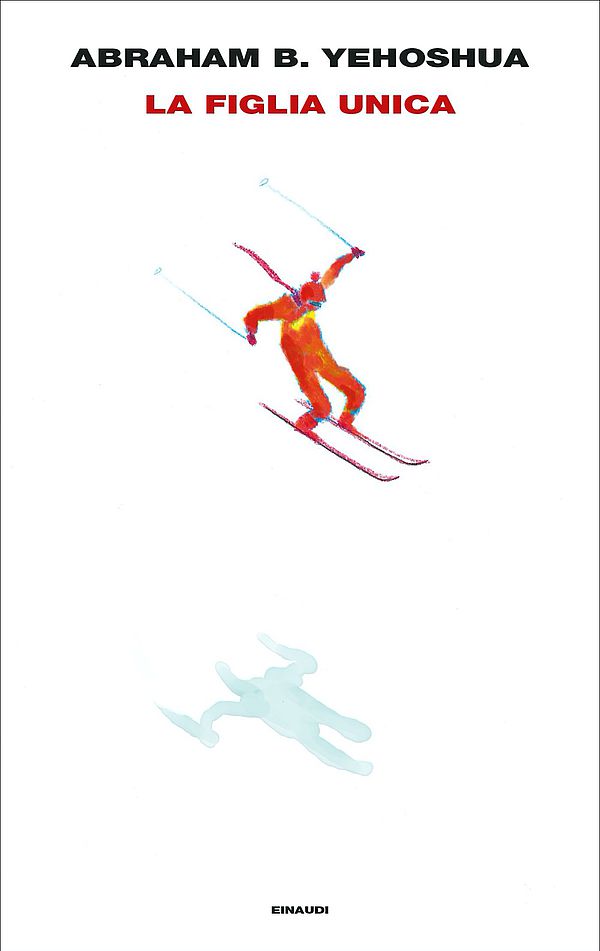Una piccola sciatrice vestita di rosso, tutta sola in mezzo a una pagina bianca come la neve. Così si presenta la copertina dell’ultimo libro di Abraham B. Yehoshua, La figlia unica, che in Israele ha scalato le classifiche in pochi giorni. Protagonista di questa novella ambientata in Italia è la saggia dodicenne Rachele Luzzatto, figlia di un avvocato ebreo benestante e di una cattolica convertita all’ebraismo. Sebbene servita e riverita, Rachele è costretta a trascorrere gran parte del proprio tempo in solitudine, in balia di adulti egoisti che la sballottano da un posto all’altro, incuranti delle sue reali necessità. Sullo sfondo di un dramma universale, quello dell’imminente perdita prematura di un papà affetto da una grave malattia, torna l’indagine delle questioni identitarie da sempre cara a Yehoshua, che questa volta sceglie di affrontare la complessa questione dei matrimoni misti tra ebrei e gentili.
Come ha rivelato recentemente lo scrittore nel corso di una presentazione all’Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv, a ispirare la vicenda della ragazzina cui il padre negò di partecipare alla recita di Natale, vestendo i panni della Madonna, è Sarah Parenzo, giornalista di «Azione», traduttrice e attivista nel campo del sociale. Parenzo, nata a Padova, vive da molti anni in Israele, dove ha conseguito un dottorato di ricerca sulla psicoanalisi e la traduzione culturale. Ma cosa vuole dire, a fronte di un’elaborazione identitaria lunga una vita, ritrovare all’improvviso parti di sé catapultate all’interno di un romanzo? Di questa esperienza, lunga e a tratti complessa, abbiamo parlato con Sarah Parenzo.
Sarah, come hai conosciuto Abraham B. Yehoshua?
È stato nel corso del mio dottorato di ricerca sulla ricezione dell’opera di Yehoshua in Italia presso il Dipartimento di traduzione dell’università di Bar-Ilan. Mi ponevo la domanda di come giustificare il successo della triade Yehoshua-Oz-Grossman e dei prodotti culturali israeliani in generale negli ultimi trent’anni, in un paese, l’Italia, dove sostanzialmente si legge poco. Inoltre mi incuriosiva capire come collocare questa fortuna rispetto alla figura dell’ebreo nell’immaginario collettivo, influenzato dalla tradizione cristiana, da fattori socio-politici e naturalmente anche da autori della Shoah come Primo Levi o americani come Philip Roth.
Per trovare una risposta a questi intriganti interrogativi scelsi tra le altre la strada psicoanalitica, prezioso strumento per l’indagine di possibili meccanismi di identificazione dei lettori nei personaggi di Yehoshua. Nel luglio del 2017 la mia professoressa mi chiese di andare a trovare lo scrittore per intervistarlo. In Israele è facile arrivare alle persone, poiché anche la gente famosa è disponibile e lui, oltre a esserlo, è anche curioso. Forse per questo, quando terminai di porgli le domande riguardanti la tesi, cominciò lui a rivolgerne a me. Qualche giorno dopo lo accompagnai a Gerusalemme a un convegno della Fondazione Segre e quel viaggio fu galeotto, perché durante il tragitto gli raccontai la storia della mia vita.
E cosa catturò la sua attenzione?
Da grande sionista quale è mi chiese subito soddisfatto cosa mi avesse spinto a lasciare l’Italia per fare l’aliya, in ebraico «salita», sinonimo di immigrazione in Israele. Gli raccontai così delle mie «doppie origini» e del mio profondo legame con l’ebraismo anche nella sua accezione osservante e ortodossa. Io allora non lo sapevo, ma quando si narra la propria vita a uno scrittore c’è il rischio che poi questi prenda appunti! Infatti, poco tempo dopo Yehoshua cominciò a scrivere la novella che inizialmente aveva intitolato La madre di Dio.
Cosa pensi che lo abbia affascinato particolarmente della tua storia?
Yehoshua si è sempre occupato di questioni identitarie, della nazione traslata nel singolo. La storia di una bambina proveniente da una famiglia ebraica sterminata dalla Shoah da parte del padre, e non ebraica da parte della madre, gli offriva uno spunto per affrontare temi importanti come la conversione all’ebraismo e soprattutto per parlare dei matrimoni misti, spina nel fianco per un popolo orgoglioso e demograficamente esiguo come quello ebraico. Lo colpì il fatto che mio padre, ebreo laico, mi proibisse categoricamente di entrare in chiesa e di assistere alle celebrazioni cristiane.
Il concetto della separazione è molto radicato nell’ebraismo e ne permea l’identità nel bene e nel male. Ad esempio, all’uscita del sabato, al comparire delle tre stelle, gli ebrei compiono la cerimonia dell’havdalà, i cui versi marcano la separazione tra il sacro e il profano, tra lo Shabàt e i giorni feriali. Un altro esempio è quello della separazione delle stoviglie per la carne da quelle per i latticini, e ancora per i sette giorni della Pasqua. Del resto è anche grazie a essa se il popolo ebraico con le sue tradizioni è sopravvissuto fino a oggi. In gioco, infatti, non vi è solamente l’elemento dell’elezione, ma anche quello della preservazione della minoranza. Yehoshua, dal canto suo, è sempre molto critico nei confronti degli ebrei della diaspora: secondo lui bisogna vivere in Israele, poiché a causa della sua ambigua identità, in bilico tra i concetti di religione ed etnia, l’ebreo errante, senza territorio, suscita sentimenti ambivalenti nelle nazioni-albergo dove cerca ospitalità.
Cosa avviene a livello psicologico quando si vede una parte della propria biografia finire in un’opera letteraria? È una vertigine, una perdita di controllo sulla propria storia, o piuttosto una seduzione, una lusinga? Come è stato l’incontro con il tuo alter ego Rachele?
Direi entrambe le cose. Senz’altro il processo ha richiesto da parte mia una discreta elaborazione. La cosa più sensata sarebbe stata che lo scrittore avesse preso spunto dalla vicenda reale, ma la collocasse molto lontano geograficamente, cambiando sufficientemente i dati anagrafici e non solo. Invece non l’ha fatto. Inizialmente dovetti fare i conti con la difficoltà di vedere la mia storia rielaborata da un altro e romanzata in una chiave spesso in contrasto con il mio sentire. Tuttavia, con il passare del tempo ho imparato a prendere le distanze da Rachele, smettendo di confondermi, o confrontarmi con lei. Non solo, ma ognuno di noi tende ad essere ancorato a una narrativa univoca della propria biografia, con il rischio di recitare sempre lo stesso personaggio, incartandosi in un ruolo predefinito. L’incontro con Rachele ha finito per esercitare su di me un effetto terapeutico, offrendomi l’opportunità di sdrammatizzare, cambiare parte nella commedia della vita e soprattutto di lasciarmi alle spalle dei traumi, consegnandoli alla penna sofisticata di Yehoshua. Inoltre non bisogna dimenticare che la storia parla di un dolore universale, quello di una bambina che si prepara ad affrontare da sola la morte del padre.
Grazie a Rachele ho dovuto fare i conti con il tabù più grande della mia vita, ovvero l’origine non ebraica di mia madre, che ho sempre vissuto in modo estremamente conflittuale, cercando di nasconderla e intrattenendovi in seduta gli psicanalisti di due continenti! Ricordo ad esempio che da piccola, quando entravo nel matroneo della sinagoga, non volevo mai sedermi accanto alla mamma. L’ebraismo non è una religione che fa proselitismo e, sebbene l’istituto della conversione esista, esso è poco praticato e addirittura osteggiato. Inoltre, poiché l’ebraismo si trasmette da parte di madre, le conversioni a scopo di matrimonio, così come quelle dei minori sono molto fragili e più facilmente contestabili da un tribunale rabbinico. L’immigrazione in Israele mi ha senz’altro aiutata nel superare questo irrazionale trauma identitario. Ciò naturalmente non significa che il passaporto israeliano sostituisca un’identità intera, poggiante su secoli di tradizione e osservanza religiosa. Credo che queste siano domande enormi che spesso Yehoshua tende a semplificare.
Inoltre penso che questa ragazzina che cerca giustizia nei testi sacri in lingua ebraica, l’amore per la quale senz’altro ci accomuna, possa essere fonte di ispirazione per chi come me si confronta con l’Israele di oggi e il dramma dell’occupazione.
Nella novella l’elemento cristiano è molto presente. Com’è il tuo rapporto con il cristianesimo?
All’inizio ero turbata dalla predominanza dell’elemento cristiano nel racconto, ma poi ho capito che si trattava di una proiezione di Yehoshua che ha sempre nutrito un marcato interesse per la Chiesa, proiettandovi speranze e fantasie salvifiche. Durante la mia infanzia di ragazzina ebrea in Italia, nel Veneto degli Anni 80, il cattolico rappresentava per me l’altro, ma era un gioco a due. Oggi finalmente anche in Italia i giochi sono a due, tre, quattro, perché le religioni e le identità presenti si sono moltiplicate. Mi auguro che questo abbia portato a una maggiore apertura anche nei confronti di norme e tradizioni di altre culture.
Come ha reagito il tuo entourage nel leggere la novella?
Più di tutti mi ha commosso un vicino di casa che nei personaggi ha riconosciuto i miei nonni materni, entrambi molto sani e preziosi nella mia crescita, meritevoli di avermi trasmesso la capacità di distinguere il bene dal male.
Chi è oggi Yehoshua per te?
Dall’incontro con Avraham è nata una solida collaborazione intellettuale, ma soprattutto un’amicizia profonda. È stato come ritrovare una casa affettuosa e sufficientemente spaziosa da accogliere, senza giudicarle, le mie identità che sono tante e faticose, motivo per cui lui mi chiama «mille feuilles» come il dolce a strati di crema pasticcera. La cosa tragica è che, poco dopo aver cominciato a scrivere la novella, Yehoshua stesso si è ammalato gravemente di tumore e così il dramma di Rachele in qualche modo si ripete e lo spettro della morte torna a incombere turbando le sue già precarie certezze.