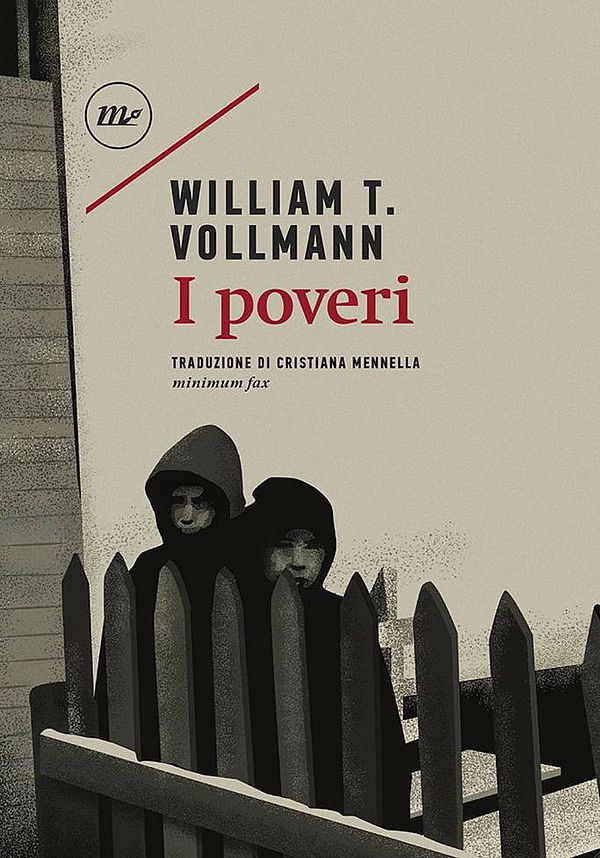Quattro dollari al giorno. È questa la soglia fissata dalle Nazioni Unite per stabilire la povertà di un individuo. Basta davvero questo numero? Sunee vive in Thailandia, fa la donna delle pulizie e guadagna tre dollari e cinquantasei centesimi al giorno. È dunque povera. Ma sua madre, che conduce più o meno la stessa vita, può essere considerata meno povera solo perché ha in casa qualche elettrodomestico? E il pescatore di tonni yemenita che sostiene di non avere bisogno di nulla e si dichiara felice? È povero anche lui? Più o meno di Sunee? Come reagire di fronte a poveri che spiegano la propria condizione riferendosi al karma o ad Allah, se non al fatto che i soldi vanno dove vogliono loro? E come la mettiamo con Montaigne, per il quale vivere con la paura di diventare poveri spesso equivale a vivere con maggiore angoscia degli stessi poveri?
È per tentare una risposta a queste domande che William Vollmann è partito per un viaggio che l’ha portato dalle Filippine al Messico, dal Kenya alla Russia, per incontrare poveri ai quali chiedere essenzialmente due cose: perché sei povero? perché alcuni sono ricchi e alcuni sono poveri? Il risultato è un libro po(n)deroso uscito nel 2007 (ora disponibile anche in italiano grazie alla traduzione approntata da Cristiana Mennella), la cui caratteristica principale risiede nella dialettica, variamente declinata, tra ricerca di senso e ammissione di uno scacco conoscitivo attorno al motivo della povertà.
Ad apparire opaca è anzitutto la posizione dello stesso Vollmann, personaggio e scrittore. È lui a incontrare i poveri e a scegliere la forma dell’intervista, pagandoli perché si raccontino, proprio per evitare l’illusione di una simbiosi comunque impossibile con un mondo cui si può guardare con empatia solo, paradossalmente, affermandone l’alterità. Non a caso il libro è dedicato alle indispensabili figure degli interpreti, quasi che l’autore volesse sottolineare la distanza incolmabile che lo separa dai destini degli intervistati, evitando dunque il limite del volume che Agee ed Evans dedicarono ai poveri della Grande Depressione. Poi c’è il Vollmann scrittore, che si interroga incessantemente sulle possibilità etiche ed estetiche di raccontare una materia così incandescente, dando vita a un testo ibrido, tra inchiesta giornalistica, saggio e racconto, in cui i discorsi diretti (liberi) dei poveri si mescolano alle osservazioni autoriali.
Soprattutto, si tratta di un libro che, pur presentando delle linee interne di continuità, appare fortemente destrutturato. Un racconto scandito in capitoli, sfaccettato e plurale senza tuttavia riuscire a farsi collettivo, proprio a mimare la difficoltà (l’impossibilità?) di una definizione univoca della povertà, ma nel quale tornano a volte gli stessi personaggi (Sunee è spesso la pietra di paragone per descrivere la condizione di altri poveri). Allo stesso modo, all’instancabile indagine condotta corrisponde la pluralità di paratesti sostanzialmente autonomi benché in fitto dialogo tra loro: la tabella delle entrate, le note al testo, le (asistematiche) fonti bibliografiche, fino, soprattutto, al ricco apparato di 128 fotografie scattate dallo stesso Vollmann alle persone incontrate. Materiali che possono essere percorsi autonomamente, tanto da fare de I poveri, in fondo, più libri in uno.
Le teorie (in larga parte marxiste) affermate e le dimensioni riconosciute dalle Nazioni Unite (vita breve, analfabetismo, esclusione, mancanza di strumenti materiali) appaiono allo scrittore sostanzialmente insufficienti per risolvere la povertà («Come viene calcolato l’indice di povertà umana? Lasciamo perdere. Non renderà i poveri più ricchi»), tanto da rendere necessaria la creazione di altre categorie: invisibilità (i disperati della metropolitana di Budapest), deformità (il vecchio senza braccia al passaggio pedonale di Bangkok), indesiderabilità (i poveri sono preziosi solo in caso di necessità immediate, come le guerre, poi di nuovo respinti ai margini), dipendenza, vulnerabilità (la prostituta australiana che tossisce accovacciata sul portone umido dove ha dormito), dolore, torpore (spesso l’unica strategia per sopravvivere), separazione (da cui le proverbiali «guerre tra poveri»).
Vollmann destruttura anche il tempo (che procede con andate e ritorni continui, dal 1992 al 2005) e lo spazio, anche se il libro delinea una sorta di ideale ritorno a casa dell’autore dopo tanto peregrinare: a Sacramento ritrova i poveri che vivono nel parcheggio del suo studio e con i quali, benché incutano paura e vengano pertanto tenuti fuori da una robusta porta blindata, è possibile instaurare un rapporto di umana solidarietà.