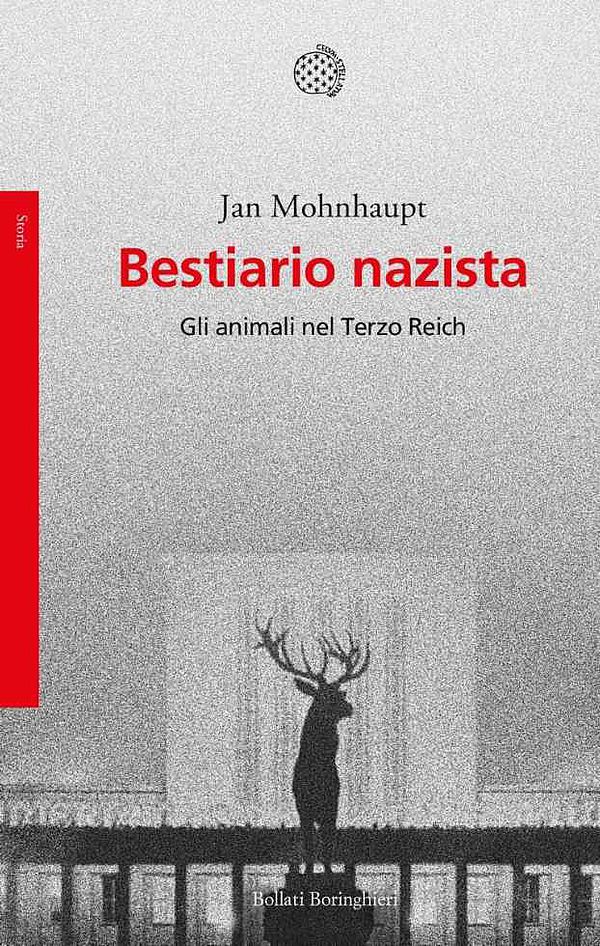C’era una volta, nel cuore della Germania, all’ombra di faggi e querce, un piccolo giardino zoologico abitato da pesci rossi, scimmie, uccelli e orsi. Karl Koch lo aveva pensato e voluto per svagare e intrattenere i suoi sottoposti nelle pause lavorative, quando non erano intenti a sorvegliare i prigionieri. Gli stessi che con le loro mani avevano costruito lo zoo. Il ridente parco si trovava proprio accanto al Campo di concentramento di Buchenwald. Dal crematorio alla gabbia degli orsi c’erano dieci, forse quindici passi. A segnare il confine tra prigionieri e aguzzini, tra sub-umani e umani, un semplice filo spinato vicino al quale Ilse Koch, moglie del comandante, spesso passeggiava con i bambini. Era vietato fare foto ma diverse immagini dell’album di famiglia ritraggono Karl e suo figlio Arwin con gli animali.
Qualche anno più tardi Ilse Koch siederà davanti a un tribunale militare affermando di non essersi mai accorta né del filo spinato né del Campo di concentramento. Era vietato disturbare gli animali o dare da mangiare e chi contravveniva veniva punito. I prigionieri ambivano al posto di guardiano, in particolare faceva gola la gabbia degli orsi. Chi se ne occupava aveva accesso a carne e miele. I meno fortunati venivano, invece, dati in pasto agli orsi. Karl Koch si divertiva ad osservare i plantigradi dilaniare le carni degli ebrei.
Le due cose, la tutela degli animali da un lato, i crimini contro l’umanità dall’altro, non costituivano alcuna contraddizione per i gerarchi nazisti. Rudolf Höß, comandante del Campo di concentramento di Auschwitz, amava i cavalli. Ne cercava la vicinanza quando i quotidiani massacri non gli riuscivano con la solita diligente ubbidienza. Per Heinrich Himmler il rapporto con gli animali dimostrava la superiorità morale del Regime nazista, per Höß era la prova del suo carattere sensibile ed empatico. Hitler smaniava per il pastore tedesco. Blondi, con grande gelosia di Eva Braun, era la sua vera compagna di vita, lo accompagnava persino in limousine.
A Treblinka, invece, tutti conoscevano Barry, un meticcio San Bernardo grande come un vitello. Di buona indole, quando era solo si lasciava accarezzare dai detenuti. Di solito però accompagnava Kurt Franz, vicedirettore del Campo di stermino di Treblinka. Per lui i detenuti non erano persone e quando più ne aveva voglia li faceva azzannare da Barry che fedele obbediva agli ordini. Il primo ministro prussiano Hermann Göring, invece, era un patito della caccia, un insaziabile collezionista di trofei, uno per tutti il cervo rosso Raufbold. Un magnifico esemplare che Göring uccise nella sua riserva di Rominten nel febbraio del 1936 per poi immolarlo in una scultura di bronzo per i posteri. Impazziva per i leoni e i predatori. Famosa è l’immagine che lo ritrae a casa sul divano mentre gioca divertito con Mucki, un cucciolo di leone.
Barry, Blondi, Raufbold, Mucki, Jan Monhaupt ci racconta anche la storia di Siegfried, stallone Trakehner che con milioni di altri cavalli partecipa al Secondo conflitto mondiale e alla campagna in Russia. Avanzano in migliaia, sauri, falbi, morelli e grigi. I Trakehner sono i più nobili, resistenti e veloci tra i purosangue tedeschi. Resistono al caldo come al freddo. Dal 1933 all’inizio della guerra la Wehrmacht decuplica il loro numero. Nel 1941 Siegfried e il suo cavaliere, il soldato di cavalleria Max Kuhnert del Reggimento di fanteria 432, dai monti della Bassa Sassonia si dirigono a Varsavia. Qui nei territori occupati della Polonia sostano per parecchi giorni finché non arriva l’ordine di partire alla volta dell’Unione Sovietica. Tra orrori e fatiche, passano le settimane e i due instaurano un legame molto forte.
Una mattina, alle porte di Mosca, mentre Kuhnert sella il cavallo scoppia una granata. Il boato è tremendo e lo butta a terra. Quando si rialza si avvicina a Siegfried e vede che sotto l’occhio destro c’è una ferita. Si gira verso la tasca della sella per prendere un fazzoletto e dal ventre del suo amico vede zampillare copioso il sangue. Un attimo dopo si accascia a terra e con gli occhi sgranati saluta il suo cavaliere un’ultima volta. Disperato, Kuhnert grida «Alzati, non puoi farmi questo!». Tutto invano, Siegfried il suo protettore, il suo compagno non c’è più. Nelle sue memorie Kuhnert scriverà «per me non era solo un cavallo, era il mio migliore amico».
Nell’ideologia nazionalsocialista tra lupi, grandi felini e predatori, il cavallo, l’unico erbivoro con l’istinto della fuga, ricoprì un ruolo d’eccezione.
Raccontare il nazionalsocialismo attraverso il rapporto che l’élite al comando aveva con gli animali consente di mettere a fuoco l’ideologia nazista da un punto di vista inedito. I nazisti furono all’avanguardia nella tutela dei diritti degli animali tanto che l’attuale sistema di leggi tedesco si basa sulle decisioni di allora. Hermann Göring era contrario a ogni forma di sperimentazione animale, minacciò i vivisezionisti con il Campo di concentramento.
Perché fino ad oggi se n’è parlato poco? Secondo Mieke Roscher dell’Università di Kassel, unica cattedra in Germania per gli Human-Animal-Studies, la ricerca, in particolare quella tedesca, temeva di poter in qualche modo sminuire la portata delle barbarie e di fare un torto alle vittime umane. L’indagine invece evidenzia in quale misura il bagaglio ideologico fosse pericolosamente radicato negli aspetti della vita quotidiana e con quali pesanti influenze sulla società.
La storia degli animali è trasversale a molte delle tematiche note della ricerca sul nazionalsocialismo e ha il pregio di aprire scorci nuovi e mai riduttivi. Lo testimonia il lavoro della storica Maren Möhring da cui emerge che quello che a prima vista può sembrare un pensiero o un atteggiamento paradossale in verità è un puro mezzo di propaganda. Per i nazisti c’erano animali di serie A e di serie B, animali che meritavano di vivere e altri di morire. L’ideologia non distingue tra uomo e animale ma tra vite utili e inutili. Utili in quanto necessarie per il benessere della comunità tedesca, la vittoria della guerra e lo sterminio degli ebrei.
Pensiamo al gatto che per la sua natura vagabonda e indomabile veniva associato agli ebrei e dunque considerato inferiore. Per Victor Klemperer, filologo ebreo, e per sua moglie, il gatto Muschel è il compagno di una vita, l’ultima speranza di un’esistenza stremata nella città di Dresda. Sono stati privati della casa, del lavoro, della dignità, della libertà di uscire la sera e di andare al parco. Vivono nel terrore costante delle perquisizioni della Gestapo. Muschel è tutto ciò che gli resta, il simbolo della resistenza finché nel 1940 il ministero della nutrizione vieta gli animali domestici, misura necessaria per risparmiare viveri per la popolazione.
Grazie a Hitler che non approva perché ritiene che un simile divieto non si addica ad un popolo che ama gli animali, la legge entra in vigore solo per le famiglie e gli individui che non appartengono alla comunità nazionale tedesca. Contorti nel dolore e nel terrore, i coniugi Klemperer salutano Muschel regalandogli un’ultima cena da re. La stessa sorte, qualche tempo dopo, per motivi diversi, toccherà anche a Blondi la cui vita, ritenuta ormai inutile, termina con quella del Führer.
Se Adorno ci dice che il rapporto con gli animali è lo specchio del rapporto dell’uomo con sé stesso e della sua visione del mondo, non vanno lontane nemmeno le parole di Federico il Grande, convinto che gli animali avessero un’anima. Nel 1752 scrive a sua sorella Wilhelmine: «Credo che un uomo capace di mostrare indifferenza verso un animale fedele, non si mostrerà riconoscente nemmeno verso i suoi simili. E nel momento in cui si viene messi dinanzi a una scelta è preferibile mostrarsi sensibili che duri di cuore». Grazie allo storico Jan Monhaupt per averci spiegato la bestialità del potere.