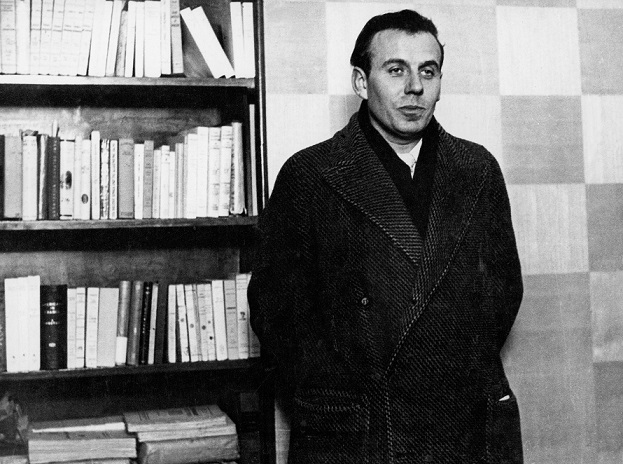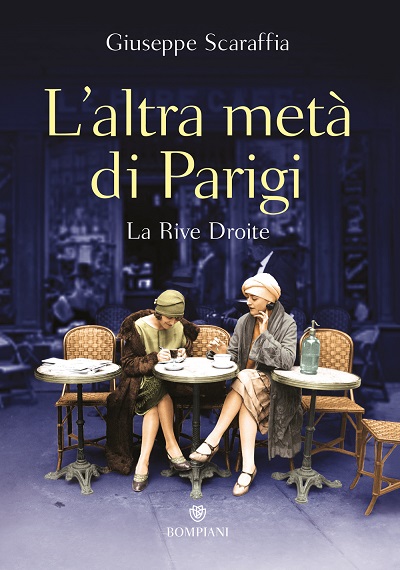Nelle giornate italiane del confinamento più restrittivo (giornate di distanziamento interpersonale; di uscite da casa consentite soltanto per validi e certificabili motivi; di passeggiate e flânerie meramente fantasticate; di suggerimenti per l’impiego dilettevole e utile del tempo forzosamente trascorso tra le pareti domestiche – la compagnia di un libro, ad esempio), uno dei più irresistibili inviti alla lettura, per quanto mi riguarda, è stato il titolo di un recente libro di Giuseppe Scaraffia: L’altra metà di Parigi. La Rive Droite.
In Francia, la Rive Droite è per antonomasia l’area urbana, situata sulla riva destra della Senna, che comprende 12 delle 20 circoscrizioni municipali (arrondissements) in cui è diviso il territorio del comune/dipartimento di Parigi. «Tra il 1919 e il 1939, nel ventennio tra le due guerre mondiali,» scrive Scaraffia all’inizio della sua introduzione «il centro artistico, letterario e mondano di Parigi era la dimenticata Rive Droite. Da sempre si è abituati a identificare Parigi con la Rive Gauche, ma per molto tempo il centro della città è stato, indiscutibilmente, la Rive Droite.»
Coltissima guida e brillante aneddotista, Giuseppe Scaraffia non si è prefisso di ragguagliare il lettore sulla più o meno mutevole fisionomia di strade e piazze della Rive Droite negli anni dell’entre-deux-guerres. Ha voluto, invece, condurlo in alcuni luoghi della zona nord di Parigi (all’aperto e assai più frequentemente al chiuso), che uomini e donne variamente ragguardevoli (in prevalenza artisti) hanno abitato o frequentato nell’arco di un ventennio. Il numero e la varietà di tali luoghi e di tali personaggi sono troppo grandi perché se ne possa dare un’adeguata esemplificazione.
Il libro si compone di 12 sezioni (corrispondenti ai 12 arrondissements della Rive Droite), a cui se ne aggiungono altre due, riguardanti i comuni limitrofi di Neuilly-sur-Seine e Clichy, «quartiere modesto, abitato da operai e impiegati», dove dal 1929 al 1937, al numero 10 di rue Fanny, Louis-Ferdinand Céline (all’anagrafe Louis-Ferdinand Destouches) esercitò la professione di medico «dei poveri» in un ambulatorio che raggiungeva partendo dalla sua abitazione di rue Lepic, nel XVIII arrondissement: «un piccolo appartamento in cima a una serie di scale buie», dove viveva con l’amante Elizabeth Craig e la piccola Colette, avuta da un primo matrimonio, e dove «la camera da letto faceva anche da sala da pranzo».
È probabile che dopo aver attraversato il primo arrondissement, i lettori del libro di Scaraffia si dividano in due gruppi: da un lato quelli che intendono rispettare il percorso stabilito dall’autore (un percorso lungo il quale si incontrano centinaia di personaggi, alcuni dei quali ricompaiono più volte in ambienti e tempi diversi), dall’altro quelli che utilizzano con golosa impazienza l’indice dei nomi posto in appendice, al fine di leggere consecutivamente i passi riguardanti i personaggi che maggiormente li interessano. In tal modo, per fare un esempio, prima di approdare all’ambulatorio di Clichy, possono incontrare in sequenze ravvicinate l’autore del Voyage au bout de la nuit in diversi punti di Parigi: quai de l’Horloge, quai d’Anjou, quai de Bourbon, rue d’Alsace, rue Lepic.
Anche se nel libro di Scaraffia, com’è naturale, hanno maggior rilievo gli artisti e gli intellettuali francesi (Bergson, Proust, Aragon, Breton, Cocteau, Radiguet, Colette, Max Jacob, Eluard, Paul Morand, Gide, Valéry, Bataille, Malraux, Leiris, Sartre, de Beauvoir, Simenon, ecc.), uno spazio notevolissimo è riservato agli artisti e agli intellettuali stranieri (Picasso, Dalí, Buñuel, Foujita, Joyce, Beckett, Pound, Eliot, Benjamin, Majakovskij, Esenin, Marina Cvetaeva, Gertrude Stein, Hemingway, Fitzgerald, Djuna Barnes, Henry Miller, Tristan Tzara, Brancusi, Giacometti, ecc.). Un vivido rilievo lo hanno anche gli esponenti aristocratici e non del bel mondo parigino (alcuni dei quali furono dei generosi e intelligenti mecenati), nonché i più significativi rappresentanti della brigata internazionale di viaggiatori facoltosi giunti a Parigi in cerca di eccitazioni fisiche e culturali.
I personaggi che ho elencato, e altri ancora, agiscono e parlano per lo più all’interno di abitazioni private o locali pubblici di vario tipo: case modeste e palazzi sontuosi (come quello di Charles e Marie-Laure de Noailles), teatri tradizionali (la Comédie Française) e cabaret d’avanguardia (Le Boeuf sur le Toit), bordelli per eterosessuali (Le Chabanais) e bordelli per omosessuali (l’Hôtel Marigny), ristoranti a poco prezzo e ristoranti costosi (come il Prunier e Chez Maxim’s), alberghi economici e alberghi di lusso (come il Ritz e il Majestic). L’elenco potrebbe continuare. Che Scaraffia sia particolarmente attento agli intérieur non stupirà chi ha gustato un suo libro del 1994, Torri d’avorio, accresciuto e ristampato nel 2010, in cui descrive dettagliatamente, e spesso argutamente, gli «interni di scrittori francesi del XIX secolo».