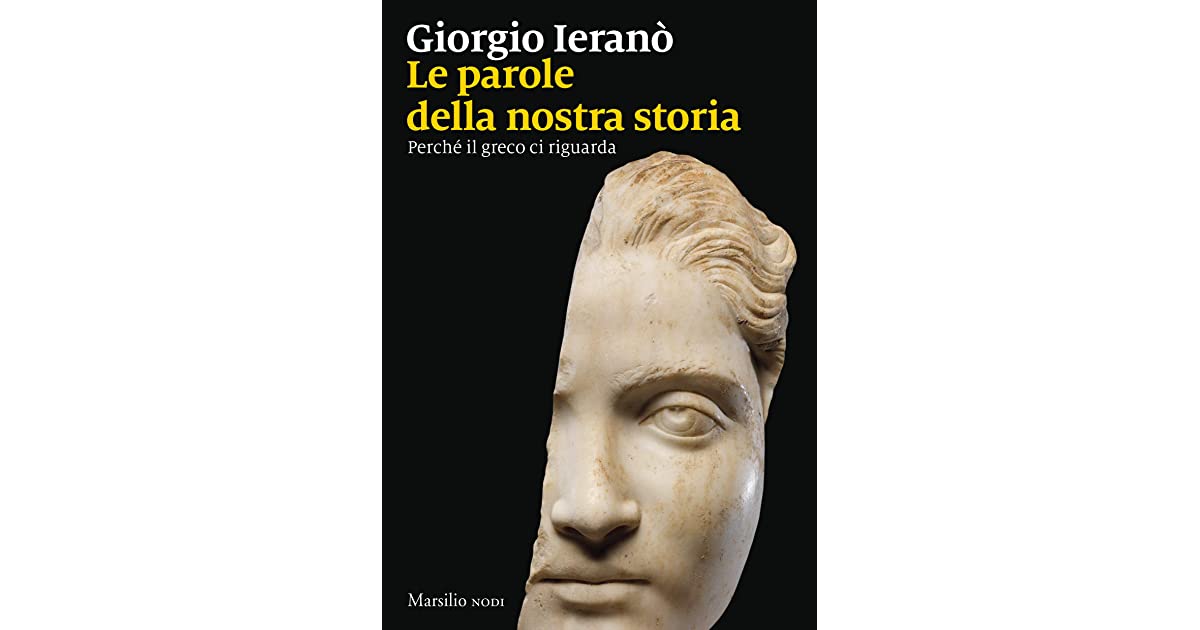Il rapporto tra lingua e storia, tra lingua e società, in buona sostanza tra lingua e cultura corre spesso in due direzioni praticamente opposte: da una parte, dalla parte maggioritaria, si sostiene che la società condizioni la lingua e le parole, le plasmi e le carichi di attualità, diminuendole del superfluo, dell’anacronistico e dello stantio. Sull’altro fronte c’è una serie di teorie affascinanti, secondo le quali sarebbe la lingua ad agire sulla società, informandola di proprie caratteristiche e in un qualche modo piegandola. È la vecchia teoria della relatività linguistica, che ebbe ispiratori importanti poco prima della Seconda guerra mondiale.
Va letto più sulla prospettiva «parole che fanno la storia», anche se le due dimensioni vi sono spesso mescolate, questo Le parole della nostra storia. Perché il greco ci riguarda del grecista Giorgio Ieranò. Il libro entra solo apparentemente nella recente popolare vague di novità editoriali dedicate al profitto che si ricava dallo studio delle lingue antiche; quella serie, ormai numerosa, di testimonianze divulgative dedicate alla loro riscoperta, del tipo «come è bello il latino», «il greco è fantastico», che quasi sovrabbondano nel panorama italiano.
Il giovane canone è ripreso solo in parte, perché in questa occasione sono almeno due gli elementi di novità che rendono la lettura decisamente originale. Uno è il riconoscimento del greco come lingua viva, che senza soluzione di continuità attraversa i millenni e giunge ai nostri giorni con le proprie parole e i loro significati, stravolti ma evocativi di quel mondo e di quei valori tanto da farci assistere ancora oggi a una ben viva fabbrica lessicale (utopia, nostalgia, ecologia, xenofobia, psichedelia sono parole moderne ma forgiate da quell’elemento linguistico). L’altro è una benvenuta relativizzazione del valore dell’etimologia, della ricerca del significato primigenio delle parole. L’invenzione delle parole nuove, l’adattarsi della lingua al tempo e alle culture che passano, «ha portato ad attribuire un senso nuovo a parole antiche. Per questo anche le etimologie servono fino a un certo punto».
Il greco antico ci fornisce parole o pezzi di parole per i concetti centrali della nostra stessa esistenza umana; e se non con parole che la sua lunga onda linguistica ha portato fino a noi è adattando quelle forme e quelle strutture che continuiamo a nominarne di nuovi. È per questo che il libro di Ieranò denomina i suoi capitoli all’insegna di nozioni chiave: l’anima (psiche, eros), il sacro (mistero, mito, chiesa), la cultura (poesia, teatro, scuola), la politica (democrazia, economia), con uno spazio illuminante per la parola che chiude le ultime pagine: epidemia.
Ecco, tra le molte altre, appunto epidemia. La parola non c’è né in Omero, né in Sofocle, né in Tucidide. Il primo usa l’aggettivo epidèmios, nel senso di «indigeno», «circoscritto a un solo luogo», «domestico». Epidemìa è usato per la prima volta tra il quinto e il quarto secolo prima di Cristo con il significato di «malattia di un determinato posto», perché «quando una malattia colpisce un gran numero di individui nello stesso momento bisogna attribuirne la causa a ciò che è più comune, a ciò che utilizziamo di più: quello che respiriamo», si potrebbe aggiungere «quello che respiriamo nel posto dove abitiamo». Poi, molti secoli dopo, nel Settecento, la parola assume finalmente, dopo piccole e successive evoluzioni dell’uso, il significato di «malattia che si diffonde con facilità», per poi approdare, ulteriore tempo dopo, al lessico della medicina. Non sarà infine meno importante alludere al fatto che la stessa pandemia è parola che è stata a lungo estranea a fatti medici.
Insomma, per quali vie le parole si trasformino con il crescere del mondo e, soprattutto, quanto sia spesso sbagliata la diffusa tentazione di trovarne il senso nel significato nucleare, è storia miracolosa. Pregio delle vicende raccontate in questo libro certamente molto bello.
Bibliografia
Giorgio Ieranò, Le parole della nostra storia. Perché il greco ci riguarda, Venezia, Marsilio, 2020.
Parole di ieri
Le voci del greco antico e la loro attualità, in un bel libro sulla storia del lessico e sul rapporto tra lingua e cultura
/ 22.02.2021
di Stefano Vassere
di Stefano Vassere