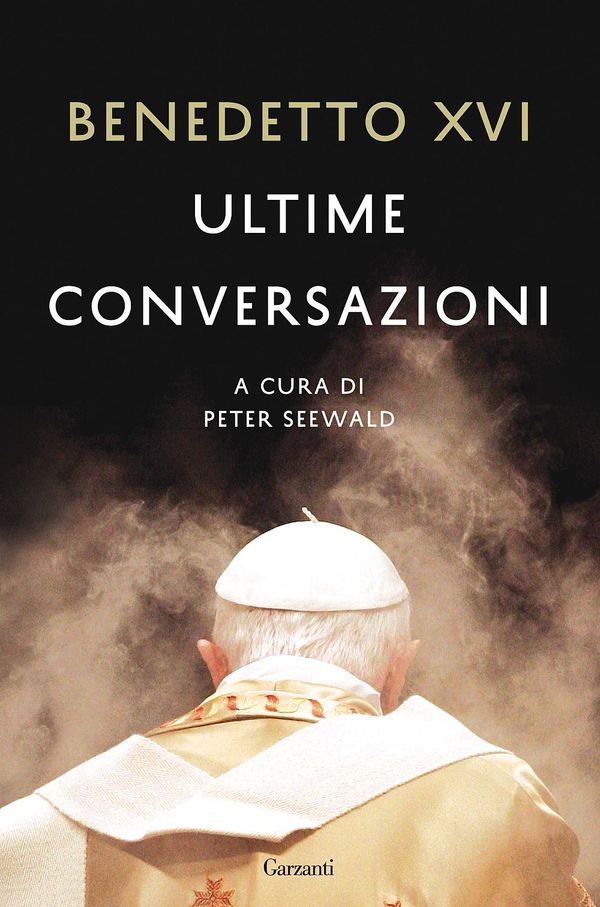L’11 febbraio 2013, lunedì di carnevale, Benedetto XVI, cogliendo di sorpresa il mondo intero, annunciava le dimissioni. Era una primizia: nella millenaria storia del cattolicesimo un papa, lucido e consapevole, lasciava il pontificato di propria volontà. Con ciò si creava la situazione singolare di due papi, uno in pensione, «emerito», e uno in carica, che risiedono, entrambi, entro il recinto del Vaticano, a poche centinaia di metri di distanza, vicini e in pari tempo lontani. Proprio così, Joseph Ratzinger, che dell’«understatement» aveva fatto la sua cifra, si trovò, per forza di cose, sotto la luce di un’esposizione mediatica persino spietata. La dietrologia ha ormai il gioco facile di fronte a una Chiesa in crisi che, nel mondo occidentale, sta perdendo seguito sia come istituzione sia come guida del pensiero. In particolare, il Vaticano, scosso negli ultimi decenni da incidenti d’ordine morale e finanziario, il chiacchierato Vatileaks, doveva offrire il fianco a critiche, insinuazioni, sospetti a non finire. Di cui la partenza del pontefice poteva rappresentare una conseguenza.
In questo clima di curiosità, sconcerto ed equivoci, Benedetto XVI ha voluto far sentire la propria voce per dimostrare che il riserbo non va confuso con l’assenza. E si è affidato a un canale in grado di raggiungere l’opinione pubblica ad ampio raggio, concedendo un’intervista al giornalista bavarese Peter Seewald, che già in passato era riuscito a rendere accessibili i colloqui con un pontefice, dotto per definizione, facendone dei bestseller mondiali. Lo sarà, a maggior ragione, questa pubblicazione Letzte Gespräche, di cui è appena apparsa la traduzione italiana Ultime conversazioni (Garzanti). Sono pagine dalle quali si attendono, innanzitutto, le risposte ai tanti perché provocati dall’inattesa rinuncia. Ma non soltanto. Attraverso questi incontri, complice la comune origine bavarese, Seewald ha saputo ottenere, da un interlocutore in apparenza restìo, testimonianze e confidenze con cui costruire la fisionomia sfaccettata di un personaggio che riserva sorprese.
Il timido Joseph Ratzinger, di modeste origini contadine, diventerà un professore universitario di successo, che fa discutere e lascia il segno come riformatore progressista. La scelta del sacerdozio, come racconta, era appunto legata all’impegno di «rinnovare la teologia e con essa la Chiesa rendendola più viva». Lungo questo percorso si apre al confronto con pensatori anche scomodi, fra i quali Hans Küng, cattolico svizzero dissidente, e il basilese Karl Barth, teologo protestante. Allaccia un intenso rapporto di amicizia con Hans Urs von Balthasar, pure lui svizzero, che diventerà un punto di riferimento importante. Affronta, coinvolto, i «turbolenti» anni 60, quelli del Concilio Vaticano II, da cui uscirono scelte rivoluzionarie, e non soltanto dal profilo liturgico. Si pensi alla svolta nei confronti dell’ebraismo. Sfidando «teologi tedeschi che non mi sono amici», cioè l’ala conservatrice, decide di depurare la preghiera del Venerdì Santo, dalle «improponibili parole: perfidi giudei».
Ratzinger non si sottrae a domande su temi delicati, oggetto di ben note controversie da parte di un’opinione pubblica che non fu tenera con lui. A cominciare da un presunto passato «nazista». Classe 1927, il giovanissimo Joseph fu chiamato, nel ’44, a prestare «il servizio lavorativo obbligatorio» nella Wehrmacht. Nulla da spartire, e lo ribadisce fermamente, con un’adesione all’ideologia nazista che recava un’impronta pagana. Nella sua famiglia, nel suo ambiente, «era chiaro che un religioso doveva essere antinazista. Noi giovani cattolici eravamo minacciati dalla Hitlerjugend». Altro tema, imbarazzante per un tedesco della sua generazione: le persecuzioni subite dagli ebrei. Nella famiglia Ratzinger, ricorda, «si ascoltavano i notiziari stranieri, ma dello sterminio nelle camere a gas non abbiamo mai saputo niente». E doveva poi sollevare un polverone polemico il «discorso di Ratisbona», con l’allusione alla violenza praticata dall’imperatore bizantino Manuele II. Fu considerata un intralcio al dialogo con il mondo musulmano. In proposito, dichiara: «Non avevo valutato bene il significato politico dell’avvenimento».
Dall’ambito politico, di cui questo pontefice fu più osservatore che protagonista, a quello morale, dove invece prese chiaramente posizione. Fu il primo a pronunciare, durante la Via Crucis nel marzo 2005, la storica denuncia: «Quanta sporcizia c’è nella chiesa». Un grido d’allarme nei confronti dello scandalo della pedofilia che diede avvio a un’operazione di «pulizia»: 400 preti rimossi e interventi per punire i colpevoli e tutelare le vittime.
Sono episodi che appartengono a quel processo di «demondizzazione» e autocritica, cui Benedetto XVI si era dedicato, per risvegliare il pensiero cristiano, innescando l’incontro ragione-fede. Un compito tutt’altro che portato a termine. Adesso, da pensionato, avrà più tempo per occuparsene.
Eccoci, dunque, a quell’11 febbraio, quando, nella sala del Concistoro, davanti a una settantina di cardinali, Joseph Ratzinger rese noto il suo ritiro, leggendo un testo in latino: «Perché le cose importanti si fanno in latino». La notizia ebbe un impatto «più forte di quanto avessi pensato». Non era certo un colpo di testa o un’imposizione esterna. Dopo otto anni di pontificato, la decisione era maturata constatando il «declino delle forze, consapevole di non più riuscire a dare molto». Nel ’91 un ictus, nel ’94 un’embolia e la maculopatia che l’aveva reso cieco all’occhio sinistro: incidenti gravi e non esibiti. Diversamente dal predecessore Wojtyla, che aveva mostrato al mondo la propria sofferenza, Ratzinger era convinto che «non si può ripetere una simile esperienza». Tanto più che, oggi, al papa si chiedono prestazioni faticose: viaggi in paesi lontani, incontri con politici, grandi folle in piazza. Esigenze a cui papa Francesco, sembra rispondere istintivamente.
Da bravo giornalista, Seewald rivolge al suo interlocutore una domanda quasi tranello: «Il suo successore non è forse troppo impetuoso, eccentrico?». Ratzinger replica con accortezza: «Ognuno deve avere il proprio temperamento. Uno magari un po’ riservato, un altro più dinamico. Trovo positivo che sia così diretto con gli altri. Mi chiedo quanto potrà andare avanti. Per stringere, ogni mercoledì, centinaia di mani ci vuole molta forza…» Del resto, anche papa Wojtyla gli era parso instancabile. Durante una visita a Monaco, Joseph Ratzinger, allora arcivescovo, gli propose una sosta, e si sentì rispondere «Per riposarmi ho tutta l’eternità».
C’è, poi, il Ratzinger privato. Ama, come si sapeva, Mozart, Bach, la pittura olandese, si scopre che ha letto Hesse e persino Sartre, «Era uno che bisognava leggere per conoscere il mondo attuale». Si è commosso incontrando Vaclav Havel, vittima del marxismo, ma anche Fidel Castro, che gli chiese i suoi libri. Considera Giorgio Napoletano un autentico amico.
Infine, il papa nella quotidianità, con vezzi e abitudini: dorme otto ore filate, scrive con la matita, detesta la moquette e le cianfrusaglie, comprese quelle a uso devozionale: «Un vero kitsch». E riconosce il suo il punto debole: «Non avevo abbastanza potenza nella voce per rendere il discorso più penetrante e umano possibile». Nell’era della comunicazione, handicap penalizzante «per un papa che deve parlare così tanto e spesso: rischia di essere travolto».