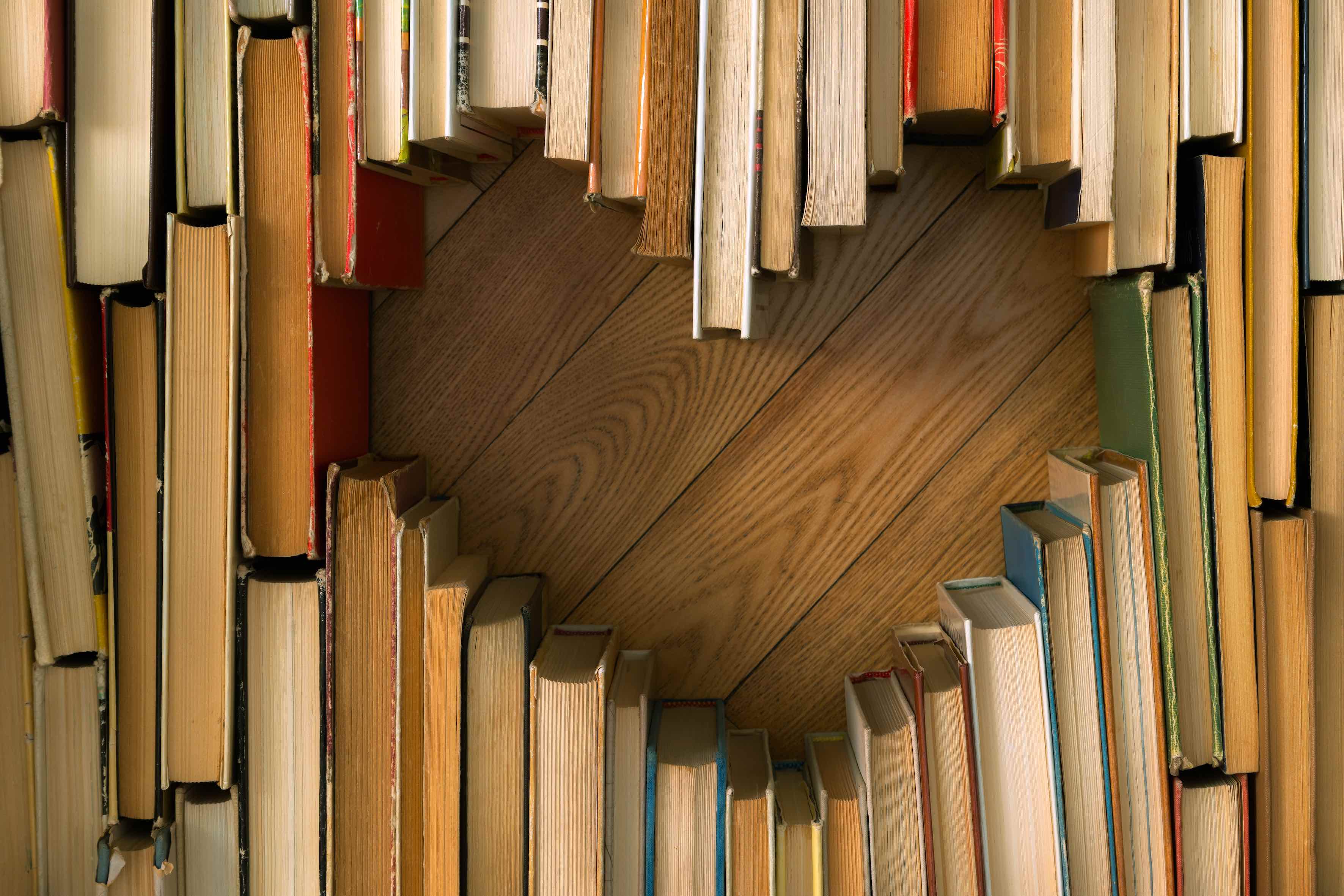È abbastanza bizzarro (o forse, come credo, non lo è per nulla) che due romanzi d’amore usciti di recente e a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, pur diversissimi tra loro, trovino un punto di contatto tra i versi dei nostri poeti delle Origini. Quasi a suggerire che sull’argomento, nella sua essenza più profonda, tutto sia già stato detto e che ora non possiamo che assistere a più o meno nobili variazioni sul tema.
I due romanzi in questione (non eccelsi, va detto subito), che vale la pena di mettere in relazione tra loro anche solo per dare una minimissima idea di ciò di cui parlano oggi gli scrittori quando parlano d’amore, sono Il Giardino degli Aranci di Dario Voltolini e Ragazza senza prefazione di Luca Tosi. Il primo racconta la vicenda di Nino Nino, così chiamato perché, onomatopeicamente, da piccolo imitava la sirena dell’ambulanza correndo in spiaggia (“Niiino Niiino!”). Ormai adulto e sposato, ritrova Luciana, il grande e irrealizzato amore dei tempi del liceo, a cui finalmente chiedere i motivi di quel rifiuto. Nel secondo, l’io narrante e ventisettenne Marcello Travaglini rimugina a distanza di qualche mese sulla notte trascorsa con un’anonima Lei, studentessa universitaria, che sul più bello, quando i due già sono a letto insieme, si tira indietro spezzando l’incantesimo.
Libri diversi, dunque, anzitutto per l’età dei protagonisti (e degli autori: Voltolini è del 1959, Tosi del 1990) e per la distanza temporale dei fatti rievocati: aspetti, questi, che determinano a loro volta le differenze tra gli orizzonti di riferimento dei due personaggi e tra gli sguardi con i quali indagano le proprie esistenze, oltre, soprattutto, a quelle tra le tessiture stilistiche dei due testi. Se per Marcello la domanda cruciale è «Lei mi vorrebbe?», per Nino Nino è «Perché Luciana non mi ha voluto?». Da una parte, dunque, la volontà di capire ciò che è stato per prevedere ciò che forse sarà; dall’altra, l’occasione per il bilancio di un’intera vita sentimentale alla luce di quel desiderio infranto. Nino Nino è un architetto che vive con moglie e figli e che ritrova Luciana nella Roma rarefatta e fuori dal tempo del Giardino degli Aranci, sull’Aventino; Marcello un disoccupato costretto (nonostante un “master in Business & Management”) a vivere con i propri genitori, e che osserva la sua Santarcangelo di Romagna sacrificare angoli di poesia a bar per l’aperitivo sempre più infighettati. Voltolini offre pagine dallo stile più compassato e ambizioso (ma con qualche caduta: «Guidava in automatico, scioltamente, e riandava dal passato al presente come una pallina tra Federer e Nadal»; o qualche velleitarismo: «Allora c’erano un paio di striminziti fatti, soggiogati dalla modalità tracimante e priva di qualunque strategia o esperienza con cui Nino Nino le si manifestava carico di disegni o altre cose in quei lontani intervalli lunghi»). Tosi esordisce con un romanzo più scanzonato, dalla lingua sintatticamente e lessicalmente modellata sul dialetto romagnolo, in cui l’ironia dei toni è in realtà lo schermo col quale il protagonista si protegge da un male di vivere che altrimenti rischierebbe di sopraffarlo («Però, insomma, campare è già complicato così. Se ci mettiamo anche a separare corpo e spirito, si fa complicatissima, mi sembra»).
Un meccanismo di difesa possibile anche attraverso la fuga nella letteratura, come peraltro attesta già il titolo: «Io, mi sembra, quando leggo, sono uguale a com’ero quella sera, mentre stavo a sentire Lei. Però c’è una cosa a volte nei libri che le ragazze non hanno, Lei di sicuro non ce l’aveva: la prefazione. Quelle frasi che ti avvisano di un po’ di cose in anticipo, così scegli se andare avanti a leggere, o cambiare libro».
Ora, a parte il fatto che entrambi i testi sono costruiti sulla vicenda breve di una passeggiata (per le vie di Santarcangelo per Marcello, verso il Giardino degli Aranci per Nino Nino) su cui si innestano gli archi analettici attraverso i quali sono riconvocate le due figure femminili, è soprattutto la fenomenologia dell’innamoramento ad accomunare romanzi tanto diversi.
Per i due protagonisti si tratta di un istante magico e irripetibile che scaturisce dalla visione dell’amata, secondo la meccanica ben indagata da Giacomo da Lentini («e li occhi ’n prima generan l’amore») e poi adottata per secoli dai nostri maggiori lirici. Luciana appare a Nino Nino, quando questi la va a cercare durante gli intervalli al liceo, stilnovisticamente avvolta di luce («la luce di quel sole», che «investe fino a spettinare i capelli») e accompagnata da “un coro di beatitudine». Una presenza capace, secondo la lezione di Petrarca («i’ che l’ésca amorosa al petto avea, / qual meraviglia se di sùbito arsi?»), di innescare il potenziale di innamoramento presente nell’uomo: «Luciana era il primo essere vivente a far detonare in questo modo intenzionalmente direzionato la carica interna di Nino Nino». Mentre Marcello capisce come tutto ormai prenda definizione da Lei: «Poco dopo si era slacciata il cappotto e l’aveva sfilato: sotto c’aveva un vestito nero, con due bande sul petto, una rosa e l’altra arancione. Ancora adesso, quando vedo il rosa o l’arancione, in giro, sulle cose, mi rimbalza in testa il suo vestito. Come se anche il rosa e l’arancione fossero colori suoi, di Lei, prestati alle cose». Con una dinamica, quindi, non dissimile da quel che si legge in Cavalcanti («ch’a le’ s’inchin’ ogni gentil vertute / e la beltate per sua dea la mostra»), per cui le categorie della conoscenza vengono superate dall’oggetto da rappresentare. In entrambi i testi, inoltre, si tratta di donne davanti alle quali assumere una posizione di vassallaggio e alle quali offrire un dono (i propri disegni per Nino Nino, in altri tempi; più modernamente, il biglietto per un concerto di voci bulgare a Venezia nel caso di Marcello), e ciò, in una sorta di rivisitazione della dantesca poetica della loda, indipendentemente dall’esito dell’omaggio: «Il piacere estremo che lui provava in presenza di Luciana non lasciava spazio a nient’altro, nemmeno all’eventuale piacere o non piacere provato da lei nei suoi confronti. Erano questioni che non c’entravano niente». Donne che difatti non si concedono, se non a un rivale (qui, due amici dei protagonisti), e che dettano i ritmi e le regole del corteggiamento, icasticamente fissate nel momento in cui uno spaesato Marcello lascia che sia Lei a scegliere la strada nel labirinto delle calli che portano alle Fenice.
Soprattutto, però, in entrambi i testi l’innamoramento permette l’accesso a una forma di conoscenza ulteriore, capace di svelare i significati più inattingibili del Mondo. Dopo l’apparizione di Luciana, «Nino Nino si era trovato a ‘vedere’ i teoremi di geometria che la professoressa spiegava» (e pure a declamarli ad alta voce, come un posseduto, alzandosi in piedi durante le lezioni, tra lo sconcerto dei compagni). Mentre per Marcello, dopo ogni incontro con Lei, «era come se la realtà diventasse più reale. I dettagli delle cose, i colori, gli odori gli si incidevano a caldo nella memoria».
I nostri Poeti avevano già capito tutto.