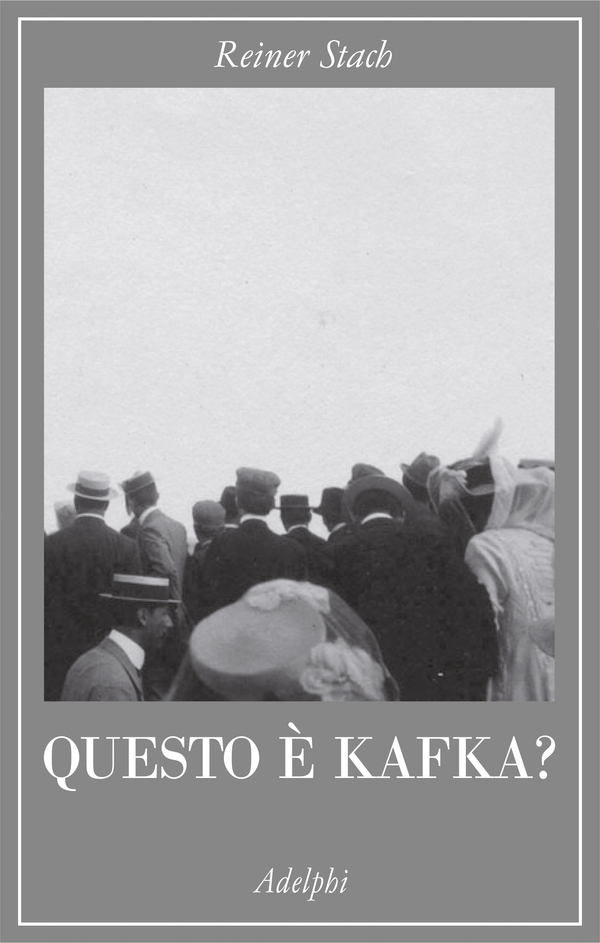Abbiamo cominciato a guardare Franz Kafka con occhi diversi dopo un’intervista a Claudio Magris, parecchi anni fa. Parlando dei critici – e del loro accanirsi su dettagli non sempre fondamentali – fece l’esempio di Odradek. Non sforzate la memoria (che oggi si traduce «non cercate su google»): è la minuscola creatura immaginaria, simile a un rocchetto di filo, che parla con voce paragonabile «al fruscio delle foglie cadute» nel racconto Il cruccio del padre di famiglia (la raccolta era intitolata Un medico di campagna). Da dove verrà il nome? E cosa vorrà mai dire? Niente, vuole dire. Kafka aveva letto il nome sul serbatoio di una motocicletta.
Poi si scoprì che la foto – mostrava la scritta Odradek sul serbatoio di una moto dell’epoca – era lo scherzo di un critico, perpetrato ai danni dei colleghi che cercavano complicate etimologie e legami con l’ebraismo. Morale: non soltanto i testi di Kafka furono accolti dai primi lettori – accadde con Il processo – come storie comiche. Non solo questa lettura è propugnata da Milan Kundera e Roman Polanski, che conoscono bene l’est europeo. Neanche i suoi critici hanno verso di lui il timore reverenziale esibito dai lettori che dicono «kafkiano» quando perdono il treno. L’amico Max Brod, oltre a descrivere Kafka come una persona che teneva l’ironia in massimo conto, contribuì con una sua gag: avrebbe dovuto bruciare i manoscritti, se ne guardò bene.
Reiner Stach, che ha dedicato a Franz Kafka una biografia in tre volumi uscita tra il 2002 e il 2014, non fa eccezione. La sua «corda pazza» gli ha fatto comporre – con i resti di quel lavoro, diremmo, sennonché i resti sono molto più interessanti per chi ama leggere e ha finito con gli esami universitari – un magnifico album appena uscito da Adelphi con il titolo Questo è Kafka?. Sono 99 momenti, raccontati con le parole di Kafka medesimo o dagli amici, i conoscenti, le fidanzate. 99 «reperti», come vengono chiamati nel risvolto copertina: tutti insieme compongono il ritratto di uno scrittore niente affatto triste, musone, preoccupato per le sorti dell’umanità.
Giocava al casinò (anche a Lucerna, perdendo con Max Brod i soldi della cassa comune). Frequentava i bordelli, barava agli esami di maturità, sputava dal balcone, beveva birra, cantava canzonette, falsificava firme, diceva molte bugie, guardava Louis Blériot esibirsi con il suo aeroplanino al campo d’aviazione di Montichiari, poco lontano da Brescia. E non teneva in ordine la scrivania. «Mi sono reso conto che non ci si può combinare nulla di buono» scrive. Segue catalogo: «opuscoli, vecchi giornali, cataloghi, cartoline, lettere, in parte stracciate in parte aperte, quasi a formare una scalinata». Mica è finita: «lo specchio pronto per la rasatura, la spazzola per i vestiti con le setole all’ingiù, il portamonete aperto, il mazzo di chiavi, la cravatta che cinge ancora in parte il solino smesso, vecchie carte che da tempo avrei buttato via, se avessi un cestino, matite con le punte spezzate, una scatola di fiammiferi vuota, bottoni, lamette da rasoio consunte…»
«A clean desk is the sign of a sick mind» – dietro un tavolo in ordine c’è una mente malata: sta scritto sulle tazze e sulle magliette, i disordinati se ne fanno un vanto. Kafka invece se ne fa un cruccio. Figuriamoci quando nel 1910 riceve da un lettore, tale Siegfried Wolff, una lettera di protesta. «Lei mi ha reso molto infelice» – è l’esordio. Il poveretto aveva comprato una copia di La metamorfosi per donarla alla cugina. La cugina aveva letto senza capire nulla, e non ci aveva cavato granché neppure la madre della suddetta cugina, a cui il racconto era stato dato in esame.
Fu chiesto un parere a un’altra cugina: neppure lei cavò lo scarafaggio dal buco. Disperate, le femmine chiedono lumi al maschio laureato, nonché guerriero («Ho affrontato per mesi in trincea i russi senza battere ciglio»). Il quale – preoccupato per la propria reputazione – chiede aiuto allo Scrittore: «Mi dica dunque, per favore, quale costrutto mia cugina debba ricavare dalla Metamorfosi».
Purtroppo non esiste risposta alla missiva. Come non c’è certezza sul colore degli occhi di Franz Kafka, discussi a pagina 54: chi dice grigi, chi azzurri, chi «scuri». È certo invece che Kafka facesse ginnastica e meditazione, ogni giorno, seguendo il metodo Müller. Era costui un guru del primo Novecento che prometteva miracoli con quindici minuti di esercizi giornalieri. 400 mila copie vendute del manuale ginnico nell’edizione tedesca, e 24 traduzioni, dimostrano che neppure il salutismo l’abbiamo inventato noi.