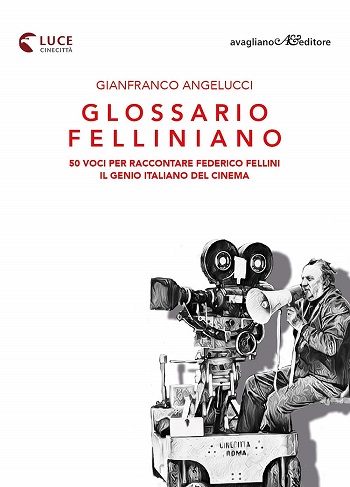Se in tempi di pandemia vi siete convinti della necessità di ripensare il vostro stile di vita e le vostre priorità, non perdetevi il capolavoro distopico GRM. Brainfuck (2019, Kiepenheuer & Witsch) valso a Sibylle Berg tre premi importanti: il Bertolt-Brecht-Preis 2020, lo Schweizer Buchpreis 2019 e il Grand Prix Literatur ricevuto proprio poche settimane fa. Riguardo al primo, nel motivare la scelta, la giuria ha colto in pieno le peculiarità della cifra stilistica della scrittrice weimariana cresciuta nella ex DDR e da anni di casa a Zurigo: «Sibylle Berg è una virtuosa della freddezza e della chiarezza letteraria, una maestra dello sguardo sobrio e dell’analisi disillusa».
Il suo cinismo e la sua violenza lessicale ricca di anglismi (Fucking Rochdale) e intercalari (dito per dire idem), la sua scrittura asciutta che va sempre dritta al punto, l’anonima schedatura dei personaggi, non lasciano scampo: come in una serie TV di Netflix (e penso in particolare a Person of Interest), un frame via l’altro, il destino di quattro bambini della periferia inglese di Rochdale ci colpisce con la forza di un treno in corsa. Attraverso le storie di Don, Peter, Hannah e Karen, Sibylle Berg ci dice come sarà il nostro prossimo futuro e, vi assicuro, non è divertente né rassicurante. Non per nulla il settimanale tedesco «Die Zeit» ha scritto che «il libro è dinamite». Non tanto per gli scenari tecnologici che prospetta ma per il decadimento e l’impoverimento umano che racconta, frutto di un profondo scollamento tra mondo reale e mondo digitale.
In un’Inghilterra post Brexit e neo liberale, l’autrice ci narra di un tempo in cui alla crudeltà umana si aggiunge quella virtuale, in cui la nostalgia per la conoscenza si è trasformata in rabbia per ciò che non si conosce, le teorie del complotto si diffondono a macchia d’olio mentre diviene naturale diffidare dello Stato, della stampa, dei libri, dei vaccini, degli scienziati e delle donne. Un tempo in cui uno Stato sfacciatamente classista riduce le prestazioni sociali al minimo e aumenta il divario sociale e in cui il disprezzo dei capitalisti per i poveri è manifesto e legittimato. Aumentano i senzatetto, i disoccupati, gli invalidi, i malati, i deboli che devono destreggiarsi tra scartoffie burocratiche inverosimili per ottenere un importo minimo e mantenere una dignitosa parvenza. Scompaiono le professioni, crescono la disoccupazione e lo scontento. Cambia la topografia delle città senza uffici postali e senza cinema.
In questo scenario, nella periferia urbana e depressa di Rochdale, Peter, Hannah, Don e Karen crescono a suon di grime, genere musicale inglese tra i più significativi degli ultimi due decenni al quale fa riferimento l’acronomimo GRM nel titolo del libro. Somiglia al rap, ma è più veloce, duro e critico nei confronti della società. Finché un giorno decidono di svoltare e di andare a Londra dove, hanno sentito dire, le cose funzionano. Scoprono che nella capitale del Regno Unito si è cittadini in piena regola soltanto se si permette al governo di impiantarti un microchip sottopelle. Questo dà diritto al reddito di cittadinanza e alla possibilità di accumulare punti, se obbedisci al sistema, di perderli se dissenti. Il cittadino modello, dunque, è dotato di microchip e regala i suoi dati e accumula punti per migliorare la sua condizione sociale. Nel freddo scenario urbano londinese che accoglie le speranze dei giovani a dettare legge e a determinare i confini di azione sono la videosorveglianza, il riconoscimento facciale, gli edifici smart e gli uomini bodycam. Le regole sono semplici, chi non si conforma è fuori dai giochi.
Attenta all’innovazione, convinta che i nerd salveranno il mondo, tra i firmatari della carta dei diritti digitali fondamentali dell’Unione europea, attiva su Twitter con più di 100’000 follower, persona molto riservata e schiva nella vita privata, per Sibylle Berg quella della sorveglianza e del diritto alla privacy è una questone cruciale. Criticando l’ingerenza e l’impatto negativo del digitale sulle qualità umane, l’autrice ricorda Greta Thunberg. In primis ci fa sentire il peso e la responsabilità delle scelte sbagliate, in seconda battuta ci dice che se non comprendiamo gli effetti e i rischi dello strapotere tecnologico e non lo arginiamo per tempo, presto ci sveglieremo in una società disumanizzata, segnata da profonde diseguaglianze sociali, in cui le decisioni le prenderanno macchine e algoritmi e l’intelligenza artificiale mapperà e manipolerà le nostre vite. Noi nel mentre avremo disimparato ad abbracciarci e a toccarci privandoci di quel meraviglioso riverbero che l’incontro fisico accende nelle nostre onde interiori. GRM. Brainfuck ci dice che la digitalizzazione non è stata un bene per le persone. Ci dice che la tecnologia non è democratica ma aiuta a convalidare il potere nelle mani di pochi che manipolano, sorvegliano, diffondono Fake News, pilotano elezioni e consensi a suon di bots.
In questo scenario inquietante e senza speranza i giovani non si fottono il cervello, come dice il titolo, ma compiono un atto rivoluzionario (di nuovo penso a Greta Thunberg e alle migliaia di ragazzi che hanno manifestato per l’ambiente e per le donne in Svizzera lo scorso anno): rifiutano di assoggettarsi al potere della sorveglianza, rifiutano il microchip e sotterrano in una buca i loro smartphone e i loro dispositivi digitali. All’inizio i loro corpi reagiscono come quelli di un tossicodipendente in astinenza poi Hannah trova sollievo nel fare lunghe passeggiate nel verde, Don nell’abbracciare gli alberi.
Nel commentare il suo romanzo l’autrice e drammaturga svizzera dice che la sua non è una visione pessimista o una critica all’innovazione, semplicemente dobbiamo abituarci all’idea che in futuro il mondo sarà diverso, né migliore né peggiore, profondamente diverso.
Ma un piccolo passaggio nostalgico nel libro l’ho trovato e cioè quando il consulente finanziario, che sognava di diventare professore di letteratura inglese e tedesca, in un’eco del passato ricorda le sue letture di Goethe, gli odori e le atmosfere del camino acceso in biblioteca, ricorda un tempo in cui gli acquisti non soddisfacevano bisogni, ma colmavano desideri.