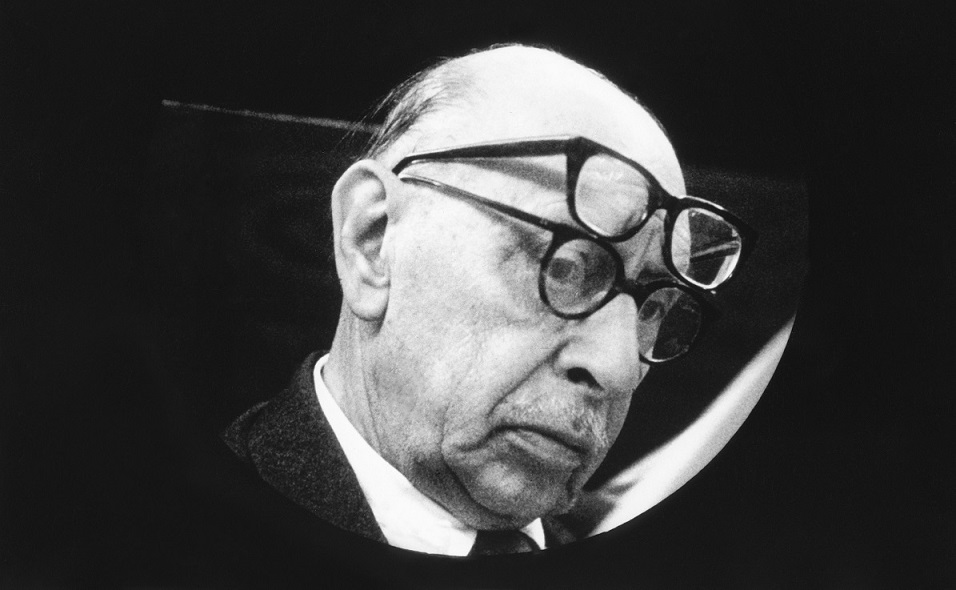Anche se è usanza indicare nel Sacre du Printemps (1913) il punto di volta dello stile stravinskiano e la sua prepotente irruzione nel campo della musica moderna, la posizione di Petruška è quella di un momento chiave altrettanto significativo, considerando il fatto che esso precede l’altro capolavoro di almeno due anni. La data di composizione sarebbe da riportare al 1911, ma in realtà il musicista fu occupato per lungo tempo nella messa a punto di questo balletto iniziato l’anno precedente e interrotto a causa di una grave malattia.
Determinante per la sua realizzazione fu la collaborazione con Sergej Diaghilev, il geniale impresario dei Ballets Russes, il quale si può considerare lo scopritore del giovane Stravinskij, avendo presentato sulle scene parigine L’uccello di fuoco (1910), la sua prima importante composizione. Un anno circa separa tale balletto da Petruška, ma una distanza maggiore separa una concezione musicale legata ancora alla tradizione (l’impianto magniloquente del poema sinfonico russo) dal preannuncio di qualcosa di completamente nuovo.
In ambedue i casi si tratta di balletti ispirati a leggende russe. Sennonché mentre nell’Uccello di fuoco l’elemento magico-fantastico rimane predominante trovando modo di manifestarsi attraverso una strumentazione raffinatissima derivata dal maestro Rimskij-Korsakov e sfumata secondo il gusto impressionistico francese, in Petruška Stravinskij scopre il colore puro ed essenziale, evitando gli impasti timbrici in favore di sonorità palesemente dichiarate, di pennellate crudamente realistiche a volte aspre e sferzanti.
Stravinsky maturò l’idea del balletto mentre stava componendo un pezzo da concerto per pianoforte e orchestra. In quell’occasione – sostenne il musicista – «mi si presentava agli occhi l’immagine di un fantoccio scatenato il quale con cascate di diabolici arpeggi pianistici esaspera la pazienza dell’orchestra. Questa, a sua volta, replica con minacciose fanfare. Segue una tremenda colluttazione che, arrivata al parossismo, termina con l’afflosciamento lamentoso e dolente del povero fantoccio».
La testimonianza è rivelante nel senso di lasciar intendere come dalla fiaba a carattere sereno e ottimistica, preferita dai musicisti dell’Ottocento, si passi con Stravinsky non solo a una fiaba tragica e cruenta, ma che cancella nei personaggi anche i tratti umani. Petruška è per metà uomo e per metà marionetta, i suoi gesti meccanici e la sua espressione sono un seguito di rigide articolazioni. La musica nascente da tale nuova situazione, i gesti sonori fulminei, il ritmo ripetitivo, la tecnica della ripetizione che dissolve il discorso a largo respiro, gli agglomerati dissonanti, liquidano per sempre la possibilità dell’immedesimazione e la stessa dimensione psicologica della vicenda.
L’inquietante dimensione del Sacre, indicata da Theodor W. Adorno come resa senza condizioni dell’individuo alla realtà sociale, se in questi termini può essere accettata, risulta già pienamente presente in Petruška, capace nella musica di eliminare completamente le forze interne al personaggio, cogliendo quelle esterne agenti in modo prescrittivo sugli individui, primo fra tutti il movimento frenetico della piazza del mercato (con un brusio sonoro al limite del rumorismo) e con innesti addirittura naturalistici, quali la citazione di note musiche popolari in combinazione timbrica addirittura naturalistica (intonazioni da organetto di Barberia) riprodotte a volte in rapporto di simultaneità dissonante. Il modello è quello dell’episodio «Limoges» dei Quadri di un’esposizione di Musorgskij, della baruffa delle comari al mercato. Sennonché qui, nella brulicante e pungente orchestrazione, c’è qualcosa di più del riferimento alla dimensione paesana, contadina, dell’immaginario popolare russo.
Come non pensare allora al Manifesto di fondazione del futurismo, lanciato da Filippo Tommaso Marinetti dalle colonne del «Figaro» il 20 febbraio 1909, in cui si proclamava: «Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne: canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violenti lune elettriche».
Replicato nello specifico manifesto intitolato La musica futurista e firmato da Francesco Balilla Pratella l’11 marzo 1911 («Dare l’anima musicale alle folle, dei grandi cantieri industriali, dei treni, dei transatlantici, delle corazzate, delle automobili e degli aeroplani») non sfuggirà la cronologia che coglie questo evento esattamente parallelo all’apparizione di Petruška, il quale, in assenza di convincenti e valide realizzazioni concrete dei futuristi italiani in campo musicale, incarna quindi (e per primo) l’espressione dell’impersonale realtà urbana del 1900 diventata il modello musicale prevalente nell’avanguardia degli anni Venti. Motivo in più per attribuire al capolavoro stravinskiano una posizione meno in ombra rispetto alla statura del Sacre, riconoscendolo come momento del pari cruciale nella definizione delle coordinate musicali dell’estetica del XX secolo.