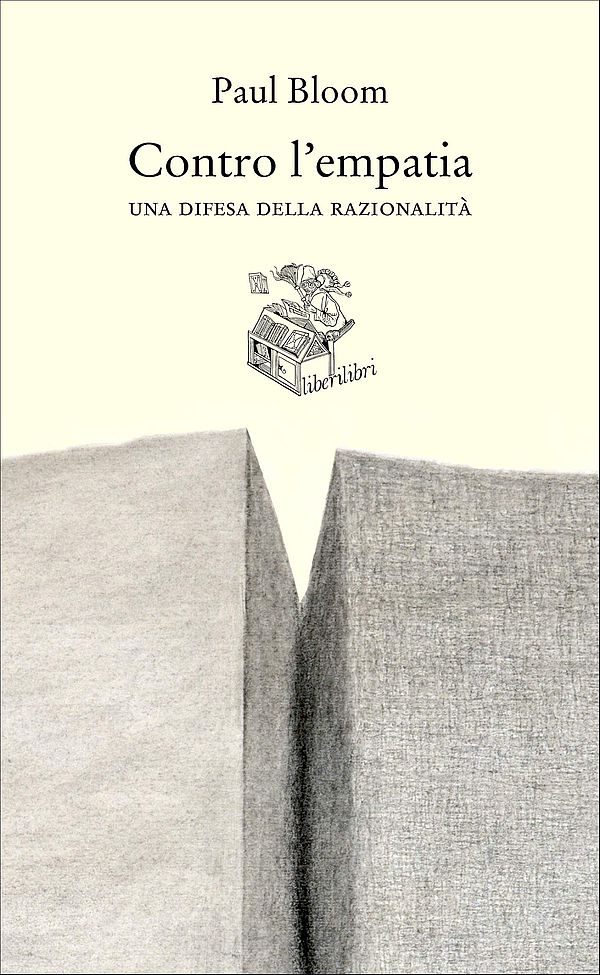Empatia: una parola e un concetto molto alla moda. Bisogna essere empatici per stare a questo mondo senza essere tacciati di egoisti e senza cuore: mettersi nei panni degli altri, soffrire per l’umanità in difficoltà, struggersi insieme ai protagonisti di tutte le peggiori storie del mondo. Eppure quel dolore che ti viene nella pancia quando pensi ai bambini affamati non li salverà. Li salverà piuttosto una politica intelligente e lungimirante. L’empatia può sicuramente fare leva sul pubblico: raccontare di Ahmed nella valigia darà per un attimo un po’ di angoscia a chi ascolta, ma poi serve ben altro. E attenzione: l’empatia è stata usata anche dai peggiori dittatori, che per esempio mettevano in circolazione storie di povere famiglie ariane distrutte dalla prepotenza di avidi ebrei. L’empatia è dunque uno strumento per arrivare al cuore delle persone, nel bene e nel male.
Questo lo dice fra gli altri Paul Bloom, professore alla Yale University, esperto riconosciuto a livello internazionale di psicologia dell’età evolutiva, del ragionamento sociale e della morale. È appena uscito in traduzione italiana il suo recente saggio Contro l’empatia. Una difesa della razionalità (ed. LiberaLibri). Bloom mette in guardia dall’insistere proprio sull’empatia come mezzo per migliorare il mondo e i rapporti umani; l’altruismo unito al buon senso, quelli sì invece che possono davvero creare commerci più onesti, politiche più egualitarie, rapporti benefici tra Stati, società e persone. Pensate per esempio a tutti quei camion di vestiti, scarpe e alimenti che vengono mandati dall’Europa all’Africa: questa idea arriva con le migliori intenzioni e uccide qualsiasi piccola impresa locale nel campo dell’abbigliamento, della fabbricazione di calzature e di attività rurali. Lascia l’Africa nel bisogno, nella dipendenza dagli aiuti, nel sogno di raggiungere un giorno quella Paris c’est chic che c’è scritto sulla maglietta che ti hanno dato. A ragionarci su, si potrebbe invece comprare alimenti e vestiti dall’economia locale e distribuirli, o investire in quelle fabbriche, agevolare prestiti bancari a tassi favorevoli per incoraggiare l’intraprendenza economica.
«L’empatia è una buona serva, ma una cattiva maestra», dice Bloom. Altri rischi che comporta: per provare un sentimento di empatia devo identificarmi con qualcuno. In generale mi viene più facile se questo qualcuno in qualche modo mi piace, mi assomiglia, mi è vicino. Lo sanno le pubblicità: per raggiungere le emozioni di chi le guarda, usano soggetti come bambini carini o donne dagli occhi profondi. Ci piacciono, quindi vogliamo che stiano bene. Più difficile è certo raccogliere fondi per i carcerati, i drogati e i senzatetto. Per chi è diverso da noi, per chi conduce una vita che non approviamo del tutto, per chi ci sembra che «se la sia cercata». O semplicemente per gli antipatici, i lagnosi, i brutti. È giusto questo?
È come dire di essere vegetariano perché gli agnellini sono carini e poi disfarsi senza remore dei pidocchi sulla propria insalata. Un animale è un animale, la zanzara non è certo fra le più popolari ma nell’ecosistema naturale ha una funzione più importante degli animali della mia fattoria. Inoltre, se vogliamo fare qualcosa per l’emergenza ambientale, l’empatia non ci serve a molto. Le distorsioni climatiche dovute all’uomo non danno particolari dolori empatici, eppure sono importanti soggetti di discussione. Se guardassimo al problema con empatia, scrive Bloom, preferiremmo non fare nulla: infatti se si agisce, «molte vittime identificabili – persone reali per cui possiamo provare empatia – saranno danneggiate dall’aumento del prezzo del carburante, dalla chiusura di attività, dall’aumento delle tasse e così via. I milioni o miliardi di persone che in una non specificata data futura subiranno le conseguenze della nostra attuale inazione, invece, sono pallide astrazioni statistiche». L’empatia è miope e parziale, vede come un riflettore: punta la luce su un caso specifico e lascia il buio intorno. Paul Bloom illustra il caso di un rapimento e assassinio avvenuto negli Stati Uniti durante il genocidio del Darfur. «Ogni giorno oltre dieci volte il numero di persone scomparse nell’uragano Kathrina muore a causa di malattie evitabili, e oltre tredici volte quel numero muore a causa della malnutrizione». Per fare davvero del bene, scrive, «è necessario rapportarsi con questioni complesse e essere consapevoli dello sfruttamento che può venire da interessi in contrasto tra loro e che possono essere malvagi e rapaci. Per farlo è necessario compiere un passo indietro e non cadere nelle trappole dell’empatia. La conclusione non è che non si dovrebbe donare, ma che si dovrebbe farlo in modo intelligente, con un occhio alle conseguenze».
Le convenzioni di Ginevra, ragionando unicamente su basi empatiche, non sarebbero mai nate: come posso essere tanto empatica verso i miei nemici quanto lo sono verso il mio popolo? Per decidere di trattare con umanità chi ha fatto del male a mio figlio, non posso essere io il giudice: deve farlo una legge giusta, non la mamma della vittima e non la mamma del carnefice, che tuttavia sono le persone più coinvolte empaticamente. Paul Bloom nel suo saggio cita numerosi studi che dimostrano come più una persona è empatica più chiede punizioni violente per chi ha commesso un crimine. È la razionalità, quella usata da persone oneste che pensano al bene degli altri, che invece porta a essere più equi. Perciò attenzione a non essere troppo empatici: rischiamo di cambiare marciapiede se vediamo davanti a noi un mendicante, rischiamo il burn-out se di mestiere facciamo l’infermiere e soprattutto i nostri amici hanno più bisogno di qualcuno che li faccia ridere che di qualcuno che pianga insieme a loro.