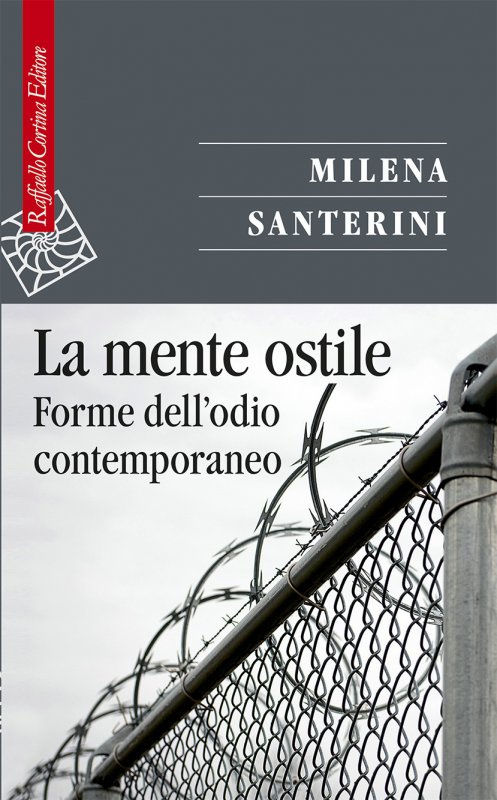«È certo che, mentre l’amore è abitualmente verso una o poche persone, l’odio diventa molto facilmente un fenomeno di gruppo, che richiede una comunicazione tra più individui».
La contemporaneità vive un po’ dappertutto il crescere del sentimento di odio, che ci pare abitudine più vitale e diffusa che mai. Una sorta di mortifero «odiocene» che sembra espandersi inesorabile, senza limiti di quantità e di qualità, esprimendosi in realtà sociali differenti e ricorrendo a vari modi e varie attitudini. Certo è che l’odio c’è sempre stato e sono tutt’al più i destinatari e, soprattutto, i canali che eventualmente cambiano. Bene fa, quindi, la pedagogista Milena Santerini a fare il punto su tutta questa varietà nel suo documentato La mente ostile. Forme dell’odio contemporaneo.
Il libro si distribuisce attorno alle forme dell’odio: quello nell’Internet, l’odio collettivo, il razzismo, l’antisemitismo, l’odio a sfondo sessuale e quello rivolto ai musulmani. In capo a tutto ciò sono poste le basi di una definizione («uno spettro di emozioni, atteggiamenti e comportamenti») e considerazioni sui fondamenti biologici. Soprattutto in questo ultimo ambito si concentrano le direzioni di ricerca recenti, un po’ per stabilire qualche continuità dell’odio nelle sue varie declinazioni storiche e un po’ per indagarne la sua bislacca comunicazione.
È la parte un po’ più di frontiera, dove impariamo che gli esperimenti con le immagini neurologiche hanno dimostrato che la localizzazione nel cervello della produzione di odio è parzialmente sovrapposta a quella dell’amore romantico (che, aggiungeremmo, è facile a trasformarsi in odio per accadimenti di vario tipo). Oppure che il comportamento d’odio è condizionato da reazioni precognitive, istintuali e istantanee, che «le emozioni legate al riconoscimento dei volti degli “altri”, di “persone che non ci assomigliano”, arrivano prima del momento in cui pensiamo razionalmente». E ancora che competenze umane come la memoria o il recupero di informazioni del passato ci permettono di ricorrere a pratiche che gli animali non conoscono: la vendetta, il piacere per le disgrazie altrui, il sollievo per il danno capitato al prossimo e non a noi, la comodità semplificatrice del pregiudizio, ma anche l’empatia, la compassione e tutta una serie di bontà.
È indubbio che la scena di questo dibattito sia occupata in questi anni da una particolare espressione del fenomeno: l’odio in Rete. Ne ha parlato, nella stessa collana di questo libro, il giurista informatico Giovanni Ziccardi qualche anno fa. Il tema sembra semplice da affrontare: da tempo si richiamano caratteristiche specifiche come la velocità, la capacità delle nuove tecnologie di dar voce ai borborigmi di chiunque abbia un PC o un telefonino, altre specialità di questi mezzi. Però, si comincia anche a ragionare su fatti che emergono con sempre maggiore regolarità: tra gli altri, la tendenza puntuale a mandare qualsiasi scambio subito fuori giri e sopra le righe.
Si può parlare di sessismo nella lingua, calcio, vaccinazioni, l’ultimo royal baby, come cucinare la pasta e fagioli ecc. e – non c’è verso – si litiga immediatamente, dandosi dell’illustrissimo senza risparmiare le bastonate. E oltre a tutto il resto, c’è pure la fastidiosa mania di taluni politici di letteralmente innescare un pandemonio dando con apparente neutralità una notizia delicata che riguardi i temi caldi del quotidiano. E scatenando quindi la canea di commenti e insulti lanciando il sasso per vedere che effetto fa: uno sbarco, la condanna di un richiedente asilo, la sentenza di un processo.
Tutto questo male fa male, naturalmente. La continua tensione verso destinatari individuali colpiti da vere e proprie tempeste di odio collettivo e categorie sociali investite nel loro insieme finisce per coinvolgere, a macchia d’olio, i diretti interessati, le loro cerchie, osservatori, passanti e l’intera comunità socioculturale. Insomma, tutti noi.