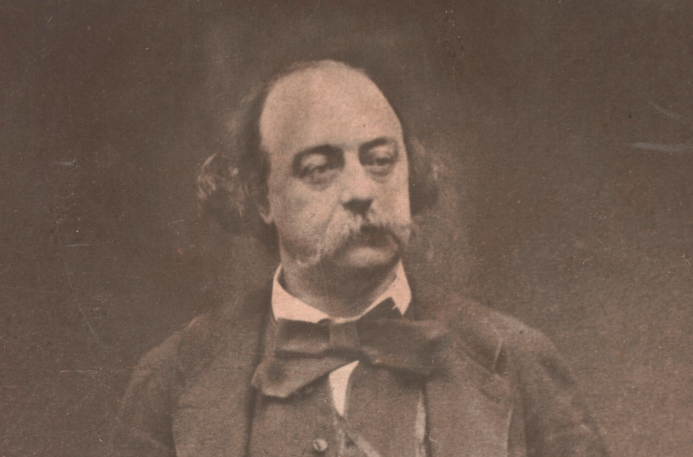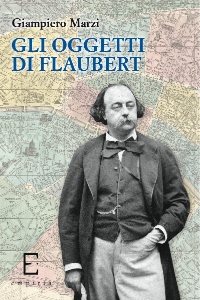9 dicembre 1876. Il quasi cinquantacinquenne Gustave Flaubert scrive alla nipote Caroline Commanville: «Che ne hai fatto dello scialle e del cappello da giardino della mia povera mamma? Li ho cercati nel cassetto del comò e non li ho trovati; amo di tanto in tanto rivedere questi oggetti e sognarci sopra. In me, nulla si cancella». A questa citazione – che incontriamo alle pagine 46 e 130 del saggio Gli oggetti di Flaubert – Giampiero Marzi avrebbe potuto aggiungere che il 15 dicembre, non avendo ottenuto risposta, Flaubert scrisse di nuovo alla nipote: «Che ne è stato o dove hai messo lo scialle e il cappello da giardino della mia povera mamma? Mi piace vederli e toccarli di tanto in tanto.
Non ho sufficienti piaceri al mondo per vietarmi questo!» Se poi ricordiamo che lo scrittore, a volte, faceva indossare alla governante un vecchio abito della madre morta, e che «sette anni dopo il funerale», come annota Julian Barnes nel suo avvincente Il pappagallo di Flaubert, «scoppiava in lacrime alla vista di quel decrepito vestito che continuava ad aggirarsi per la casa», come dubitare (tenuto conto anche di altri ragguagli riguardanti non solo la madre defunta) che nell’autore di Madame Bovary ci fossero dei tratti feticistici? E come non pensare a Charles Bovary, che dopo la morte di Emma si chiude frequentemente nello spogliatoio per contemplarne gli abiti?
Nelle opere flaubertiane del filone realista, scrive Marzi, «l’oggetto, che è pura materia, può essere elevato a simbolo, diventare feticcio, arricchirsi di una carica spirituale che ne può persino mutare l’originaria funzione, fino al diventare uno strumento dell’irrazionale». Un processo di feticizzazione lo subisce, ad esempio, il portasigari «bordato di seta verde, con uno stemma nel mezzo», che Charles Bovary raccoglie da terra durante il viaggio dalla Vaubyessard a Tostes, di ritorno dal ballo nel castello del marchese d’Andervilliers. Emma se ne appropria, lo nasconde in un armadio, e ogni tanto lo estrae da sotto la biancheria per aspirare l’odore della fodera, misto di tabacco e di verbena, immaginando che l’oggetto appartenga al visconte che l’ha invitata a ballare.
Oltre ad essere dei suscitatori di ricordi o dei surrogati di un essere vivente, nelle opere flaubertiane del filone realista gli oggetti possono svolgere diverse funzioni e avere più significati. I capi d’abbigliamento, ad esempio, ci dicono in varia misura i gusti personali, il temperamento, il milieu di appartenenza, le aspirazioni sociali, le possibilità economiche (reali o apparenti) di chi li indossa. E ci dicono molto della moda del tempo, a cui Flaubert era particolarmente attento. Per questo Marzi parla di «polisemia dell’oggetto flaubertiano». Esemplare e memorabile è un oggetto che compare nelle pagine iniziali di Madame Bovary: il berretto del giovanissimo Charles, un copricapo «d’ordine composito», descritto con una precisione che sembra anticipare l’école du regard. (Sia Madame Bovary che L’éducation sentimentale abbondano di cappelli e copricapo).
Anche gli oggetti presenti nelle stanze di una casa possono dirci molto dei personaggi che le abitano. Se, come scrive Marzi, il locale in cui Charles Bovary accumula e conserva gli oggetti fuori uso è solo un «cimitero delle cose», e se «il curioso museo che i due copisti (Bouvard e Pécuchet) allestiscono nella loro casa di campagna» è una collezione di oggetti eterocliti che documentano un’avventura conoscitiva che volge spesso in farsa, la camera dell’umile protagonista di Un coeur simple – «un luogo» come scrive Flaubert «che aveva l’aria di una cappella e di un bazar, tanti erano gli oggetti religiosi e le cose disparate che conteneva» – è invece «un museo personale di ricordi». (Più in generale, Marzi rimarca che l’importanza assunta dagli oggetti nel romanzo realista di Flaubert è conseguenza del crescente sviluppo dell’industria manifatturiera. La narrativa flaubertiana è specchio della modernità).
Ma per tornare all’oggetto che può «arricchirsi di una carica spirituale […] fino a diventare uno strumento dell’irrazionale», l’esempio più dimostrativo è il pappagallo Loulou, l’animale d’affezione della domestica di Mme. Aubain, Félicité, il «cuore semplice» del racconto (che non mi stanco di rileggere) con cui Flaubert voleva – sono parole sue – «impietosire, far piangere le anime sensibili, essendo io stesso una di loro». Quando Loulou muore, Félicité lo fa impagliare (lo «oggettualizza», come dice Marzi), e col passare del tempo lo va sempre più confondendo con l’immagine dello Spirito Santo. Flaubert non ci dice che fine ha fatto, dopo la morte di Félicité, il decrepito e inverminito pappagallo. Quando me lo chiedo, il pensiero corre immediatamente a un altro animale, il polveroso e tarlato Bendicò, che nella pagina finale del Gattopardo viene gettato da una finestra di villa Salina in un angolo del cortile sottostante, dove trova pace «in un mucchietto di polvere livida».