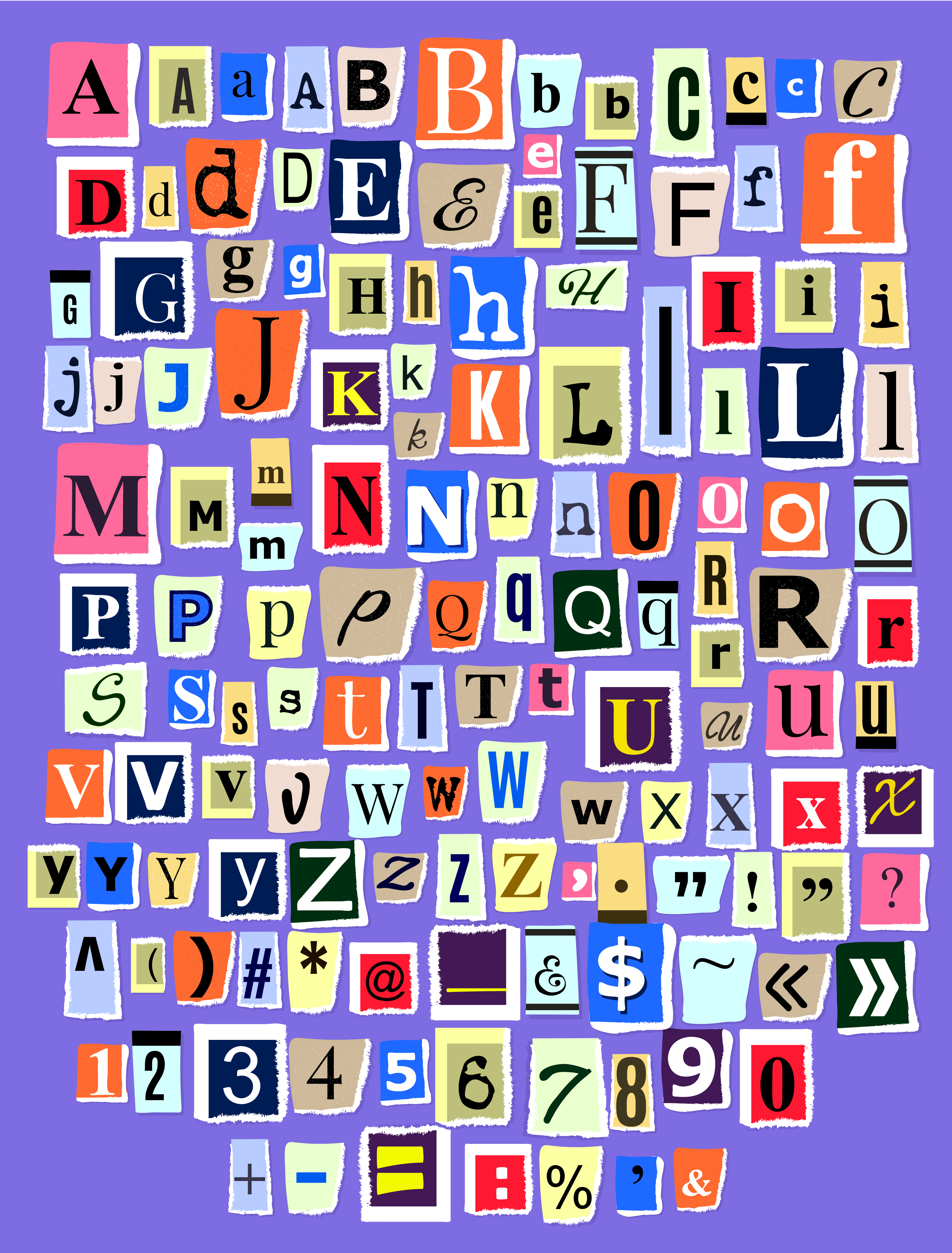Con l’irrequieto mondo dei social media, il dibattito sul linguaggio inclusivo condivide almeno una caratteristica: si infiamma subito, spesso indipendentemente dai buoni propositi di chi vi si avvicini e spesso al di là di ogni tentativo di riportarlo su un terreno di ragionevolezza, se proprio non lo si vuole sostenere con le logiche scientifiche. Si litiga insomma prontamente; non importa se gli interlocutori siano al bar, in televisione o a un congresso scientifico e ugualmente non contano premesse o mani avanti su regole del gioco e inviti alla calma. Il discorso sul linguaggio inclusivo è ormai per definizione divisivo.
Per fortuna, però, ci sono le buone letture, dove si impara tutto quello che si vorrebbe portare in quell’inferno comunicativo per cercare di mettervi un po’ di pace. E che, da par loro, assumono sovente il formato del manuale, con tutti i box, gli elenchi puntati e numerati, le istruzioni per l’uso, la bibliografia, ulteriori link per approfondimenti e verifiche. In questa letteratura pacificata brilla una pubblicazione della Direzione della lingua francese nel Belgio curata da due linguiste di lì, Anne Dister e Marie-Louise Moreau, che si intitola Inclure sans exclure. Les bonnes pratiques de rédaction inclusive (devo la segnalazione di questo illuminante libro a François Grin, specialista di economia linguistica, professore all’Università di Ginevra e membro del consiglio direttivo di Forum Helveticum).
Il libro solleva quello che sembra il problema principale dell’applicazione di qualsiasi forma di linguaggio inclusivo e cioè la necessità di assumere una linea che ponga in equilibrio esigenze diverse e in alcuni casi contraddittorie: una benvenuta lotta contro le esclusioni di qua e il dovuto rispetto per la leggibilità dei testi e una competenza grafica potabile di là. Sono mandati civili non di rado emanati contemporaneamente da una medesima autorità pubblica e che però non è facile far convivere in una politica linguistica ragionata.
Le etichette sono numerose, linguaggio inclusivo, ugualitario, non sessista, epiceno, non discriminatorio, a testimoniare il groviglio di prospettive che decidiamo talora di affrontare tutte insieme senza i dovuti distinguo e che giustificano l’incandescenza frequente. Ma, ancora, sarà saggio analizzare e separare. Prendiamo il genere linguistico, che è chiaro quasi sempre con qualche eccezione significativa, come i termini sentinella e staffetta, che al femminile possono designare anche persone di genere maschile. L’italiano ha plurali neutri maschili per un gruppo di uomini e donne ma anche forme d’insieme al femminile come maestranze, clientele ecc.; il francese ha soggetti maschili per situazioni dove non è in gioco nessuna persona, come nel caso di il pleut, trente-et-un, c’est beau que. Ci sono poi casi, forse di tendenza, in cui l’uso al plurale di un nome di professione allude a quasi solo uno dei generi: se dico i cassieri di un supermercato tenderò a intendere solo gli uomini e omologamente se uso la forma femminile solo le donne (si può fare per i parrucchieri, i puericultori e gli estetisti, sempre più con i medici e un po’ meno con gli infermieri, forse). Il giapponese ha tra le parecchie variabili legate all’espressione della prima persona singolare un’opposizione di genere: un io e una specie di ia.
Il lettore che abbia un po’ di volontà troverà in questa pubblicazione la storia dell’accordo al maschile, ragionevoli questioni di economia del sistema linguistico, una discussione sul carattere arbitrario del genere grammaticale, gli usi alternativi per un’espressione rispettosa, gli utilissimi termini collettivi e collettivanti. E, sull’altro piano, le buone pratiche della leggibilità e della pacatezza espressiva, una sacrosanta sezione con le raccomandazioni: che cosa bisogna fare e che cosa no.
Da tenere lì sul tavolo, per mantenere la calma.
Bibliografia
Anne Dister et Marie-Louise Moreau, Inclure sans exclure. Les bonnes pratiques de rédaction inclusive, Bruxelles, Éditions Collection Guide, 2021.