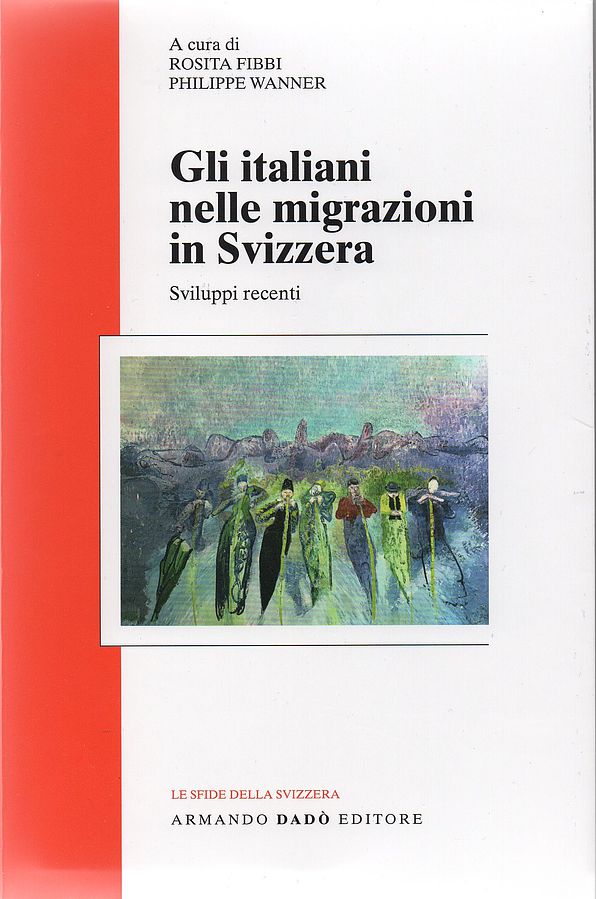Il recente studio pubblicato da Armando Dadò e affidato alla curatela di Rosita Fibbi e Philippe Wanner, dal titolo Gli italiani nelle migrazioni in Svizzera ci ha ricordato immediatamente un vecchio classico sull’argomento, nella sua bella veste viola tipica della «serie politica» einaudiana anni 70, Elvezia il tuo governo, di Delia Castelnuovo Frigessi. I due volumi sono necessariamente diversi per impostazione metodologica e per età, ma sembrano somigliarsi un po’ proprio per questa bipartizione formale tra parte istituzionale e parte «umana» (ben più estesa, quest’ultima, nel secondo esempio).
Il fenomeno che cercano di fotografare è, del resto, molto cambiato. E anzi, compito del saggio più recente è proprio registrare l’importante evoluzione socioeconomica che il periodo trascorso tra gli anni 60 e oggi ha portato nel mondo dell’immigrazione italiana in Svizzera. Se nel caso di quel movimento migratorio, che traeva le sue origini dallo sviluppo economico e urbanistico nella Svizzera del secondo dopoguerra, l’entrata di manodopera italiana era massiccia e rendeva gli italiani la nazionalità di maggioranza assoluta tra gli immigrati, oggi il quadro generale è molto mutato. Gli italiani rappresentano in effetti il 15% della popolazione di origine straniera attiva ed occupata in Svizzera (da notare che a questi, in Ticino vanno aggiunte le presenze dei frontalieri, che sono il 27% della forza lavoro cantonale), e sono il secondo gruppo nazionale maggiormente rappresentato sul mercato del lavoro elvetico, dietro ai tedeschi.
Da un lato, dunque, il parallelo tra dati statistici ci permette di valutare la quantità e la qualità della nuova emigrazione italiana fornendoci molti elementi di confronto col passato: se negli anni del boom economico la mano d’opera in arrivo in Svizzera era a basso tasso di formazione professionale, oggi, i nuovi immigrati che hanno scelto la Svizzera (i dati mostrano che più del 50% degli espatriati italiani si dirige in realtà verso la Gran Bretagna, la Germania, la Francia, mentre la Svizzera ne assorbe solo il 9%) hanno un tasso di formazione universitaria relativamente alto, e vanno ad occupare posizioni di responsabilità, senza comunque che smetta di esistere una immigrazione di persone con livelli medi e bassi di qualifica, tra l’altro spesso coinvolta in forme di lavoro precario e mal retribuito.
La dinamica di questi nuovi flussi delineata dalle statistiche trova evidentemente la sua spiegazione nella presenza di nuovi dispositivi legali e di nuove regolamentazioni (se ne occupano approfonditamente proprio i contributi della Fibbi e di Wanner). Per ciò che riguarda la nuova immigrazione italiana del nuovo millennio al centro della discussione stanno gli accordi bilaterali con l’UE, con la loro definizione delle famose «quattro libertà»: di circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali. Molto interessanti, da questo punto di vista, sono i saggi contenuti nello studio che si occupano degli aspetti storico-istituzionali legati all’atteggiamento della Confederazione in rapporto al tema dell’immigrazione. I concetti di «assimilazione» prima, e di «integrazione» poi, sono termini cardine della legislazione elvetica dopo il 2000, e mostrano una chiara (e per certi versi impensata) armonizzazione dei dispositivi elvetici con i principi adottati a livello europeo («L’analisi della normativa svizzera in materia di integrazione rivela un parallelismo con gli sviluppi europei, insospettato se ci si limita a seguire il dibattito interno, che invece tende a presentarla come frutto di una elaborazione dal basso, dall’azione sul campo, delle città», p. 82).
Merita senz’altro di essere approfondita, poi, la riflessione sul concetto di «italianità» proposta da Nelly Valsangiacomo e Paolo Barcella, che sottolinea il mutamento in senso positivo dell’immagine degli italiani in Svizzera tra gli anni 60 e oggi. Momento di svolta nel cambiamento di percezione è, per alcuni osservatori, addirittura la vittoria italiana ai Mondiali di calcio del 1982. Quel che è certo è che oggi l’immagine dell’Italia della moda, della gastronomia, del design di alto livello ha sopravanzato quella di patria degli «Tschingg»: anzi sembra che proprio quest’ultimo termine sia diventato il nome di una catena di ristoranti di successo, alla moda. Ironia della
storia...
Infine, i contributi personali, offerti dalle testimonianze recenti di immigrati in Svizzera (e in particolare a Basilea) creano quel filo di collegamento con il volume della Frigessi di cui parlavamo all’inizio. Le storie concrete e vissute mostrano profili diversi, successi e insuccessi, soddisfazioni e delusioni, come in ogni storia di sradicamento. Dietro alle statistiche ci sono delle persone che cercano riscatto e affermazione per le loro capacità o, magari, per i loro fallimenti: l’emigrazione è una questione complessa che merita di essere considerata con intelligenza e sensibilità.