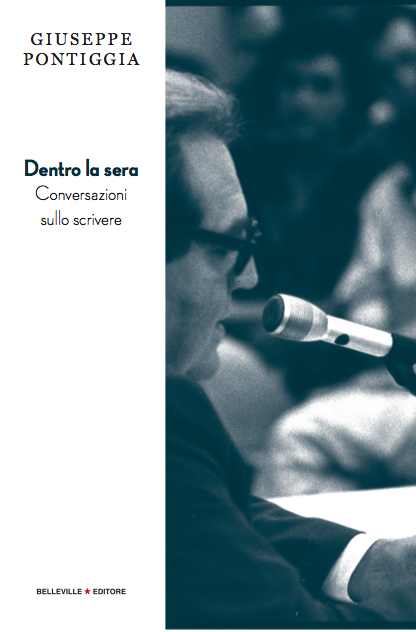I manoscritti non saranno restituiti perché smarriti. Questo voleva scrivere il direttore di una rivista (vero, tanti anni fa, diciamo il peccato ma non il peccatore) ai questuanti che inviavano articoli non richiesti. Elio Vittorini, direttore negli anni 50 della collana einaudiana I Gettoni, a Giuseppe Pontiggia che gli aveva telefonato dicendo «Avrei un manoscritto da farle leggere» rispose in maniera più articolata. «Bene, me lo mandi, poi mi telefoni, io non l’avrò letto, e allora lei mi ritelefoni e io non l’avrò letto neanche allora; mi telefoni una terza volta, io sarò irritato che lei mi telefoni per la terza volta, dopodiché ci incontreremo».
Il manoscritto era intitolato La morte in banca (dove l’aspirante scrittore era andato a lavorare a 17 anni, dopo la morte del padre). Di lì a quattro mesi, seguite puntualmente le istruzioni, Giuseppe Pontiggia fu ricevuto da Vittorini, incoraggiato a lasciare la banca, dissuaso a usare «le recensioni dei sentimenti», vale a dire frasi come «Gli sembrava che…» oppure «Aveva la sensazione che…». L’allievo seguì il consiglio e scrisse libri bellissimi come Vite di uomini non illustri e Nati due volte. A rendere l’aneddoto ancora più gustoso, sono gli altri Gran Rifiuti dello scrittore siciliano: Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il tamburo di latta di Günter Grass, Il Dottor Zivago di Boris Pasternak.
A metà degli anni 80, Giuseppe Pontiggia iniziò al Teatro Verdi di Milano – allora era un quartiere di periferia con la sede del PCI, oggi è l’Isola, luogo di elezione degli hipster milanesi, poco lontano dal bosco verticale di Stefano Boeri – i suoi corsi di scrittura. Materia di cui in Italia si era a fatica sentito parlare, mentre negli Stati Uniti erano numerosi (all’interno delle università, perlopiù). Dieci anni dopo, nel maggio 1994, Aldo Grasso commissionò a Giuseppe Pontiggia una serie di conversazioni radiofoniche sulla scrittura.
In onda sulla seconda rete della RAI, ora sono pubblicate da Belleville editore, sigla editoriale nata dalla scuola di scrittura creativa con lo stesso nome pennacchiano (a Milano dal 2014). Tra gli insegnanti: Ottavio Rossari, Edgardo Franzosini, Luca Crovi, Walter Siti. Oltre al corso annuale, propone una serie di corsi serali, mentre il prossimo libro – in autunno – sarà Writers in Hollywood di Ian Hamilton. Ovvero, le avventure e le disavventure degli scrittori arruolati dal cinema. Per esempio William Faulkner, che in cambio di un’ottima paga settimanale chiese «posso lavorare da casa?». Dallo studio gli risposero di sì, e lui non si mosse dal Mississippi, giacché odiava Los Angeles. La relazione andò malissimo, e non migliorò in corso d’opera.
Chi ha conosciuto Giuseppe Pontiggia ne ricorda la smisurata biblioteca (aveva affittato l’appartamento al piano di sopra per farci entrare tutti i libri) e la brillante conversazione, ricca di aneddoti che riguardavano sia i poeti amici sia gli scrittori dei secoli passati. È il modello Carlo Fruttero di chiacchiera letteraria, come lo si trova esposto in Mutandine di chiffon: parlare di Zola, di Dickens, di Jonathan Safran Foer, di Salman Rushdie con il tono dei padroni di casa che commentano gli ospiti, a festa appena finita.
Tutto si ritrova in queste pagine, e volendo anche nel CD allegato al libro. Giuseppe Pontiggia sfata l’idea che Marcel Proust sia «uno scrittore dotato di prodigiosa memoria» – definizione che ebbe il risultato di tenerlo lontano per un po’ dalla Recherche. Non erano i ricordi che gli interessavano, era la costruzione gigantesca e fascinosa che se ne poteva trarre. Questo – e non altro – segna la differenza con gli scrittori dilettanti che cominciano a raccontarci delle loro zie, prozie, cognate annoiandoci a morte.
Prende in giro «i narratori irresponsabili». Insomma, i velleitari che annunciano «voglio raccontare un paese dove non succede niente» – e li invita subito a cambiare mestiere. Chiarisce che per raccontare la noia non bisogna essere noiosi, una cosa è la vita e altra cosa è l’arte. A una signora che davanti a un suo dipinto commentò «la donna ha un braccio più lungo dell’altro», Braque rispose «Non è una donna, è un quadro». Avverte «contano solo le cose che capitano sulla pagina». Perfetta risposta per chi – quando gli fai notare che il dettaglio è insulso, la precisazione noiosa, la battuta stantia – risponde «ma è andata proprio così». Certo, nella vita. Per fortuna la letteratura ha regole più rigorose.