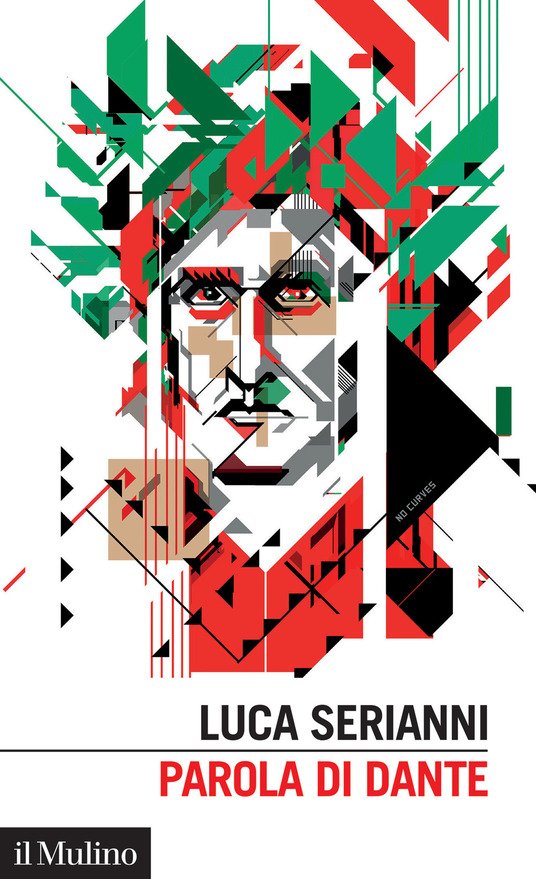«Mancano all’appello sostantivi che indicano sentimenti come fiducia (già duecentesco), simpatia e antipatia (più tardi); o aggettivi come bravo e acido (entrambi trecenteschi) o identico (XVII secolo)».
L’interrogativo più urgente dell’anno dantesco sta già nella prima riga della prima pagina di questo Parola di Dante di Luca Serianni: «Sono troppi i libri su Dante apparsi in questo 2021?». Nell’anno del settecentesimo dalla morte è fuori di dubbio che questo sia un libro in più in una serie nutrita di libri; però, lette le centocinquanta pagine, l’ultimo saggio del linguista romano può di sicuro essere classificato nella squadra dei tanti e non in quella dei troppi. Anche perché ci parla di un problema non da nulla, che interessa gli Italiani e la propria lingua.
Si narra un po’ ovunque della sorprendente facilità con la quale il lettore italiano contemporaneo legga la Commedia, con tutti quei secoli di mezzo e soprattutto rispetto a francesi, tedeschi e inglesi. I quali, messi a confronto con testi coevi della loro tradizione non ci capirebbero, ahiloro!, quasi nulla: qualche combattimento tra cavalieri e poco più. Sarebbe difficile, in parole povere, asserire che l’italiano del Trecento e quello che parliamo oggi siano due lingue differenti, cosa che pure è sostenuta da più di uno studioso. È per contro agevole osservare (senza necessariamente essere degli specialisti) quanto poco siano cambiati il modo di scrivere e una percentuale importante delle parole, come hanno dimostrato invece molti linguisti.
La faccenda è meritevole di approfondimento, perché le cose sono date per tanto certe e di fatto non lo sono. Lo nota giustamente Patrizia Valduga in un articolo decisamente linguistico (per chi lo sa, la maggiore poetessa italiana non sorprende per questa briosa verve su questioni di lingua) sul «Fatto Quotidiano» dello scorso 26 settembre, «la Commedia non la si capiva già più nel Quattro e Cinquecento, figurarsi oggi». Giusto. E sacrosanto risulta dunque l’approccio di Luca Serianni. A cominciare dalla fortuna del lessico trecentesco e dalle parole stracitate e perentorie di Tullio De Mauro, autentico Literaturpapst del campo e indiscutibile padre di numerose direzioni della linguistica italiana. Dice De Mauro (è bene ricordarlo) che al momento della redazione della Divina Commedia «il vocabolario fondamentale dell’italiano (di oggi) è già costituito al 60% e alla fine del Trecento il vocabolario fondamentale è configurato e completo al 90%».
Ora, il libro di Serianni ha il pregio di affondare poderosa mano nella materia: prima di tutto consacrando capitoli allo stile e proponendo uno studio del destino nei secoli delle parole della Commedia, e poi non disdegnando incursioni nella filologia, nella metrica e nello studio della messa in versi. Vale a dire che per capire Dante oggi servono le parole, a due condizioni: a patto cioè di distinguere tra parole e parole e di prendere in considerazione aspetti diversi del sistema linguistico e comunicativo.
L’analisi del lessico in Italia ha costruito, grazie a De Mauro, Serianni, Giuseppe Patota, Giuseppe Antonelli e tutta una serie di osservatori attenti e documentati, una bella tradizione di autorevolezza e benvenuta leggibilità, e questo libro non fa ovviamente eccezione. A partire dalle parole dell’italiano contemporaneo che già c’erano in Dante e separando quelle che ancora oggi hanno lo stesso significato da quelle che nel frattempo ne hanno assunto un altro, da quelle che non c’erano nella Commedia per vari motivi (i termini dell’abbigliamento, quelli che indicano le piante commestibili, parole tipo medico, ambasciatore, aglio, cipolla ecc.), dalle espressioni poi usate male o a sproposito, da quelle che in tutti questi anni hanno preso significati specifici. Come la parola «stampa», che Dante usa nel senso di «impronta» un secolo prima dell’invenzione della stampa. E come molte e molte ulteriori parole; giunte fino a noi, d’accordo, ma in che stato e dopo quali «travagli» lessicali è ancora tutto da vedere.