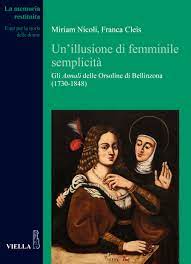Leggere di suore e di conventi potrebbe sembrare noioso: ci s’immagina una vita piatta fatta di rosari e giaculatorie. Invece non è così. L’indagine storica scritta da Miriam Nicoli e Franca Cleis Un’illusione di femminile semplicità, gli Annali delle Orsoline di Bellinzona è ricca e sorprendente perché insieme alle vicende legate alla comunità religiosa, racconta anche la storia del Palazzo del Governo Cantonale inaugurato nel 1743 come Collegio delle Orsoline. Promotori dell’edificazione furono i fratelli Pietro Antonio e Fulgenzio Molo, che chiamarono a Bellinzona le religiose della Compagnia di Sant’Orsola, specializzate nell’educazione delle giovani. Gli Annali, redatti da Giuseppa Marianna Mariotti, descrivono la quotidianità delle Religiose e delle Educande, raccontano di sfarzose cerimonie religiose, di vestizioni e di morti. Il manoscritto è anche una cronistoria ricca e precisa che evidenzia i conflitti di potere tra fazioni opposte e registra i grandi avvenimenti «fuori le mura», come la Rivoluzione francese e l’arrivo delle truppe francesi a Bellinzona, che nel 1798 scalzarono temporaneamente le suore dal convento. Gli Annali si concludono nel 1848, un anno turbolento per l’Europa intera, quando in seguito alla legge sulla soppressione dei Conventi, lo stabile fu incamerato dallo Stato e consacrato poi, nel 1881, sede definitiva del Governo.
Le due autrici appartengono a generazioni diverse: Miriam è una giovane esperta di storia culturale delle scienze, Franca è la pioniera, da mezzo secolo impegnata nella ricerca sulla scrittura femminile in Ticino. Con il lavoro comune, hanno saputo integrare le più recenti metodologie d’indagine con l’esperienza sul campo. In effetti dev’essere andato tutto a meraviglia perché insieme al volume sulle Orsoline, le stesse autrici hanno presentato un secondo saggio: La Gran Regina del cielo e le Benedettine di Claro. Il Convento di Claro, arroccato sul fianco della montagna, è un luogo che al profano è sempre apparso misterioso. Da ragazzini immaginavamo le celle con dentro le suore sepolte vive, obbligate al silenzio, donne fatte di puro spirito; non ci era ben chiaro se avessero necessità di mangiare e bere: così ce le tramandava la diceria popolare. In realtà, il manoscritto del 1697 di suor Ippolita Orelli, ricamato di miracoli e di venerazione per la Vergine Maria, lascia trasparire una cultura e una vivacità intellettuale difficilmente rintracciabili, a quel tempo, fuori dai conventi. Alle madri cariche di figli, sempre con la gerla in spalla, mancava lo spazio per coltivare l’intelletto. Dal libro veniamo a sapere che le monache – recalcitranti alla reclusione voluta dal Cardinal Borromeo – seppero escogitare gli stratagemmi e le astuzie necessarie per procurarsi il pane della sopravvivenza.
Ma come è nato l’interesse per la donna scrittrice e per le tracce che ha lasciato nella cultura e nella storia? Con Franca Cleis-Zoppi, che conosco e stimo da molti anni, ho colto l’occasione per risalire il percorso del suo viaggio nel mondo della scrittura femminile. «Sono sempre stata una gran lettrice, fin da piccola – racconta Franca – leggevo di tutto, ma erano sempre opere scritte da uomini. Poi, non ricordo per quale compleanno, mio figlio Giovanni, consigliato dalla sua maestra, mi regalò Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Un’opera che mi ha cambiato le prospettive, aprendomi il mondo della scrittura femminile. Per la verità non mi ero mai riconosciuta del tutto nelle montagne di libri che avevo letto, anzi, mi avevano insinuato il sospetto che ero io a essere sbagliata. Nelle pagine di Virginia Woolf mi sono sentita subito come un pesce nell’acqua. In quel periodo – erano i primi anni Settanta – andavo spesso a Milano e lì mi sono imbattuta nella Libreria delle donne, in via Dogana, proprio dietro il Duomo: piena di libri di ogni genere, tutti scritti da donne. Ho cominciato a comprarne a borsate. Con quella immersione, mi sono resa conto che in Italia e un po’ in tutta Europa erano iniziati, o stavano iniziando, gli studi specifici sulla scrittura femminile. Ma non nel nostro Cantone, tagliato fuori dalle indagini italiane ed escluso da quelle svizzere che si indirizzavano sulla produzione in lingua tedesca e francese. Allora mi sono chiesta: Ci saranno state, in Ticino, donne che hanno scritto? Chi sono? Cosa hanno scritto?».
Ebbe così inizio la sua ricerca sistematica nelle biblioteche e negli archivi in cui l’informatica non era ancora entrata. Ci si documentava esaminando schede cartacee, scritte a mano, che portavano i segni delle dita inumidite sulla lingua. Un lavoro durato più di dieci anni. Il risultato è il saggio di 400 pagine Ermiza e le altre (1993). Una sorta di atlante delle autrici della Svizzera italiana, un panorama biografico e bibliografico, indispensabile per chi intende affrontare l’argomento. Franca Cleis era allora docente presso le Scuole professionali commerciali di Chiasso, dove fu tra le prime a insegnare videoscrittura. E questo le permise di ritrascrivere e ordinare le schede su computer, quando il computer era ancora una rarità.
Le sue letture, intanto, si erano concentrate sulla saggistica femminile dedicata ai problemi di genere, al «pensiero della differenza sessuale». La sua iniziale passione per la poesia non le è però mai venuta meno. Ricordo di averla incontrata a Buenos Aires, nello storico Café Tortoni, frequentato da intellettuali e artisti: era sulle tracce di Alfonsina Storni, la poetessa nazionale Argentina – la più amata e celebrata, laggiù – ticinese di nascita ed emigrata da bambina. Di Alfonsina, Franca Cleis ha curato due opere tradotte in italiano: Poemas de amor (1988) e Vivo, vivrò sempre e ho vissuto, in collaborazione con Marinella Luraschi Conforti e Pepita Vera Conforti. Al centro delle sue ricerche c’è sempre la volontà di affermare i meriti che la donna si è conquistata con il suo operare. Non importa che sia una figura quasi mitica, dal destino tragico, come Alfonsina Storni, o che si tratti di Angelica Cioccari-Solichon (1827-1912), un’insegnante che a metà Ottocento ha scritto il primo manuale di economia domestica per le scuole intitolato L’amica di casa. Ad Angelica Solichon, maestra d’avanguardia e divulgatrice scientifica, Franca ha dedicato La piramide di pesche della saggia Reggitrice (2007).
Con il tempo, per Franca Cleis si sono moltiplicati anche gli impegni di collaborazione con giornali e riviste e di promotrice culturale. Con Osvalda Varini ha curato i seminari Pensare il mondo con le donne (poi pubblicati in tre volumi). Nel 2001, davanti ai 250 incarti frutto delle sue ricerche e alla sua biblioteca di 2500 volumi di mano femminile, le venne l’idea di fondare gli Archivi Riuniti delle Donne Ticino (ARDT), realizzata nel 2003 in collaborazione con altre studiose. Determinante fu il sostegno di Margherita Scala-Maderni, che mise a disposizione i locali per la sede di Melano. Gli Archivi delle Donne sono rimasti indipendenti dalle altre organizzazioni archivistiche ticinesi per volontà delle fondatrici che hanno preferito stare alla larga da possibili intromissioni maschili. «Si ha l’impressione – ho detto a Franca – che in questo vostro mondo di sole donne, tutto sia filato in grande armonia …» «Non esageriamo – mi ha risposto – anche noi abbiamo avuto le nostre beghe, i nostri scontri». Non ho indagato oltre, per lasciare spazio alle ricercatrici del futuro. Comunque, se dispute ci sono state, credo che non possano eguagliare le pittoresche liti settecentesche tra le Orsoline di Bellinzona: suore che urlavano forzando le porte, suore che scappavano dal Convento – a piedi e a cavallo – travestite da contadini … (leggete il libro!)
Oggi, incurante dell’età, Franca Cleis continua le ricerche nel suo studiolo che guarda su un giardino rigoglioso e ben soleggiato e – anche se può sembrare contraddittorio – le piace molto lavorare in cucina. Intanto ha già iniziato, con Miriam Nicoli, una nuova indagine su un’altra donna ticinese di grande valore che definisce «la mia amata e impareggiabile Maestra», per salvarla dall’oblio.