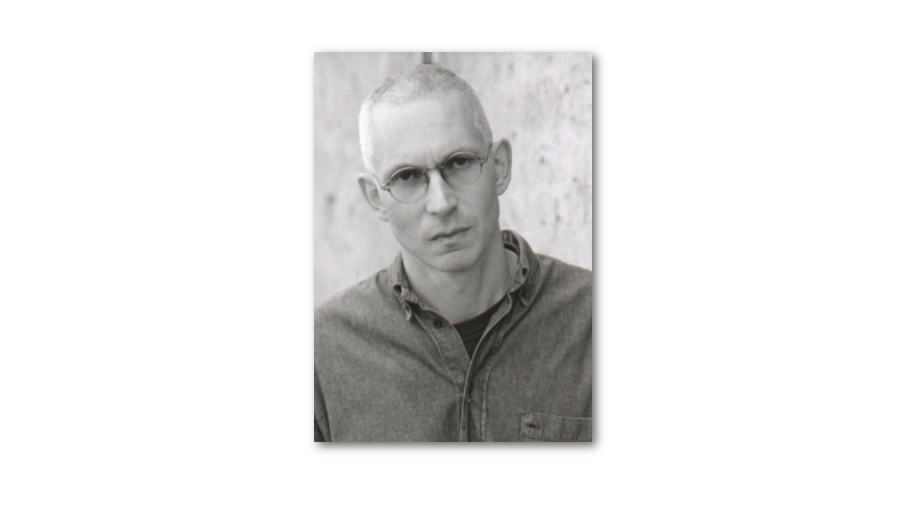Nella sua nota a Diafonie (Vanni Scheiwiller, 1995), Stefano Agosti scriveva di una «non facile collocabilità (...) nel quadro pur variegato dell’attività poetica contemporanea». A distanza di vent’anni, a seguito della pubblicazione di Sesterno nel 2005 e con l’uscita, ora, di questo densissimo Brevis altera (Book Editore, 2015), tale constatazione si rivela necessariamente attuale. Il libro, di una sessantina di pagine, conferma infatti un ulteriore, mirato inabissamento nella faglia che, da sempre, è il campo di indagine di Antonio Rossi.
Ma, prima, è bene retrocedere e descrivere, per sommi capi, gli esiti di un percorso che, come si è detto, rappresenta un fenomeno singolare nella nostra letteratura. Rossi esordisce nel 1979 con la raccolta Ricognizioni (Casagrande, 1979). La prima edizione del volume è introdotta da una prefazione di Giovanni Raboni, nella quale, acutamente, già si accenna a «un linguaggio che si parla da solo, fantasma o alone vocale di un ben difeso inconscio collettivo».
Di fatto, i brani di Ricognizioni, anche se emanati da parvenze narrative, sembrano contenere quel che sarà, poi, uno sviluppo sostanziale e violento. Ad esempio, testi come Terriccio, oppure Comunicazione a terzi o, ancora, Movimenti di gru e Rimozione di polline rivelano caratteristiche reperibili nelle successive raccolte: «Erano così singolarmente distribuiti / sopra il tavolino delle riviste / gli infinitamente minuscoli, / com’è abitudine designarli, / granelli di polline caduti e riuniti / a formare infine consistenza / di fragili aggregati in un canto / e di isolati corpuscoli dall’altro / e così fuori dell’ordinario era la compiutezza / suggerita da tale loro disposizione / che assai smarrito e con vero senso di rincrescimento / presi atto, a un certo momento, / della loro accidentale rimozione».
Se in questo frangente l’appoggio al senso condiviso appare ancora evidente (aspetto che, poi, Rossi attaccherà con un vero e proprio assedio linguistico), la presenza della materia corpuscolare, del suo farsi e disfarsi in balia di forze «altre», indica, al contrario, quella «nuova», ingigantita dimensione che permetterà alla lingua del poeta di rinnovarsi acquisendo una singolare autonomia. Un continuo cozzare di elementi «assolutamente non omogenei fra loro» (S. Agosti) – sostantivi, aggettivi, verbi – simile a quello di un processo alchemico sarà alla base delle future Diafonie – così come di Sesterno (Book Editore, 2005) – e di formulazioni che, via via, andranno a seguire le logiche di un editto preciso quanto impenetrabile: «Turbolenze subdole / rasentano massi farinosi / e si addensano se stoffe / assumono nottetempo fogge / truci e visi di altri / transitano fra condotti / e con essi un livido / sleale, una brezza / carente poiché respinta / in cunicoli e: un furto seguito / da offese, un’esplicita collusione».
Nelle note del nuovo Brevis altera l’autore, riferendosi al titolo della raccolta, accenna al sistema di notazione mensurale che permise, dalla fine del XIII secolo sino al termine del Seicento, la rappresentazione esatta di ritmi articolati e complessi: «è così chiamata (...) una «breve alterata» (o «altra breve»). Qui con allusione al «punto di partenza» che, trasformato, si ritrova nella parola poetica». Vediamo dunque che, con questa schiva indicazione, il poeta suggerisce il campo da gioco in cui si consuma la sua partita: il percorso di Rossi è sì oscuro (per noi) ma, anche, rispondente a un definito progetto «musicale». Infatti lo sforzo che richiede al lettore non riguarda la ricerca di una piana comprensione, ma, piuttosto, la ricezione fisica di una parola reinventata. In questo Rossi è indubbiamente un autore radicale, poiché non opera in modo furbesco (tenendo un piede nel «discorso» e l’altro oltre il segno). Al contrario, è come se a monte, tra le righe, dicesse: smantellerò il senso e obbedirò al buio, alla sua vibratilità, così da far emergere l’incandescenza di una lingua inedita.
Brevis altera, come era il caso di Sesterno, è suddiviso in sei parti e comprende quaranta poesie distillate nell’arco di dieci anni. I testi, tutti brevi, evidenziano quella materialità che è peculiare della scrittura di Rossi e, al contempo, lasciano emergere criptate dichiarazioni di poetica – come in questo esempio: «Una particella di fuoco / da un braciere fuoriuscita / e a ovatta puntualmente / sorretta o illesa capigliatura / sfuggita forse impoverita non è / se aspetto di perlina o luminosa / goccia non assume ma esente / da fidato interlocutore suo / tragitto compie». Ancora più evidenti, in questo senso, sono certi brani della sezione Quasi di sé: «Prevale il silenzio: / timori e pericoli / si faranno più sicuri / e visioni più esplicite / o lesive / se prima con bisbiglio / parole dispendiose / in severa lingua / torneranno».
Ed è proprio questa sezione che, a tratti, forse con qualche eccezione qua e là, lascia emergere, seppur di rado, una sorta di soggettività fantasmatica comunque sempre dissestata, fuori asse e priva di contorni che non siano quelli del testo: «Temono i passi / quasi di sé la presenza / nel locale agli eventi / destinato come se / le cento frammentate / musiche in esso generate / potessero per un istante / essere udite». Naturalmente, l’io è al bando ma la sua eco potrebbe essere udita, magari (e, sottolineo, magari), nel seguente brano, appartenente a Disancoraggi: «In foreste pluviali / originato e da monsone oltre / golfi e ombre danzate / sollevato e a gran passo / in cerchi e strati e atmosfere / dilagato: vieni affanno / e di ogni fessura o pensiero / fai tuo presidio».
Per concludere: la pubblicazione di Brevis altera è un evento considerevole e, in qualche modo, atteso; poiché Rossi, nel suo percorso, ha avuto l’abitudine di operare come un sommergibile, aspettando a lungo l’istante della riemersione. Certo la sua poesia potrebbe sembrare esclusiva e non «aperta» quanto altre, eppure è proprio questa posizione estrema, intransigente, a confermarne il valore – e l’indiscutibile unicità.