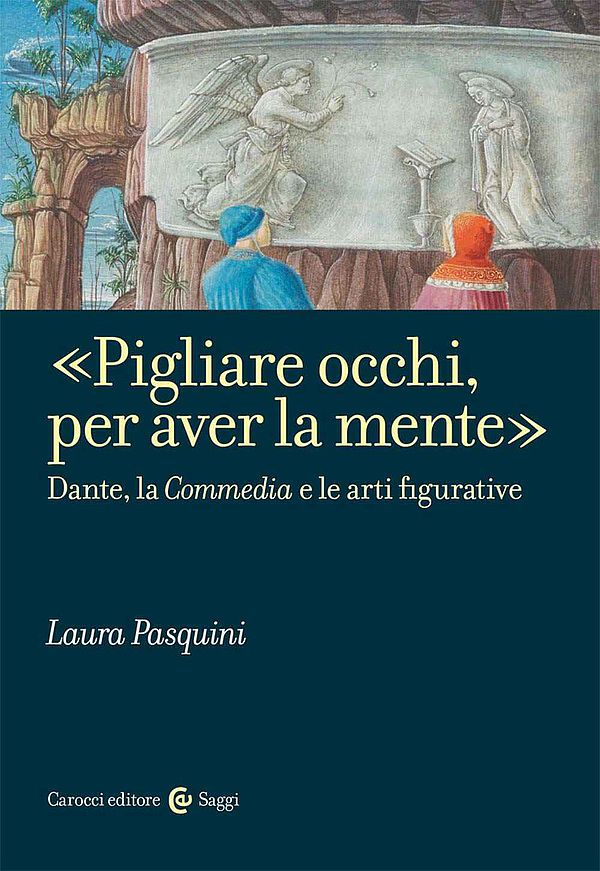Se la Commedia è stata fonte ispiratrice per artisti nel corso dei secoli, ci si può chiedere quali sono invece gli orizzonti figurativi e iconografici che hanno nutrito l’autore della Commedia. Risposte convincenti e documentate le troviamo ora nel saggio di Laura Pasquini che deriva il titolo da un verso del Paradiso e formula nuove ipotesi sulla biblioteca interiore di Dante, «un mondo intero fatto di alcuni libri fondamentali e di numerosissime figure», fra queste quelle appartenenti alla grande bellezza del territorio italiano, dall’arte classica a quella più innovativa del suo tempo, «che stava andando alla riconquista del vero» con il realismo di Giotto. Così facendo emergono anche tracce plausibili della presenza di Dante in luoghi più «incerti», come Torcello, Venezia e Roma.
Le immagini portatrici di messaggi religiosi e politici erano parte della quotidianità dell’uomo medievale, immerso in un universo di figure, segni e simboli, che avevano principalmente la funzione di istruire gli analfabeti, attivare la memoria e suscitare emozioni, come spiegavano già Gregorio Magno e Tommaso d’Aquino. Si era insomma abituati «a ragionare per immagini», a decifrare i significati delle rappresentazioni e Dante attinge a questo patrimonio visivo per rafforzare le sue descrizioni, rielaborando e plasmando le opere d’arte che aveva ammirato in alcuni luoghi; fra questi figura quasi certamente la basilica di Santa Maria Assunta a Torcello, dove si trova un grandioso mosaico dell’XI secolo che raffigura il Giudizio universale, con una discesa di Cristo agli inferi e «l’attestazione rara e precoce» del tema iconografico del limbo dei bambini non battezzati, che Dante colloca nel primo cerchio dell’Inferno. Alla stessa fonte visiva si fa risalire la pesatura delle anime dei defunti, che si disputano diavoli e angeli (iconografia antica di ascendenza egizia), ma anche la divisione dei dannati in scomparti (sette come i peccati capitali) potrebbe aver stimolato l’immaginazione del poeta, con dettagli che trovano riscontro nelle sue terzine.
Appassionante anche l’indagine sulle radici figurative del Lucifero dantesco, fra ascendenze pagane e tradizione cristiana nota all’arte medievale che rappresenta il demonio con un volto triforme, in antitesi alla Trinità. Gli indizi in questo caso portano a Tuscania, al Satana scolpito sulla facciata di San Pietro, ma anche al demonio «villoso e corpulento» nell’affresco di palazzo arcivescovile di Treviso. Di certo rilevante è la raffigurazione nell’inferno musivo realizzato da Coppo di Marcovaldo nel battistero di Firenze, opera che funge da comune denominatore fra l’inferno dantesco e quello raffigurato da Giotto nella Cappella degli Scrovegni; sono molteplici infatti le assonanze fra poeta e pittore, non soltanto per il Lucifero «possente e gigantesco», ma anche per le iconografie dei dannati, come per avari e usurai raffigurati con un sacchetto di monete appeso al collo: tutte immagini costruite per rendere visibile il peccato e innescare nello spettatore l’immedesimazione salvifica.
In particolare nella cantica del Purgatorio (canto XI) Dante dimostra di essere stato testimone attento della rivoluzione naturalistica che si compie fra Duecento e Trecento nell’arte figurativa occidentale, cominciata nelle cattedrali gotiche francesi e tedesche, ma anche dal ciclo di affreschi di Giotto ad Assisi; un realismo che si concentra sulla fisicità dei corpi e l’espressività dei volti e frutto di un nuovo modo di intendere la spiritualità.
Nella cantica del Paradiso si tratta per Dante di «dare forma plausibile a un’idea, a un dogma, a una preghiera»; la sfida dunque è raggiungere un equilibrio fra concretezza ed espressività, astrazione e peso simbolico. Ancora una volta Dante attinge ai mosaici paleocristiani fra Roma e Ravenna: i riscontri testuali indicano stretti legami fra le processioni paradisiache dantesche e quelle realizzate in Sant’Apollinare Nuovo e in alcune chiese romane. Ma l’interesse di Dante per le opere musive si estende agli aspetti tecnici e materiali: dimostra infatti una profonda conoscenza delle modalità di assemblaggio di quelle tessere contenenti lamine dorate in grado di produrre la massima luminosità.
Versi come quelli che si trovano nel canto IV, in cui Dante rievoca il martirio di San Lorenzo, dimostrano infine l’importanza del ruolo che rivestono le arti figurative nella Commedia per visualizzare il dogma; del resto alcuni concetti sono comprensibili se sono percepiti dapprima dai sensi, secondo la dottrina tomistica. La preferenza del poeta per questo martire, arso vivo nel 258, sembra essere stata favorita da alcune immagini del santo a Ravenna, come il mausoleo di Galla Placidia. Nell’astrazione dell’arte bizantina Dante trova inoltre ispirazione per le simmetrie delle gerarchie angeliche, la visione della Vergine e la luminosità dei cieli. Poeta ben consapevole che – come scriveva Gregorio Magno - «non si fa del male, nel voler mostrare l’invisibile per mezzo del visibile».