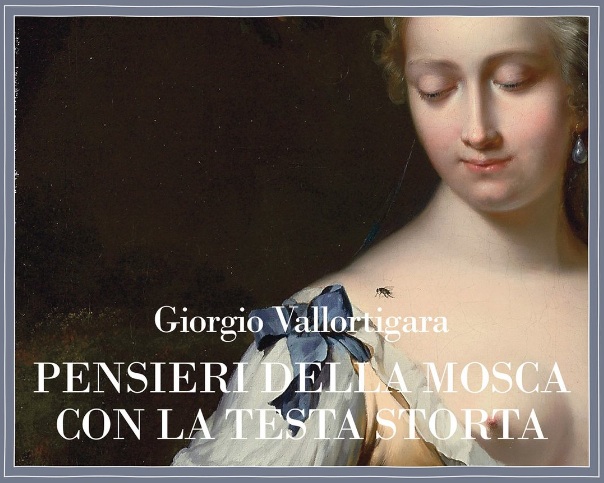«All’Università del Sussex, dove proseguì la mia formazione, c’era un collega che si occupava dei ragni saltatori, in particolare del modo in cui questi animali sono capaci di aggirare gli ostacoli “tenendo a mente» la preda scomparsa alla vista. Avevo indagato gli stessi comportamenti di detour nei pulcini di pollo domestico, così ci scambiammo qualche idea».
Non c’è alcun dubbio: leggere libri come questo Pensieri della mosca con la testa storta di Giorgio Vallortigara, neuroscienziato trentino noto per ricerche molto apprezzate sul comportamento cognitivo degli animali, è soprattutto uno spasso, e non da poco. Prendiamo il caso delle scimmie macaco reso adulte, le quali come noi umani riconoscono icone che cercano di rendere la fisionomia di un viso umano, per intenderci quelle fatte con le verdure o disegnate sulla superficie liquida di un caffè. Oppure il fatto che i singoli esemplari di un particolare tipo di vespa cartonaia (la polistes fuscatus) distinguono letteralmente i visi delle proprie compagne di sciame; a dire il vero potremmo già accontentarci di sapere che queste vespe hanno visi diversi l’una dall’altra, perché d’istinto si è tentati di pensare che le vespe hanno tutte lo stesso aspetto.
Di più, Vallortigara ci spiega che sulla base di questi tratti si fonda gran parte delle relazioni sociali e gerarchiche all’interno del gruppo. Ancora, le api discriminano in taluni esperimenti segnali percettivi come i colori, ma sanno anche estrarre e astrarre concetti superiori del tipo «se devo raggiungere una gratificazione o evitare una punizione, vado nella direzione del colore di prima o scelgo quella di un altro colore»: non il colore in sé ma il fatto se un colore è uguale o diverso da quello precedente. Ragionamento e non pura percezione, categorie astratte e non semplici stimoli sensoriali.
Poi è chiaro che non si legge un libro del genere solo per divertirsi. Una cosa che emerge con insistenza in vari punti riguarda il confronto tra la capacità di un animale, uomo compreso, di fare cose ritenute cognitivamente alte e di stabilire una socialità accettabile e consapevole da una parte e le dimensioni del cervello e il numero di neuroni per dirigere tutto ciò dall’altra. Pare che non basti un gran testone per disporre di una grande intelligenza e che altre siano le evidenze importanti, non da ultimo un quoziente di encefalizzazione secondo il quale conta quanto pesa il cervello di una specie animale rispetto a quello di specie di pari taglia. Che poi questo tagli fuori un’intera lunghissima stagione di studi di paleontologia umana che stabiliscono l’inizio della facoltà del linguaggio nell’uomo primitivo sulla base del volume di crani trovati qua e là è effetto secondario, cui si dovrà peraltro un giorno trovare una risposta.
Tant’è. Le vespe del tipo «una faccia, una razza» di cui si è detto hanno dei cervelli mini, «un milione scarso di neuroni» (l’uomo ne ha ottantasei miliardi, lo dimostra un calcolo spiegato molto bene a pagina 77); ciò proverebbe che abilità cognitive e conseguenti competenze sociali (per esempio lo «stare al mondo vespesco») possono essere considerate elementari e non determinano da sole la superiorità dell’uomo. Di fatto, «per riconoscere i volti poche centinaia di neuroni sono sufficienti. Il problema semmai è la memoria dei volti». E anche qui… «le pecore possono imparare a riconoscere cinquanta facce individuali di loro compagne e ricordarle a due anni di distanza».
Ah, ci sono inoltre le api che distinguono i quadri di Monet da quelli di Picasso e i piccioni che riconoscono beccando lo schermo parole della lingua inglese. E un percorso di lettura a sé è sostanziato dalle epigrafi poste a capo di ogni capitolo: da Antonio Rosmini (nato a Rovereto come Vallortigara) a Emily Dickinson (due), Campanella, Montale (due), Borges (due), Achille Campanile.