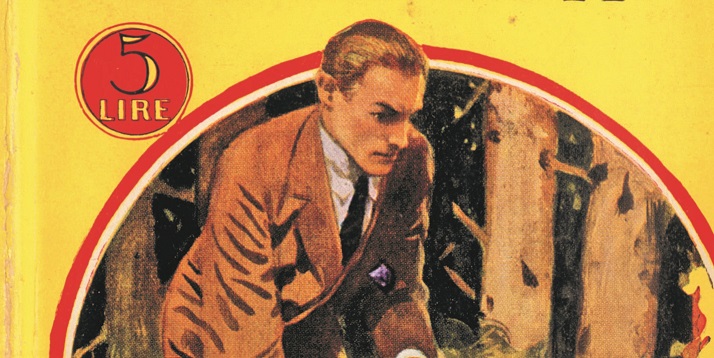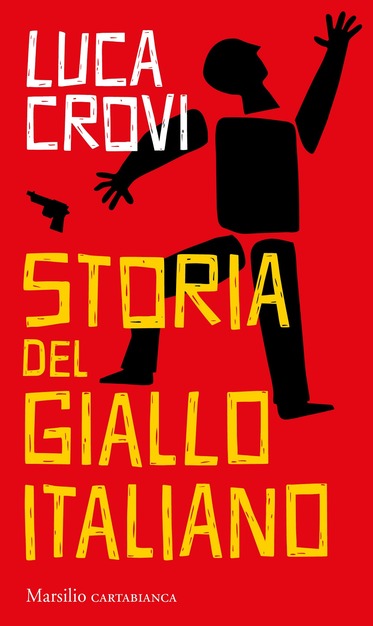«Torino è una città pericolosamente mascherata. Non è affatto sobria e diffidente. È la più pronta a captare il Male da ogni angolo della terra, e la sua funzione è di spargerlo in giro per il resto della penisola».
Fosse solo anche per il numero delle pagine, cinquecento, questa Storia del giallo italiano di Luca Crovi ha di sicuro il carattere del monumento. Le due prospettive principali sono quella cronologica e quella geografica, attorno alle quali cresce una lunga vicenda sorprendente per originalità e varietà. Per la prima, il libro si apre con l’opera precoce di Emilio De Marchi: sul finire dell’Ottocento la sua ambizione fu subito quella di creare un nuovo tipo di narrativa, quella «sulle colpe e sui colpevoli», centrando un proprio target popolare con un prodotto «locale» di impatto.
La prospettiva geografica descrive poi una serie di realtà cittadine circoscritte ma densissime del giallo italiano, anche qui di costituzione antica: attorno alla metà del diciannovesimo secolo, infatti, il tipo I misteri di… elencherà una serie di opere collocate via via a Palermo, Roma, Firenze, Milano, Napoli, Torino. Il libro le riprende tutte, in una serie di capitoli centrali che raccontano le città che ancora oggi ospitano le varie storie. Non di rado, il genere è stato ed è aiutato e promosso dalla strutturazione in collane, e spesso cavalcando l’effetto seriale e continuato dato da innumerevoli investigatori, magistrati, poliziotti, avvocati; in questa squadra, il libro fa bene a non dimenticare quelli che Crovi chiama «nonni thriller», pensionati che sul modello di Agatha Christie e Miss Marple popolano un vero e proprio genere nel genere.
Si sa che il nome del giallo deriva direttamente dalla mitica collana inaugurata da Mondadori nel 1929; meno noto il fatto che, a quei tempi, la casa editrice milanese già disponeva di altre serie colorate: «I Libri Azzurri», «i Libri Verdi», «Il Libri Neri», i quali evidentemente non ebbero come i gialli la forza di fondare un genere. Questa e altre scelte grafiche del tempo furono però molto consapevoli, e su questo aspetto lo stesso Crovi indugia giustamente un po’.
Il giallo italiano è scritto da autori prestati occasionalmente o in modo regolare al canone, e ovviamente da tutta una serie di scrittori «nativi» che finiscono qua e là per assumere lo statuto di classici della letteratura italiana recente (Giorgio Scerbanenco, Andrea Camilleri, Massimo Carlotto tra gli altri). In posizione intermedia sta l’«ibrido» di alcune figure come quelle di Giovanni Comisso e Sergio Saviane, a metà tra la narrazione e la cronaca; a un fatto nero, la serie di omicidi montani accaduti ad Alleghe, nelle Dolomiti bellunesi, questi due scrittori di molto diversa provenienza dedicarono due libri memorabili. Qui è interessante sottolineare che, tra i vari teatri delle diverse vicende (dal giallo storico classico, al Ventennio fascista, alla mala milanese degli anni Sessanta e Settanta, alle tensioni degli Anni di piombo), ha certamente un suo posto il thriller di montagna, quello che mette in scena «i tremendi segreti delle comunità», dove il delitto opprime anche perché inserito in un’angustia regionale di angoscia e inquietudine.
C’è – è chiaro – dell’altro, nel libro di Luca Crovi: un accenno per esempio a una sorta di «giallo nel giallo», il giallo-bolla, che incorpora altre storie. Il personaggio di Sherlock Holmes è inserito nei pastiches letterari di parecchi scrittori. Giorgio Celli è autore di un Come fu ucciso Umberto Eco del 1991 (l’idea è stata poi ripresa, omologa anche nella scelta della vittima «semiotica», nel recente La settima funzione del linguaggio di Laurent Binet, dove l’omicidio è quello di Roland Barthes). Non manca infine in questo libro qualche accenno alla notevole opera di teorizzazione: il manuale di Laura Grimaldi, le riflessioni dello stesso Massimo Carlotto, l’opera di Leonardo Sciascia e tutta una linea tecnica che consolida e afferma il giallo come una delle modalità di prima fila della letteratura italiana contemporanea.
«Se uno ci fa caso, in ognuno dei flagelli che opprimono la patria ci trova sempre sotto la mano torinese. È una città straniera che odia il resto d’Italia e manda i suoi messaggeri maledetti a diffonderci ogni più abominevole trovata».