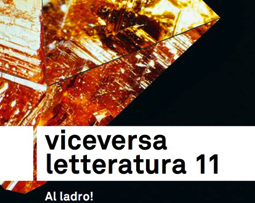La lingua franca del latino, e non l’onnipresente inglese, offre il titolo alla rivista del Service de Presse Suisse, edita oramai da undici anni, tra aprile e maggio, sotto la limpida insegna di «Viceversa letteratura» (il secondo termine declinato invece nelle lingue nazionali). Erede della storica «Feuxcroisés», pubblicata dal 1999 al 2006 e già quella dedicata a «littératures et échanges culturels», «Viceversa» ha continuato sulla medesima linea di chi l’aveva preceduta, potenziando però la sua presenza sul digitale e instaurando nuovi rapporti con editori locali.
Il fascicolo 2017, che guarda in realtà, come ogni annuario, ai dodici mesi precedenti, è faccenda di furti e ruberie: Al ladro! recita infatti il titolo nell’edizione italiana, curata da Matteo Ferrari e pubblicata a Bellinzona da Casagrande. I furti sono per lo più metaforici: di «prestiti», più che di «plagi», si parla solitamente in letteratura, e «ladro» è parola che si attaglia sia a un Alberto Nessi, poeta in cerca di frammenti da rubare alla realtà di ogni giorno (Ladro di minuzie è una sua recente antologia poetica), sia al concetto stesso del tradurre, che anche quest’anno è giustamente al centro delle attenzioni della rivista.
Montati attorno a materiali comuni, ma dosati diversamente a seconda delle lingue e del diverso pubblico di lettori, i tre fascicoli di «Viceversa» sono sempre simili ma non identici. Lasciamo ai lettori curiosi (e poliglotti) il compito di esplorare le edizioni tedesca e francese, per concentrarci su quella italiana, che si apre con alcuni inediti di Matteo Terzaghi (intervistato da Magda Mandelli), di Irena Brezna (già apprezzata ospite di Chiassoletteraria e Piazzaparola lo scorso anno) e di Philippe Rahmy (autore anarchico e proudhoniano, qui non a caso con una prosa intitolata I monarchi). A Emmi Hennings e Friedrich Glauser, nel centenario del dada, è dedicata la sezione «Qui e altrove», che si chiude sulle tracce di Maurice Chappaz e Charles Ferdinand Ramuz; mentre il «Quaderno di inediti» ospita testi di una decina di autori svizzeri, tra cui Stefano Marelli, Yari Bernasconi, Odile Cornuz, Rolf Hermann, Dana Grigorcea e altri. Senza nulla togliere agli sforzi di scrittori e traduttori, ciascuno con una propria voce e una propria visione del mondo, la preferenza di chi scrive va ai versi di Thilo Krause, poeta di Dresda attivo da qualche tempo nella Svizzera tedesca, anche grazie alla splendida traduzione di Roberta Gado: «Qui passa di mano in mano / un bicchiere di latta / mentre sotto i piedi / vola la ghiaia. / […] / Qui il giorno sferraglia verso la fine».
Davvero quella dei traduttori, lo si ripete spesso, è la chiave d’accesso alle letterature svizzere, anche di esportazione: Markus Roduner, domiciliato nei paesi baltici, traduce in tedesco dal lituano (si veda il bel dossier su di lui alle pp. 198-205). Non ci si dovrebbe però limitare a questo, pena il rischio, specie per le lingue di minoranza, di una certa retorica da riserva indiana. È difficile montare un fascicolo che proponga ogni anno a lettori svizzero-tedeschi e romandi produzioni originali in italiano e romancio, per il semplice fatto che la massa critica degli scrittori in queste lingue non sempre giustifica lo sforzo, indipendentemente dalla bontà dei singoli contenuti. Anche tra le pagine di questo fascicolo di «Viceversa» circola insomma, qui e là, un po’ di aria di chiuso (una redattrice di Casagrande intervista un editor di Casagrande per una rivista di Casagrande…) e uno sguardo oltreconfine, chissà, potrebbe rappresentare in futuro una valida alternativa, almeno per la minuscola parte italiana. Per ribadire come le frontiere da attraversare non siano soltanto quelle interne (linguistiche), ma anche esterne (politiche), e per ricordarci, soprattutto, in quale misura le letterature svizzere continuino a nutrirsi del confronto con le molte culture linguistiche cui di fatto, ibridamente, appartengono, al crocevia di una delle zone più vivaci e interessanti d’Europa.