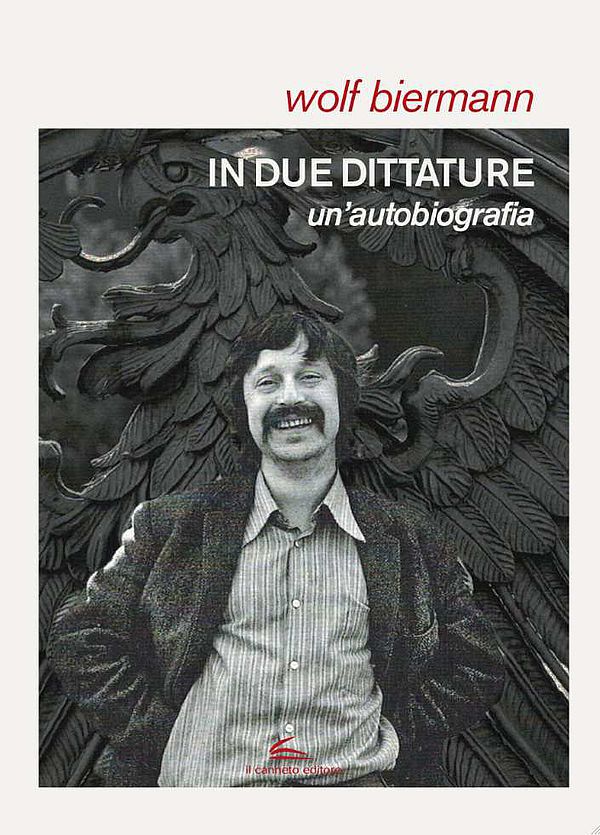La biblioteca delle pandemie registra nuovi arrivi. Accanto al Decameron di Boccaccio con la terribile immagine della peste fiorentina e alle pagine manzoniane dei Promessi sposi che rievocano l’epidemia milanese del 1630. Mentre a tenerci un po’ più allegri ci pensano i sonetti in dialetto romanesco del Belli, Er collera mòribbus, sul morbo che colpi l’Italia nella prima metà dell’Ottocento. Tutti volumi da tempo in catalogo come, altrove, La peste di Camus o Il castello di Kafka che suggeriscono al nostro presente di solitudine e dolore la disperante attesa di un futuro.
Ma a leggere l’incalzante testo di Wilhelm Jensen, Gli ebrei di Colonia. Romanzo del Medioevo tedesco, proposto per la prima volta in italiano a cura di Claudio Salone da Robin edizioni, l’orizzonte si rabbuia di fronte a una duplice tragedia: la Morte Nera, cioè la peste, e l’antisemitismo. Gli eventi si svolgono intorno alla metà del Trecento ma è la percezione del presente che echeggia da lontano nel libro. Jensen, figlio illegittimo del borgomastro di Heiligenhafen, una cittadina vicino a Kiel dove nacque nel 1837, ha certo in mente le epidemie che devastarono il Vecchio Continente al tempo della sua infanzia e oltre fino al 1866. Tre anni dopo pubblicava la sua intensa storia di distruzione e amore con al centro il vecchio saggio ebreo Kaleb.
Lo scrittore aveva alle spalle studi di medicina e una laurea in filosofia. Visse per un certo tempo fra Monaco e Stoccarda per poi trasferirsi definitivamente con la numerosa famiglia nel capoluogo bavarese. Fu redattore e direttore di giornali e autore prolifico, nell’ambito del realismo tedesco, di romanzi e drammi soprattutto storici. Era un intellettuale ben inserito negli ambienti letterari dell’epoca, ma il suo nome viene ricordato ancora oggi soprattutto per l’interesse che Freud mostrò verso la sua novella gotica Gradiva del 1903 che gli era stata segnalata dall’amico Jung.
Era la storia di un giovane archeologo che scopre in un museo il bassorilievo di una fanciulla che cammina e ne viene colpito a tal punto da lasciarsi andare a vagheggiamenti e fantasie oniriche. Lo studioso ne fu talmente affascinato da dedicargli nel 1907 il saggio Il delirio e i sogni nella Gradiva di Wilhelm Jensen, in cui per la prima volta prendeva coscienza della profonda affinità fra psicoanalisi e arte nella prospettiva dell’inconscio. Una dimensione tuttavia abbastanza marginale nelle pagine dello scrittore, anche se la sua indole malinconica e la profonda sensibilità per l’indagine dei processi psicologici talvolta proiettano sui suoi protagonisti miraggi e visioni, come nel caso della giovane e splendida ebrea Tamar, figlia di Kaleb.
A dire il vero Jensen amava piuttosto la tradizione illuminista e dete-stava la mentalità piccolo borghese e l’antisemitismo. Era estraneo a qualsiasi confessione religiosa e sosteneva il Kulturkampf, cioè la lotta del progresso liberale contro ogni forma di oscurantismo. Insomma, un tedesco sui generis nell’atmosfera nazionalista del Secondo Reich, in cui l’odio verso gli ebrei non era affatto scomparso e la barbarie – come si legge nella prefazione alla seconda edizione del romanzo – «ancora alberga nei cuori». Fin da giovane non nascose il suo sdegno verso la brutalità che attraverso i secoli aveva moltiplicato «per mille la vergogna e l’umiliazione scesa sul nome tedesco». E lo proietta sulla scena drammatica del suo romanzo, dove la peste si sta diffondendo in modo subdolo con l’alito, i gesti di amore e amicizia, i baci e le strette di mano.
Ne ha sentore fin dall’inizio il giovane Hellem di ritorno a Colonia dopo sette anni di assenza, che alle porte della città viene assalito dalle locuste e sente stormire nell’aria qualcosa di spettrale e invisibile. Lo attendono nel Ghetto il vecchio e ricco Kaleb, che egli chiama padre ma è in realtà lo zio, sua moglie Lea e la loro bella figlia Tamar. Ma ben presto in preda ai terribili sintomi del morbo Hellem fugge dai familiari trascinandosi a fatica per la città dei cristiani finché perde conoscenza.
Attorno a lui ruotano gli altri personaggi in una drammatica atmosfera che sembra riflessa nel dipinto coperto da un panno di seta che Kaleb ha appeso alla parete: case incendiate, saccheggi, corpi sfigurati o inceneriti. E su un lato lo splendido viso di una fanciulla che cerca invano di difendersi dall’assalto di uomini vogliosi. È una sorta di preannuncio della vicenda romanzesca in cui spiccano anche figure generose come il medico ebreo Thubal che assiste il malato, la giovane Sybille, a cui un tempo Hellem salvò la vita, che lei ricambia ora con il suo aiuto, il vigoroso maestro d’ascia Franz disposto a portare in salvo l’intera famiglia con la sua barca o il padre di Hellem, l’ebreo Isaschar, fratello di Kaleb, macchiatosi anni prima di una grave colpa e ripudiato dalla famiglia, che si riscatterà con la propria morte per salvare i parenti più cari.
Sullo sfondo il profondo affetto di Tamar e Hellem, appena lambito da una sfumatura incestuosa, che sfocerà in sincero amore. Certo poi non mancano i violenti come il conte Honfried, seduttore di mestiere e nemico della nascente borghesia, che aizza i più bassi istinti della folla seminando odio contro gli ebrei. Non esita per altro ad accusare ingiustamente Kaleb e Hellem di fronte al Consiglio di aver avvelenato i pozzi della città per annientare i cristiani.
Il giovane Jensen ama l’intreccio melodrammatico, predilige atmosfere e immagini notturne, stigmatizza le tendenze antigiudaiche della chiesa cattolica più retriva, ricama sul tema dell’erotismo, ma soprattutto costruisce una narrazione vigorosa che a distanza di un secolo e mezzo non ha perso nulla del suo inquietante fascino. Soprattutto quando si scatena il pogrom e il Ghetto va a fuoco mentre una folla rabbiosa distrugge ogni cosa. Ma ormai la famiglia del patriarca Kaleb è già in viaggio sul Reno verso Rotterdam e poi oltre ancora verso le terre di Polonia e Lituania dove regna il saggio re Casimiro e dove con gli anni sorgerà la grande comunità degli ebrei ashkenaziti. Dalla santa città di Colonia Jensen ha dato vita a un epico esodo verso la speranza, pur consapevole di quanto effimera essa fosse.