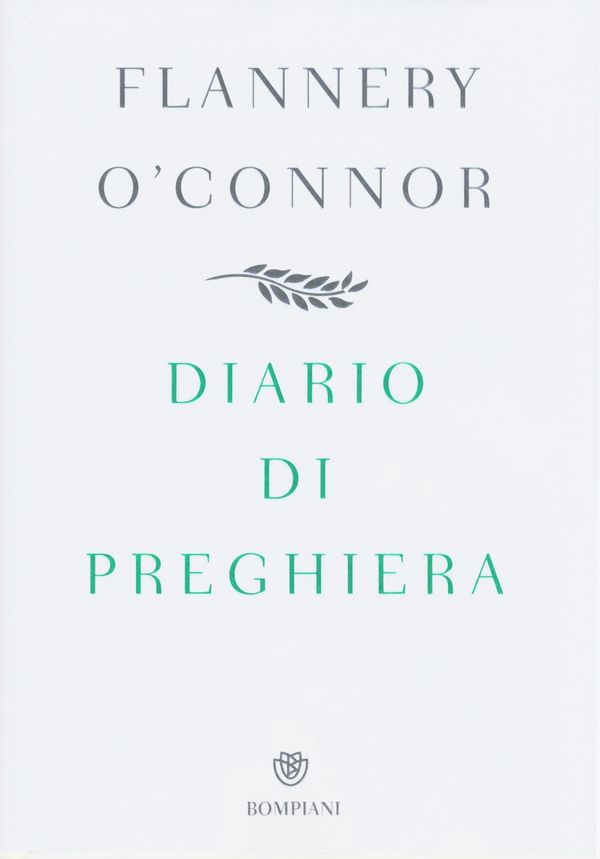Per Flannery O’Connor la realtà era qualcosa di semplice e allo stesso tempo stupefacente come l’aprirsi improvviso della coda di un pavone. Difficile era semmai, per lei, comprendere le profondità dell’agire umano, con tutte quelle incongruenze e contraddizioni. Gli uccelli erano diversi. Per questo aveva iniziato ad addestrarli sin da bambina, con un successo tale da convincere la Pathé News, nel 1932, a riprenderla assieme ai suoi polli che camminavano all’indietro (il breve filmato, Do you reverse?, è visibile su Youtube).
Se però le avessero chiesto la sua maggiore soddisfazione come allevatrice, avrebbe ricordato di certo il giorno in cui, verso la fine della sua breve vita, ben undici dei suoi venti pavoni fecero la ruota contemporaneamente, lasciandola senza fiato.
La storia di Flannery e dei suoi uccelli è molto nota, negli Stati Uniti, al punto che è diventata di recente un libro per bambini (The King of the Birds, 2016). La cosa sorprendente è che questa esperienza eccezionale ha in qualche modo a che vedere con la vocazione letteraria di questa donnina del Sud, cresciuta in una famiglia cattolica di origini irlandesi e morta di lupus all’età di 39 anni. Sì perché tra questi due estremi, la bambina entusiasta che cerca di convincere i polli a procedere contro natura e la donna malata che si commuove davanti alla bellezza dei pavoni in amore, è racchiusa tutta l’evoluzione della sua scrittura, il suo crescere e maturare secondo una dinamica che contemplava equamente il merito e la gratitudine, lo sforzo e la grazia. I risultati, altissimi, stanno lì a dimostrarlo: due romanzi e una manciata di racconti che hanno dato una scossa alla letteratura americana a cavallo degli anni Cinquanta.
Lasciata la nativa Georgia per l’Università dell’Iowa, dove professori e compagni faticavano a comprendere il suo accento del Sud (parlò sempre in dialetto, come John Keats), abbandonò presto i propositi di diventare giornalista per dedicarsi soltanto alla narrativa. Di lì a poco uscì il suo primo romanzo, Wise Blood (La saggezza nel sangue, 1952), storia di un veterano in lotta con la propria fede in una società intimamente caratterizzata dalla dimensione religiosa. Simile ma non identico è il protagonista del secondo libro, The Violent Bear It Away (Il cielo è dei violenti, 1960), un professore rimasto vedovo che prova a rieducare alla sua visione razionalista un nipote cresciuto da un vecchio che si credeva un profeta.
L’orizzonte metafisico, sovrapposto a quello reale del paesaggio agricolo degli Stati meridionali, è lo sfondo sul quale si proiettano tutte le sue storie, i cui attori, sovente segnati nel fisico da menomazioni e malattie, dispiegano la loro umanità in termini che molti lettori non esitarono a giudicare «brutali». Questo era Flannery O’Connor: un’autrice che non faceva sconti, né ai lettori né tantomeno ai personaggi delle proprie storie. Forse persino più dei due romanzi, il volume con tutti i racconti, pubblicato in Italia da Bompiani, è di quelli da tenere sempre sul comodino, assieme alle raccolte di Poe, Kafka, Hemingway, Raymond Carver.
Una produzione letteraria così ridotta, costantemente sottoposta al severo vaglio della scrittrice, è comunque andata arricchendosi negli ultimi anni di titoli laterali che raccolgono lettere, conferenze, pagine sparse. Per chi conosca già il mondo della O’Connor (il percorso a rovescio è possibile ma sconsigliato) si tratta di materiali preziosi e in un certo senso rivelatori: quanta consapevolezza dei propri mezzi, e insieme quanta accettazione della propria fragilità umana, nelle lettere ad amici ed editori (The Habit of Being, apparso in italiano da Einaudi con il fuorviante titolo Sola a presidiare la fortezza).
Al ricco carteggio si aggiungono ora le pagine del diario inedito, e anche in questo caso il numero esiguo di pagine, un centinaio compreso il facsimile dei manoscritti, è bilanciato dalla densità del suo pensiero: ad esempio laddove ritiene che una sincera «visione d’amore» sia tutto quello che serve al racconto del mondo. Oppure nelle disarmanti richieste, al tempo stesso pratiche e spirituali, al «caro Dio» cui nel diario si rivolge, giorno dopo giorno, con il cuore in mano: «che io non sia altro che lo strumento della Tua storia, proprio come la macchina da scrivere lo è per me». O ancora: «Per favore aiutami caro Dio a essere una brava scrittrice», sostenuta dalla ferma convinzione che il bene possa mostrarsi «anche attraverso qualcosa di banale».
Bisogna risalire a Dante per trovare un autore in cui la vocazione cristiana e quella letteraria si fondono in un equilibrio così perfetto, finendo quasi per coincidere. E non sarà un caso se, a distanza di secoli, il grande affresco della Commedia sia ancora il punto di riferimento per ogni discorso sull’aldilà: «Posso immaginare le torture dei dannati, però non riesco a immaginare le anime disincarnate sospese in un cristallo a lodare Dio per tutta l’eternità». Di disincarnato i protagonisti delle sue storie non hanno davvero nulla, in quel Purgatorio di destini incrociati che è andata costruendo finché le forze non sono venute meno. La sua eredità letteraria è di quelle che, con il tempo, acquisteranno sempre più peso. Sarei pronto a scommetterci.
Bibliografia
Flannery O’Connor, Diario di preghiera, Bompiani 2016, 110 pagine.