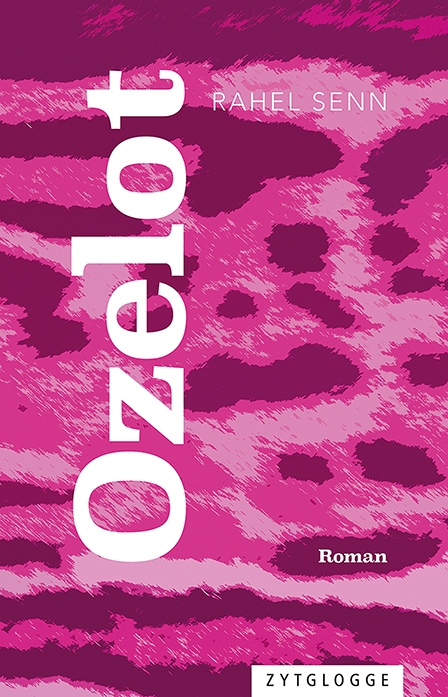Metti una pianista di fama internazionale, classe 1986, nata a Zurigo da padre svizzero e madre asiatica, che non ancora ventenne si trasferisce a Singapore per poi tornare in Svizzera dopo essere stata nominata nel 2012 Young Steinway Artist e da Forbes nel 2016 annoverata tra le donne più influenti. Metti una femminista e una donna straordinaria come Iris von Roten che nel secolo scorso ha lottato per i diritti delle donne e per il suffragio femminile. Uniscile, et voilà, ne esce un romanzo dal titolo Ozelot uscito in tedesco per l’editore Zytglogge e firmato dalla talentuosa Rahel Senn. Musicista e scrittrice, ha già pubblicato un romanzo sulla storia di Eduard Einstein, figlio di Albert. Sul suo sito si presenta così: «Sono cresciuta parlando sette lingue in un paese che non era effettivamente il mio. Spesso mi sono sentita incompresa; nella musica ho finalmente trovato la mia lingua. Grazie ad un pianoforte Steinway ho trovato la mia voce e il modo di esprimere la mia anima vagabonda».
Il perché del titolo ci viene svelato subito nelle prime righe che ci portano dritti al centro della storia, una sera del 6 dicembre 1955. Quel giorno, a quell’ora, a Zurigo viene arrestata una donna che afferma di essere un’avvocata. Indossa un pantalone di velluto verde e un cappotto di pelliccia di Ozelot. Manca il cappello ma non il rossetto rosso. Per i due poliziotti di pattuglia non vi sono dubbi, si tratta di una «E Trottoiramsle», in dialetto basilese una prostituta. Le chiedono i documenti: «Perché? Non sono obbligata a portare con me una carta d’identità». Detto da una donna equivale ad un affronto. Lei per evitare altre seccature dà il suo indirizzo: Iris von Roten, Oberer Heuberg 12, Basilea. Gli agenti non sono soddisfatti. Vogliono sapere dove è diretta, dove starà per la notte. «Come vi viene in mente di chiedermi dove pernotterò? Sono libera di non pernottare affatto e di camminare se ne ho voglia per tutta la notte fino a Ziegelbruecke». Le chiedono il biglietto del treno e Iris von Roten glielo mostra. Ancora non basta, insistono sul chiederle dove è diretta e quando si rifiuta di rispondere la minacciano di portarla al comando di polizia. Le chiedono cosa fa di mestiere, dice loro che fa la giornalista e l’avvocata. Scoppiano a ridere. Una telefonata ai colleghi conferma però la versione della donna, moglie dell’ex Consigliere nazionale Peter von Roten e madre di una bambina di due anni. Dopo averne confermato l’identità si apre allora un’altra questione: chi si occupa della bambina mentre questa donna si prende la libertà di passeggiare per le strade della città a quest’ora di notte? Il marito ha dato il suo consenso? A nulla valgono le proteste di Iris von Roten, alle 02.45 la polizia telefona a casa per farsi confermare dai domestici che la signora von Roten è uscita di casa diretta a Zurigo. I domestici confermano. Iris viene liberata solo alle prime ore del mattino. Nel rapporto si legge che il comportamento e il modo di presentarsi della persona arrestata erano singolari a tal punto da far sospettare che fosse fuggita da un manicomio. Un episodio che passerà alla storia come il «caso Panthermantel».
Cose da pazzi se pensiamo che sono accadute solo 66 anni fa. D’altra parte a quei tempi le donne non potevano accettare un posto di lavoro o aprire un conto, prelevare dei soldi senza la firma del marito e in caso di morte del congiunto non erano tutelate. Per non parlare di cosa poteva capitargli se non vivevano in modo conforme alle regole della società e a quelle coniugali. Rahel Senn ci racconta di Lydia, figlia dell’imprenditore e politico Alfred Escher che dopo la morte del padre sposa con riluttanza Friedrich Emil Welti per poi, di lì a poco, innamorarsi dell’artista Karl Stauffer. La relazione extraconiugale finisce male, il suocero per punirla la rinchiude in un manicomio.
È questo il motivo che ha spinto Rahel Senn a rendere omaggio a Iris von Roten, mostrare quanto questa donna sia stata coraggiosa e all’avanguardia in tempi in cui le donne dovevano accudire figli e marito e pensare al focolare domestico. Per ricordarci le ingiustizie e le angherie, gli affronti che ha dovuto subire perché bella, colta, intelligente, rea di aver alzato la voce per rivendicare ciò che alle donne spettava di diritto. E per ricordarci che se oggi possiamo vivere la vita che vogliamo, scegliere il percorso di studi e la professione, lo dobbiamo a chi ha lottato prima di noi. Iris, ad esempio, il femminismo ce lo aveva nel sangue. Meta von Salis (1855-1929), famosa femminista, sorella del bisnonno, appartenente a una famiglia dell’aristocrazia grigionese, sin dai suoi anni giovanili si oppose al volere del padre e scelse di studiare filosofia e storia all’Università di Zurigo. Nel 1887 in un articolo sulla stampa divenuto famoso chiese ciò che nessuno prima di allora aveva mai osato fare nella Svizzera tedesca: l’introduzione del diritto di voto e di eleggibilità delle donne. Hortensia Gugelberg von Moos (1659-1715), conosciuta come Hortensia von Salis, figura straordinaria del suo tempo, esperta di terapie naturali, si occupò di religione, medicina e botanica e mise la sua istruzione e la sua cultura al servizio della causa per la parità delle donne.
Ecco le antenate di Iris von Roten e se il passaggio di testimone tra loro ha funzionato, nel romanzo succede anche con la piccola Vittoria di sei anni, voce narrante, che viene a conoscenza della storia di Iris von Roten attraverso la madre, segretaria dell’Alleanza delle società femminili svizzere. La stessa che all’uscita di Frauen im Laufgitter: offene Worte zur Stellung der Frau nel 1958 volterà le spalle a Iris. La piccola Vittoria in Ozelot parla di una riunione di crisi del comitato dell’ASF alla quale partecipano anche le redattrici del «Frauenblatt», storica testata nata nel 1919 per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione politica, economica e sociale della donna e promuovere il suffragio femminile. Vittoria sente tutto. «Questa donna è un affronto per il nostro Paese! Senza riguardo …vi ricordate del caso Panthermantel? Terribile, semplicemente terribile» dice una. Un’altra prova a placare gli animi «Non esageriamo…», la terza risponde «Altro che! Non fa altro che mettersi in mostra! Nessun rispetto per tutte quelle donne che da decenni lottano con strategia e diplomazia per i diritti femminili.» E all’indomani delle votazioni del 1959 non perdono tempo ad addossarle tutta la responsabilità della sconfitta. Quando nella realtà, come ci racconta la splendida lumaca che nel 1928 sfila al corteo organizzato all’interno dell’Esposizione nazionale svizzera del lavoro femminile (SAFFA), l’unica verità è stata la lentezza consapevole e ingiusta della politica nel riconoscere alle donne un diritto tanto fondamentale che le sorelle tedesche avevano ottenuto nel 1918, quelle inglesi nel 1928 e l’Italia nel 1945.
Rahel Senn dunque intreccia due storie e due punti di vista, quello di Iris e di Vittoria, usando la tecnica del montaggio. Rafforza il primo con dei passaggi tratti dall’opera di Iris che tanto fu osteggiata. Eppure per lei il principio di tutto era tanto semplice quanto lineare: «A fare di me una femminista è stata la semplice sete di vita. Tutto ciò che il cuore desiderava: avventure selvagge, orizzonti lontani, prove di forza avvincenti, indipendenza, libertà – la vita pulsante insomma, tutto ciò che nei fatti, nelle parole e nella scrittura sembrava essere riservato soltanto agli uomini».
Peccato aver capito tutto troppo tardi.
Bibliografia
Rahel Senn, Ozelot, Basilea, Zytglogge Verlag, 2021.