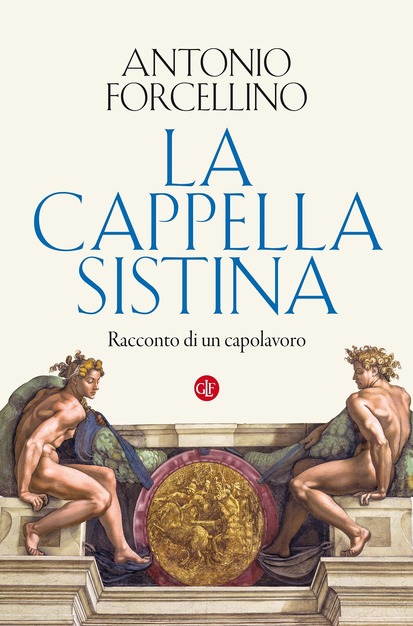La storia raccontata da Antonio Forcellino, restauratore e grande studioso dell’arte del Rinascimento, nel saggio Storia di un capolavoro, comincia a Otranto, la mattina del 28 luglio del 1480. Quel giorno una flotta turca sbarca sulle spiagge degli Alimini con tanto di cavalli e cannoni; su uno dei vascelli Gedik Pascià in persona, uomo di fiducia di Maometto II, conquistatore della seconda Roma autoproclamatosi imperatore ed erede dei romani che ora presentava il conto all’Occidente. Quell’assedio, che si conclude con un massacro, mette di fronte gli stati italiani, in quel momento intenti a farsi la guerra fra loro, alla necessità di allearsi per neutralizzare quella che è una reale minaccia all’integralità territoriale della penisola, ma anche al primato spirituale del papato e quindi della legittimità del cristianesimo come erede della civiltà romana.
Questo è lo sfondo storico-politico alla grande impresa artistica della Cappella Sistina, i cui lavori di ristrutturazione ex novo sulle fondamenta della Cappella Magna, erano cominciati tre anni prima, nel 1477 e s’inserivano nel programma di ricostruzione avviato da Sisto IV, fine teologo e dotato di grande energia politica. Proprio nel 1480 – ultimata la decorazione della volta con un cielo stellato – si andava cercando una soluzione per decorare rapidamente le grandi pareti; i documenti attestano la furia e la fretta di Sisto IV che voleva affermare così anche il proprio programma politico e religioso. Inoltre c’era la necessità di sfruttare l’enorme impalcatura utilizzata per decorare la volta.
Una prima grande novità sarà quella di affidarsi non a un singolo pittore, ma a un consorzio di pittori reclutati in quello che era il centro dell’arte più avanzato dell’epoca: Firenze. I grandi affreschi alle pareti laterali saranno affidati quindi a quattro grandi nomi: Botticelli, Ghirlandaio, Perugino e Cosimo Rosselli. A questo punto il racconto di Forcellino, che attinge sempre direttamente alle fonti, scende nei dettagli svelando i retroscena del cantiere, documentando le logiche economico-finanziarie che stavano dietro a una tale impresa; il compenso degli artisti dipendeva per esempio anche dal numero delle figure affrescate in una singola scena, e sul preventivo incidevano i materiali pregiati, come oro e lapislazzuli, che davano prestigio a un’opera che si voleva propagandistica.
Le scelte artistiche erano infatti condizionate anche da aspetti tecnici e materiali come la struttura delle impalcature, la necessità di lavorare senza ostacolare le funzioni religiose, la rapidità di esecuzione richiesta dalla tecnica dell’affresco, che vedrà l’affiancamento di altri pittori – fra i quali Pinturicchio e Luca Signorelli – per garantire anche l’omogeneità stilistica e la continuità narrativa delle «storie». Tutto è teso a razionalizzare l’intero processo produttivo.
Il racconto si fa ancora più appassionante con l’entrata in scena di un altro gigante del Rinascimento, Michelangelo: scelto da Giulio II Della Rovere – papa dal 1503 – per portare a termine un progetto ambizioso, la decorazione della volta della Sistina. Anche in questo caso alla base c’è un preciso intento politico: liberare lo Stato Vaticano dalle mire di eserciti stranieri e glorificare il proprio pontificato. Il papa intuisce che quell’intemperante artista fiorentino «sarebbe stato un alter ego capace di comprenderne le passioni e di tradurle in immagini».
La nuova impresa prende avvio fra il 1507 e il 1508, anno in cui Raffaello, che di lì a poco ruberà la scena pubblica all’artista divino, già alle prese con la decorazione delle Stanze Vaticane con la così detta Scuola d’Atene, firma il manifesto della rinascita intellettuale e culturale voluta da Giulio II nel segno di un recupero della mitica età dell’oro.
Quando Forcellino svela i retroscena della pittura di Michelangelo, quasi fossimo lì insieme a lui sui ponteggi a qualche centimetro dalle pareti, emerge la sua anima di esperto restauratore che ha lavorato anche al Mosé michelangiolesco. Le forzature anatomiche espressive di quel grandioso racconto di corpi si spiegano con la sfida di dipingere su una superficie curva e il fatto di dover essere visibili a venti metri dal suolo: elementi che rendevano necessario l’uso dello scorcio prospettivo. Michelangelo rivoluziona il linguaggio pittorico, con una nuova rappresentazione della fisicità corporea, ma anche il rapporto fra committente e artista, ormai divenuto intellettuale conscio del proprio ruolo, anche politico (esige compensi sostanziosi).
Raffaello dal canto suo rinnova la tradizione di bottega rinascimentale; la sicurezza del suo genio gli consente di riorganizzare il lavoro dell’atelier puntando sul lavoro collettivo, mantenendo comunque il controllo grazie alla minuziosa progettazione dei disegni preparatori, come nel caso dei fastosi arazzi intessuti d’oro commissionatigli da Leone X per ornare le pareti della Cappella Magna, «diventata ormai luogo di celebrazione della grandezza dei papi moderni ma anche della stessa civiltà cristiana».