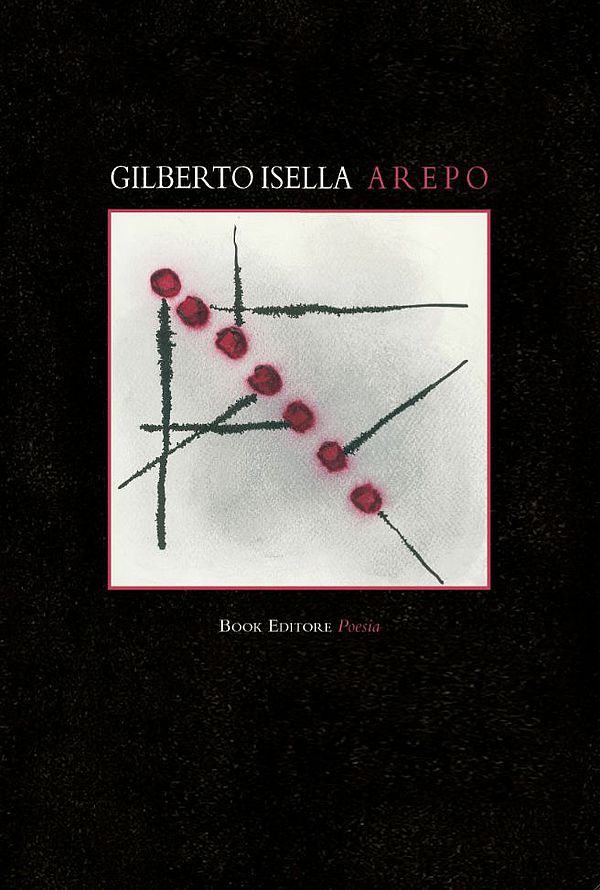Recensendo nel giugno del 1989, su queste stesse pagine, la prima raccolta poetica di Gilberto Isella (Le vigilie incustodite, Casagrande), Giovanni Orelli scriveva parole che si sarebbero rivelate profetiche: «Isella non gioca le sue chances, le sue “puntate”, sulla immediata leggibilità (se il problema della poesia fosse di farsi capire ‒ è stato giustamente detto ‒ nessuno scriverebbe poesie). Certo è che Isella, per un bel po’ di tempo, non si scuoterà più di dosso l’epiteto inflittogli di arduo», invitando però subito il lettore, sulla scorta di Gerard Manley Hopkins e del suo Naufragio del Deutschland, a leggere «senza eccessivamente occuparsi di capire», facendosi portare cioè da una lingua in cui i suoni e le accensioni improvvise di senso giocano un ruolo fondamentale.
A trent’anni (e centinaia di versi) di distanza le parole di Orelli sulla poesia di Isella non hanno perso un’oncia del loro valore, se ancora si possono riproporre a introduzione dell’ultimo libro, Arepo, uscito, come molti altri in anni recenti, presso l’editore Book di Ferrara. L’autore offre al lettore una chiave d’accesso nella parola stessa del titolo, rovescio di «opera» e parte del cosiddetto quadrato del Sator: sator arepo tenet opera rotas, celebre palindromo latino di significato oscuro, ma che nell’immagine del seminatore e del carro potrebbe alludere all’esercizio stesso della scrittura.
In una nota al testo Isella afferma di apprezzare, in quell’antico quadrato magico, la «potenza combinatoria del linguaggio», e sono parole che pesano in un’ottica di interpretazione della sua poetica. Non usa il termine «gioco» (che lo avrebbe portato semmai dalle parti dell’Oulipo) bensì «potenza», come a dire che la forza stessa della parola poetica è insita nel suo linguaggio, si scatena mentre si svolge sulla pagina, accostamento dopo accostamento, riga dopo riga.
A uno sguardo macroscopico il libro dialoga, grazie a frequenti citazioni in esergo, con autori di ieri e di oggi, con i quali Isella mostra evidenti consonanze o anche soltanto debiti di riconoscenza (da Giovan Battista Marino a Paul Celan, da Roland Barthes a Cesare Viviani passando per Caproni, Cattafi, Walpole, Yourcenar e molti altri). Bastano questi pochi nomi per proiettare il libro su una prospettiva europea, e nemmeno mancano, oltre i confini della cultura letteraria, precisi riferimenti all’ambito figurativo, cui l’autore guarda con interesse da sempre: qui in direzione di Alessandro Magnasco (1667-1749) e Giovanni Battista Piranesi (1720-78), dedicatari di due sezioni della raccolta, ma anche di Paul Klee che ispira una notevole prosa poetica al centro geometrico del libro.
Chiedersi come funzioni, nello specifico, la lingua poetica di questa come di altre opere di Isella significa porre attenzione essenzialmente alla dimensione sintagmatica, a come cioè le parole si accostino alle altre in modo non banale, rispettando la regola aurea manzoniana degli «accozzi inusitati di vocaboli usitati» (Del romanzo storico). Isella se ne serve al meglio nei nessi tra aggettivo e sostantivo, in forme quali «fiore assente», «ragno refrattario», «tendine pensante», «torre flagellata», «transfisico pallore», e si potrebbe continuare a lungo.
Più in generale, la lezione di uno dei massimi autori italiani del Novecento, Eugenio Montale, mi pare ancora ben presente all’estensore di questi versi (ne è debitore soprattutto il lessico) e non sarà un caso: pochi come Montale hanno saputo fare della poesia un luogo in cui la lingua potesse esprimersi al massimo del suo potenziale, uno spazio in cui, in forza di una sacralità mai venuta meno nonostante il disincanto degli ultimi anni, potessero ancora accadere miracoli. Di questi momenti di eccezione la poesia di Isella è ancora alla ricerca, come il primo giorno.