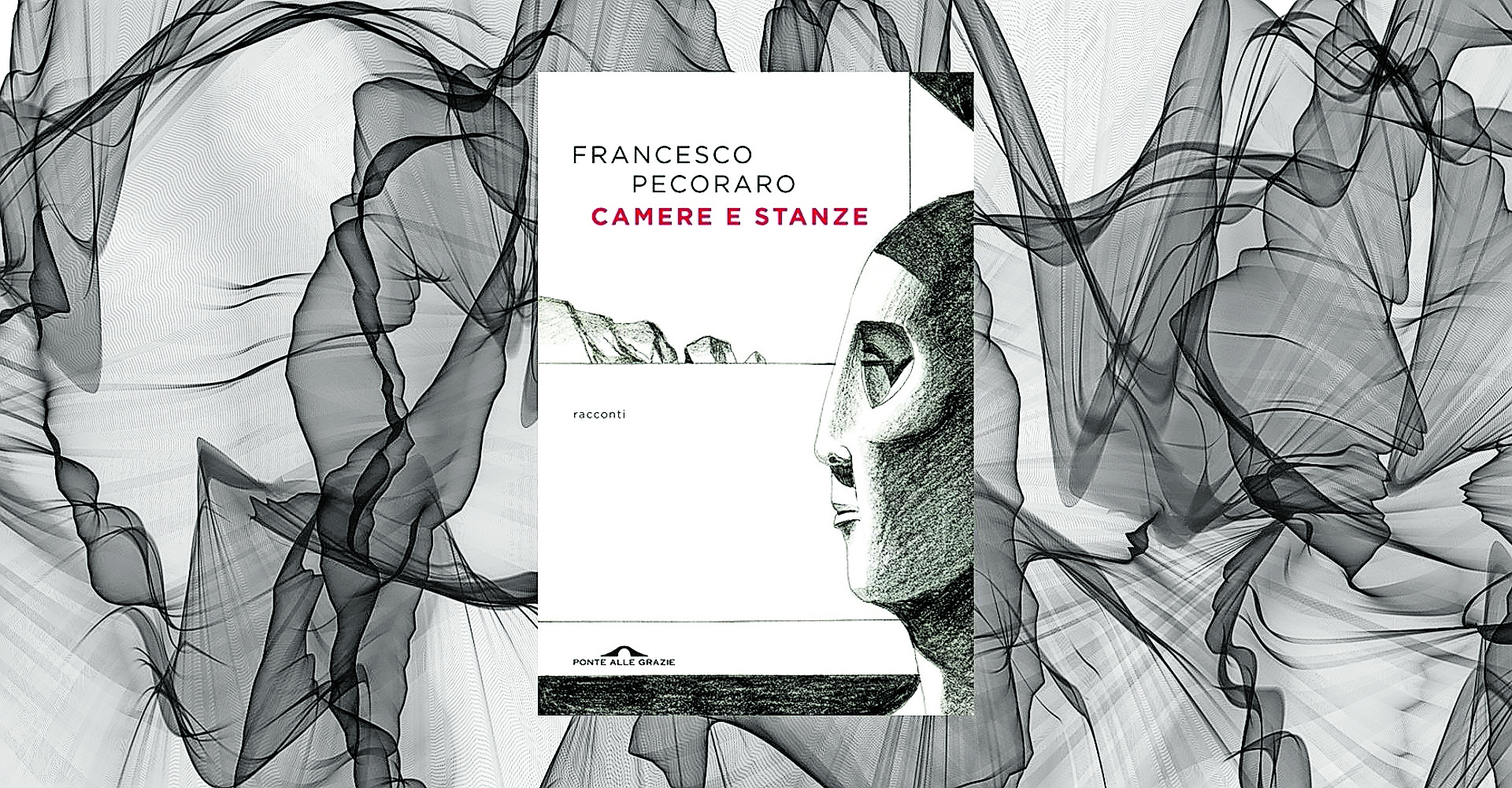«Il rettangolo prevale sul mondo, sull’umanità e sui pittori, da sempre: l’architettura e la città non sono altro che un’accozzaglia di rettangoli, un quaderno è rettangolare e così un letto e una stanza e una porta e una finestra, le strade sono solo lunghi rettangoli. Nessuno è libero dal rettangolo».
Così riflette un pittore, ossessionato dal vincolo imposto dalla tela che ha di fronte. Una forma che ha tuttavia anche una funzione utile nel suo lavoro: «direi che a me tutto sommato il rettangolo serve per finire il quadro: si esaurisce la superficie disponibile e io smetto di dipingere. Certo, non è che smetto di colpo, ma il rettangolo mi aiuta. Devo costringermi a smettere, perché se fosse per me ritornerei all’infinito sulla tela per correggere e modificare».
Un giorno un amico gallerista gli fa una proposta: ha affittato un capannone e ha deciso di inaugurarlo con sei installazioni, affidate ad altrettanti artisti. Una sarebbe per lui, basta che non superi la cifra di cinquemila euro per i materiali. Il pittore ci pensa un po’ su, in fondo lui non fa installazioni. Poi però vede lo spazio che gli verrebbe assegnato (un locale quadrato di sei metri di lato, alto quattro: ancora una serie di rettangoli!) e si convince. Si porta un frigorifero e un letto-poltrona. Decide subito che non dipingerà la parete della porta, ma solo le altre tre. Inizia quindi a lavorare in senso orario. Quando ha ultimato il giro, non riesce a fermarsi e prosegue sulla pittura già stesa («qui non sento le pareti come rettangoli e tendo a ignorarne i margini»). E poi via, compulsivamente, con il terzo strato, il quarto, senza trovare una delimitazione di campo, «in un sovrapporsi di ipotesi, tutte più o meno valide e dunque intercambiabili». Si barrica nel locale («piscio nelle bottiglie di acqua minerale e caco nei barattoli vuoti di solvente che subito richiudo»), resistendo ai colpi alla porta del gallerista («Apri questa porta, imbecille! Ti rendi conto che stai qui dentro da quasi due mesi? Gli altri hanno quasi tutti finito e hanno speso meno di te»). Alla fine, stremato dalla fame e dal caldo, se ne torna a casa, almeno per una notte. Il giorno seguente trova il gallerista a osservare il lavoro svolto. Il pittore lo colpisce al volto con tutta la forza che ha («Ti ho dato il permesso di entrare?», gli urla con voce disumana), poi alza gli occhi sulla parete di destra: «c’è un azzurro che non mi piace: è troppo acceso e poco dubbioso, bisogna correggerlo».
È questo, in sintesi, uno dei racconti del libro che riunisce tutti i pezzi brevi, editi e inediti, di Francesco Pecoraro, e che credo contenga in nuce alcuni elementi determinanti per la lettura dell’intera raccolta. A cominciare dalla figura del rettangolo per il pittore protagonista, emblema della tensione tra la necessità di definire e la consapevolezza dell’impossibilità di mettere ordine nel caos del mondo, e quindi dell’esigenza di varcare i margini, in un tragico e ininterrotto (tragico perché ininterrotto) percorso di ricerca, il cui punto d’approdo non può che essere costantemente spostato verso un nuovo orizzonte di possibilità. Ciò, a ben vedere, non vale solo per il pittore, ma pure per lo scrittore: anche un libro è composto da una serie di rettangoli (sovrapposti), il cui numero deve prima o poi finire, ma senza precludere all’autore la possibilità di intervenire infinite volte entro quel perimetro. Anche la scrittura, come la pittura, può stratificarsi. A maggior ragione in un libro come questo: non una semplice operazione editoriale con lo scopo di recuperare (e rivendere) testi provenienti da sillogi già pubblicate ai quali aggiungere qualche inedito, bensì la creazione di una raccolta attraversata da nuove dinamiche interne, determinate dai rapporti tra i singoli pezzi e la loro organizzazione nel macrotesto definitivo.
Significativamente, il titolo del libro non è un insulso Tutti i racconti, bensì Camere e stanze, dal titolo del primo pezzo, che già apriva la raccolta Dove credi di andare: se stanza è «l’insieme di cose che stanno, concluse in sé» (dal latino stans, stantis), camera è «ciò che è ricoperto da una volta» (dal greco kamàra). Stanza è dunque ciò che occupa una camera e l’organizza. E non si tratta solo di un brandello della lezione che il protagonista del racconto, un professore di sociologia dello spazio, tiene ai propri studenti, ma, al pari di quella sul rettangolo, di una vera e propria riflessione metaletteraria sulla natura stessa del libro e sui suoi rapporti di forza interni.
Basti pensare alla presenza di elementi che si richiamano e si illuminano reciprocamente di significati ulteriori proprio grazie alla loro ricorrenza tra i vari racconti (significati che varierebbero nuovamente se il libro accorpasse anche i due romanzi dell’autore romano). Come il motivo del mare, ora vagheggiato da una coppia di fratelli costretta a rimanere qualche giorno in compagnia di un padre imprevedibilmente violento prima di raggiungere la madre nella casa di villeggiatura estiva; ora, al contrario, luogo in cui una coppia in crisi si rifugia sperando di rimettere in piedi una relazione incrinata. O, ancora, il suicidio, analizzato nelle sue motivazioni da un cinquantenne trovato appeso ai tubi del riscaldamento con una serie di fogli spillati nel taschino della camicia «di tessuto oxford celeste, fresca di bucato»: dieci pagine anaforicamente martellanti con qualche reminiscenza dell’Islandese leopardiano («Mi suicido per la mia incapacità, ormai comprovata ma mai accettata, di stabilire un patto termico con l’ambiente che mi circonda. Mi suicido perché un assolo di John Coltrane è un unicum assoluto, irriproducibile, enigmatico, senza possibilità di redenzione, di vera comprensione, di appagamento, di stasi, di riposo, di perdono ). Un gesto estremo che, in un altro racconto, non riesce a un artista da sempre ossessionato proprio dal suicidio mancato: «si riprese a tarda notte, ritrovandosi nudo e gelato nel proprio sangue rappreso, ma vivo».
Mi pare rispondere alla tensione tra esigenza definitoria e impossibilità di una piena delimitazione del mondo anche la presenza di generi diversi, qui riflesso dell’incessante ricerca della forma più adatta per tentare di accedere alla magmatica complessità del reale. Ci si muove dunque entro l’arco teso tra i racconti distopici e quelli più propriamente realistici, attraverso le atmosfere todorovianamente fantastiche del pezzo in cui un ragazzo, rientrando da scuola, non trova più i propri genitori, che sembrano averlo abbandonato all’improvviso.
Quello di Pecoraro è pertanto un libro fortemente e nobilmente conflittuale. Non è un caso che alcuni dei protagonisti siano artisti ingombrati dai propri modelli o alla ricerca di qualcosa di forse irraggiungibile, come il giovane pittore Bilal di Tecnica mista (già uscito in ebook nel 2014), che riuscirà a far coincidere Arte ed Esistenza solo attraverso la performance di un attentato terroristico di matrice islamica. Per tacere dei conflitti tra intimità e immagine esteriore (Happy Hour), e di quelli tra presente e passato, variamente declinati: tra genitori e figli (Uno bravo); tra generazioni diverse (Camere e stanze); nelle relazioni amorose (in Antonella ti amo la protagonista è dolorosamente costretta ogni mattina a passare sotto il cavalcavia su cui si trova, a caratteri cubitali, la dichiarazione di un vecchio amante); nelle stratificazioni urbane che hanno brutalizzato gli interstizi che separano le borgate romane dal centro. Un aspetto, questo, da sempre oggetto della serrata indagine di un autore che si spera possa varcare al più presto, con la propria scrittura, i confini di questo pur magnifico rettangolo-libro che è Camere e stanze.
Bibliografia
Camere e stanze, Francesco Pecoraro, Firenze, Ponte alle Grazie, 2021.