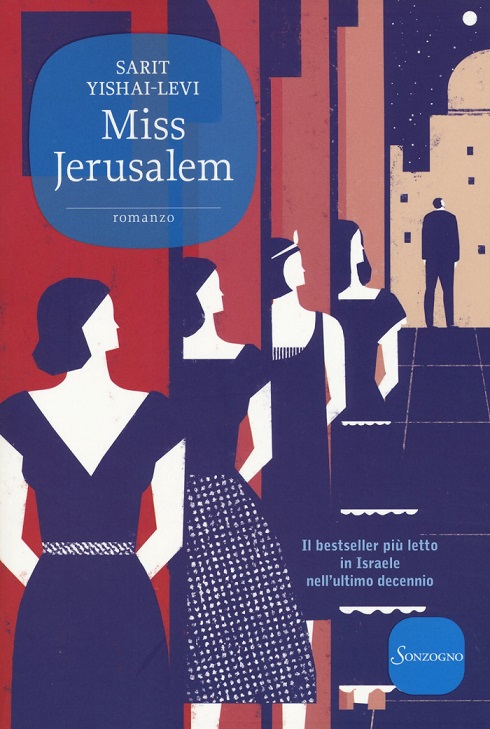Sono da poco terminate le festività ebraiche del mese di settembre e la televisione israeliana ha già ripreso la trasmissione di una delle serie di maggiore successo degli ultimi mesi, La regina di bellezza di Gerusalemme. Liberamente tratta dall’omonimo libro di Sarit Yishai-Levi, pubblicato in Israele nel 2013 e tradotto in italiano per Sonzogno con il titolo di Miss Jerusalem, la serie, dove recita anche Michael Aloni, il Kyve di Shtisel, narra le vicende degli Hermosa, una famiglia di ebrei di origine sefardita residenti a Gerusalemme nel corso del ’900. Quattro generazioni di donne sfortunate in amore e una città che cambia volto nel passaggio dall’Impero Ottomano al mandato Britannico, dalla fondazione dello Stato d’Israele agli assetti intervenuti dopo la Guerra dei Sei Giorni del ’67, fino all’epoca più recente. Sarit Yishai-Levi mi accoglie calorosamente nella sua casa a nord di Tel Aviv.
Sait Yishai-Levi, prima di scrivere La Regina di Gerusalemme Lei era nota al pubblico israeliano come giornalista. Come è nata l’idea di scrivere questo libro?
Ero una giornalista affermata. Uno dei miei servizi più importanti fu l’intervista che feci ad Arafat durante la Prima Guerra del Libano con Uri Avnery. Fu un grande traguardo andare a intervistarlo passando attraverso le truppe militari. Al termine dell’intervista ci chiese se poteva fare ancora qualcosa per noi e io espressi il desiderio di vedere il prigioniero israeliano Aaron Achiaz. Nonostante il parere contrario dei suoi consiglieri, Arafat ci permise di fargli visita. Dopo tre mesi di prigionia il poverino non aveva ancora visto un medico ed era molto confuso, ma alla fine girammo un filmato e lui ci diede una lettera da consegnare alla famiglia ad Herzliya.
Anche quella del giornalista è una professione che ha a che vedere con la scrittura, e io ho sempre desiderato scrivere un libro, ma per anni non ne ebbi il coraggio. Vedevo giornalisti come Meir Shalev e David Grossman diventare romanzieri, ma mi sentivo un po’ presuntuosa. Tuttavia, raggiunta l’età della pensione, mi emozionai leggendo il libro di Meir Shalev, Il ragazzo e la colomba, e fu per me un input. Scrissi una bozza di circa trenta pagine e senza pensarci le inoltrai all’editrice Roni Modan. Con mia grande sorpresa, dopo solo qualche ora Roni mi aveva già dato l’okay e firmai il contratto senza nemmeno consigliarmi con un legale. Da quel giorno alla pubblicazione trascorsero sei anni. A posteriori il contratto non era vantaggioso, ma il successo è stato incredibile. Mai avrei pensato che ne avrebbero tratto un film e un telefilm, e ringrazio ancora chi ha creduto in me.
A giudicare dal numero di copie vendute solo in Israele si direbbe che la Sua editrice abbia avuto un ottimo fiuto.
Roni dice di aver avuto un’intuizione, c’era a mala pena un’idea con la storia di Gabriella che nel giardino sul retro della casa dei nonni raccoglie escrementi di uccelli, porta a casa rane e si sporca i vestiti, con la madre che le dice che è una barbara e che sarebbe adatta per vivere nel quartiere curdo. Non avevo in mente la trama, ma dopo la firma mi ritrovai a scrivere su luoghi di Gerusalemme in cui non vivevo da anni. Appartengo all’ottava generazione di una famiglia nata a Gerusalemme e i miei figli alla nona, anche se sin da giovane sapevo che l’avrei lasciata appena possibile, infatti vivo a Tel Aviv da quando avevo vent’anni.
Sembra una persona dalle idee molto chiare, cosa L’ha motivata in questa scelta così netta? Io ho una casa a Gerusalemme e anche se ho scelto di vivere a Tel Aviv per comodità, provo sempre nostalgia. A volte mi sembra di essere bipolare, tanto sono diverse queste due città: Tel Aviv città di mare libera, solare e sfacciata, ma allo stesso modo alienante e superficiale, mentre Gerusalemme è malinconica, austera, carica di tensioni, ma nel contempo avvolgente, spirituale e densa di significato. Mi ricordano le due anime di mio padre e di mia madre, e sento il bisogno di entrambe.
Io non sono mai stata combattuta. Anzi, la Gerusalemme di oggi è pesante, seria, povera e ultraortodossa, nulla a che vedere con la città di prima del ’67, bohemienne, aperta e piena di studenti. Allora i charedim (gli ultraortodossi) vivevano in quartieri distinti, come Mea Shearim e Shaarei Chesed, e uscivano solo di venerdì per suonare lo shofar, il corno di montone. Ora è una città difficile e mette paura, davvero non capisco chi riesce a viverci. Sono ormai poche le isole laiche come quella del quartiere di Rechavia frequentate dai miei figli, che hanno terminato i loro studi all’Accademia di Betzalel. Mi piace Tel Aviv perché c’è il mare ed è una città libera, con persone leggere che non fanno domande, la sento più adatta al mio carattere.
Dal modo in cui parla sembra comunque che Gerusalemme Le abbia regalato un’infanzia felice e spensierata. Ci racconti della Sua famiglia.
Entrambi i miei genitori provenivano dalla piccola e coesa comunità di autentiche origini sefardite, le cui radici risalgono alla cacciata degli Ebrei dalla Spagna, in particolare dalla città di Toledo. La famiglia di mia madre, i Nachmias, è quella alla quale sono più legata ed è stata maggiormente dominante nella mia vita. Tra loro i nonni parlavano ladino e con noi ebraico. Io non sapevo il ladino fino a che non ho scritto alcune frasi per il libro, ora un po’ lo capisco ma non lo parlo. Eravamo una famiglia molto unita e usavamo trascorrere insieme tutte le festività. In occasione del seder di Pesach aprivamo tutte le porte delle stanze comunicanti nel quartiere di Ohel Moshe, Nachlaot di oggi, lo stesso dove è ambientato il libro. Ma non eravamo osservanti, sono cresciuta in una casa laica, molto israeliana e piena di cultura e di musica.
Durante la Guerra del ’48 mio padre aveva difeso la casa e mia madre era rimasta ferita. Per la giornata dedicata al ricordo dei caduti, tutti i parenti venivano da noi. Salivamo sul tetto e guardavamo dall’alto la piazza con la bandiera a mezz’asta, poi andavamo sul Monte Hertzel e la sera successiva, la vigilia di Yom Hatzmaut, ci riunivamo nuovamente per veder alzar la bandiera e festeggiare il Giorno dell’Indipendenza ballando nelle strade. I nostri vicini, la famiglia Nachmani erano ortodossi, e per rispettarli di sabato mio padre abbassava il volume della radio e non ci era permesso di mangiare panini sulle scale nel giorno di Kippur. Frequentavo gli scout ed ero molto brava nelle materie umanistiche, ma soffro di discalculia e questo non mi permise di accedere alle scuole che desideravo. Nell’esercito invece ho servito nell’unità dell’intelligence, ma non sapevo l’arabo, quindi operavo in inglese.
Quanto della storia è tratto da frammenti della Sua vita?
Il libro non è autobiografico, ma ho certamente preso spunto dalla mia vita, da personaggi e storie. L’ho scritto improvvisando, come un flusso di coscienza, la mattina mi svegliavo e rileggevo incredula. Il lasso di tempo della trama è molto ampio poiché comincia dalla metà del 1800. Benché di tutti i personaggi io appartenga solo alla generazione di Gabriella, qualcosa mi ha permesso di descrivere in modo nitido Gerusalemme in tutte le sue evoluzioni, come quella dell’epoca ottomana, con la sporcizia, le pestilenze, i morti, e quindi gli orfani. La storia di Rosa, ad esempio, è quella della mia bisnonna. Mia nonna infatti era rimasta orfana dopo che i suoi genitori erano morti di colera e, come il fratello di Rosa, anche il suo era stato impiccato dai Turchi alla Porta di Schem perché non voleva arruolarsi. A casa abbiamo una pagina di giornale in cui si riporta questa vicenda che la nonna a sua volta ci ha raccontato un’infinità di volte.
Leggendo il romanzo sono stata colpita dal taglio dato ai personaggi femminili. Rosa e le altre protagoniste sono sposate con uomini che non ricambiano il loro amore. Insomma, una storia di donne tristi, ma molto dominanti, sullo sfondo di un ambiente patriarcale.
L’accezione dominante è una caratteristica che contraddistingue solo me e non le altre donne della famiglia. Quella dell’amore non corrisposto invece è una sorta di maledizione famigliare. Rafael si è innamorato di una ragazza con gli occhi blu intravista a Tsfat che ha continuato a sognare pur rispettando la moglie Marcada. Rosa invece riesce nella scalata sociale, ma paga un prezzo molto alto perché Gabriel non la desidera e la condanna a vivere senza amore. Così è per Gabriella, che rifiuta l’amore di Amnon, e persino per Luna, che fallisce in amore finché perdura la sua bellezza.
Inoltre Luna ha sofferto di depressione post-partum che ai tempi non si diagnosticava: non dava da mangiare a Gabriella e non se ne prendeva cura. Rosa invece è una donna infelice. Rimasta orfana quando aveva undici anni, lavava i bagni degli inglesi e raccoglieva i resti di cibo al mercato per crescere il fratello che diventerà alcolizzato e problematico sino a vivere da fuggitivo perché ricercato per omicidio. Tuttavia è molto forte e si occupa della casa nel momento in cui il marito si ammala.
Anche le figure maschili sono vittime di matrimoni infelici, ma risultano più deboli rispetto alle mogli.
Sì, ad esempio Gabriel rinuncia all’amata Rochel per volere della madre che gli fa credere di aver provocato la morte del padre. Rende infelice la moglie e ama la figlia Luna in maniera eccessiva e quasi malata.
Quale messaggio pensa di aver trasmesso ai lettori alla fine dei conti?
Durante la stesura non avevo un’agenda, anzi fino alla fine ho temuto che la mia storia non piacesse e posticipavo la consegna. A posteriori, tuttavia, molte persone mi hanno ringraziato per aver gettato luce sulla comunità dei cosiddetti «sefarditi puri» parlanti ladino, un gruppo rimasto un po’ nell’ombra benché vanti esponenti di spicco come David Ben Benisti, Ytzhak Navon, Yoram Gaon e lo scrittore Abraham Yehoshua. Famiglie come i Valero, gli Hermosa, gli Abulafia e i Siton risiedevano in Terra d’Israele da generazioni, erano di condizioni agiate ed erano considerate «élite» anche rispetto alle immigrazioni askhenazite di studiosi di accademie talmudiche, gente molto povera e poco acculturata.
Il divario tra ashkenaziti e sefarditi, e il sentimento di inferiorità di questi ultimi, risale agli anni ’50 con l’arrivo dei mizrachìm, gli ebrei provenienti dai paesi arabi. Il termine sefardita infatti confonde proprio perché dalla fondazione dello Stato ha cominciato a includere anche questi ultimi. Comunque per me queste differenze sono irrilevanti. La mia è una storia israeliana e come è noto Israele è un crogiuolo di popoli.
Come è stato accolto il libro all’estero?
Negli Stati Uniti il libro è molto popolare soprattutto tra gli ebrei. Le presentazioni sono andate molto bene anche in Italia, nonostante la palese ignoranza di alcuni giornalisti sulla storia ebraica e israeliana. Una delle soddisfazioni maggiori è stata scoprire che in Turchia si studia il mio libro nei corsi di letteratura straniera per conoscere la storia di Gerusalemme e i cambiamenti intervenuti nel corso delle dominazioni. In quasi cinquecento anni di dominazione turca non è stato fatto niente per la città, mentre gli inglesi in meno di quarant’anni hanno collegato elettricità e acqua e costruito strade, tutti li odiavano ma hanno fatto tanto.
Come vive il successo della serie televisiva tratta dal libro?
La serie è molto diversa dal libro, e va bene così, bisogna separare le due cose. A causa della mia ambivalenza ho deciso da subito di prendere le distanze e non collaborare alla scrittura della sceneggiatura. Sapevo che avrebbero modificato la storia ma ho chiesto io che Michael Aloni interpretasse il personaggio di Gabriel. Alla fine abbiamo deciso di girare a Tzfat perché Gerusalemme non era adatta e mi hanno anche ripresa durante il matrimonio di Gabriel e Rosa. La cosa più difficile è stata vedere Luna entrare in un pub di inglesi. Non era adatto che una brava ragazza di buona famiglia andasse in luoghi del genere, è stata un’esagerazione!
È possibile dire che il successo di Miss Jerusalem Le ha cambiato la vita?
Sì, non sono più considerata una giornalista, bensì una scrittrice e ricevo manifestazioni di stima e
considerazione nuove per me. Sono stata fortunata, per questo il mio messaggio è «non rinunciate al vostro
sogno, non importa l’età, credeteci!».