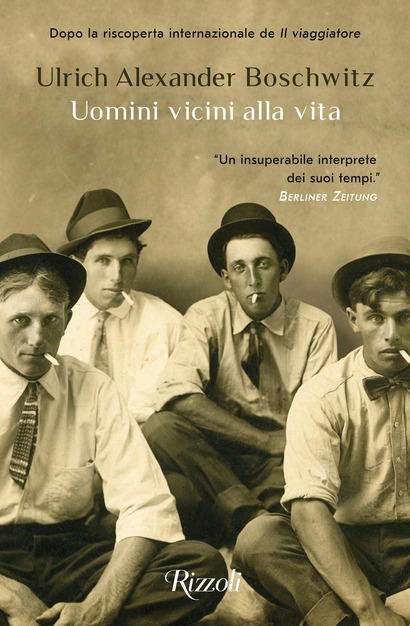Scrittore israeliano classe 1965, Yishai Sarid, figlio del noto giornalista e politico Yossi Sarid, vive a Tel Aviv dove lavora come avvocato. Il poeta di Gaza (E/O 2012), suo secondo romanzo, ha vinto in Francia il Grand prix de littérature policière nel 2011.
Ne Il mostro della memoria Sarid affronta il tema della Shoah da un’interessante prospettiva critica che offre al lettore straniero una nuova finestra sulle sfide e le contraddizioni della società israeliana contemporanea. Il libro è strutturato sotto forma di una lettera accorata che il protagonista, storico ricercatore dei meccanismi di sterminio, nonché guida e accompagnatore di studenti, politici ed esponenti dell’esercito nelle visite ai campi nazisti della Polonia, rivolge al direttore dello Yad Vashem, il Museo Nazionale Israeliano dedicato alla Shoah. Il mostro della memoria è stato annoverato dal «New York Times» tra i 100 migliori libri del 2020.
Figlia della «seconda generazione», come si usa dire qui in Israele, ho ereditato il trauma della Shoah nel patrimonio genetico, sperimentandolo emotivamente, sin da piccolissima, attraverso le figure dei miei nonni paterni, entrambi unici superstiti di due famiglie sterminate. Tuttavia, solo quando, una volta trasferitami in Israele, mi si presentò l’occasione di frequentare dei corsi sul tema proposti dall’Università Ebraica di Gerusalemme, ebbi modo di comprendere realmente la complessità del meccanismo della memoria e le insidie nascoste nel suo seno.
Fu allora che sentii parlare per la prima volta del rischio di ridurre la Shoah a una memoria autoreferenziale, o peggio, di manipolarla, utilizzandola per giustificare azioni poco etiche, e sollevare domande sulla necessità di onorare le vittime dello sterminio ebraico senza incorrere in simili trappole. Se questi e altri interrogativi fanno parte integrante del dibattito intellettuale israeliano, in Europa, pressoché ogni tentativo di approcciare la questione con spirito critico viene tacciato di antisemitismo, anche quando a sollevare le critiche sono gli stessi ebrei. Soprattutto in Germania da anni è in atto una vera e propria caccia alle streghe che esclude dalla scena esponenti della cultura che muovano critiche di sorta a Israele o alle sue politiche della memoria.
È per tali ragioni che sono stata particolarmente lieta di apprendere dell’avvenuta traduzione italiana del libro di Yishai Sarid e oggi ne parlo con l’autore.
Partiamo dall’inizio, cosa l’ha condotta a scrivere sulla Shoah e come è nata l’idea di questo libro?
La domanda corretta da porre a uno scrittore israeliano è piuttosto «come evitare» di scrivere sulla Shoah, evento che ci coinvolge sia sul piano privato sia su quello collettivo, rivestendo un ruolo centrale nelle nostre vite. Da sempre ho letto molto su questo argomento, da libri di storia a memoir, da articoli di giornale a interviste, ma ci è voluto molto tempo perché maturassi l’idea di scrivere qualcosa anch’io. Se da un lato mi era chiaro che non avrei inventato una fiction sulla Shoah – ci sono già sei milioni di racconti veri – dall’altro non sono uno storico, quindi nemmeno un libro di saggistica faceva al caso mio. Poi nel 2015 sono partito per la Polonia, ho noleggiato una macchina e per circa due settimane ho visitato tutti i campi di sterminio polacchi. Al ritorno in Israele ero emotivamente molto provato. All’improvviso tutte le letture fatte negli anni erano divenute concrete e tangibili, così ho optato per un protagonista storico, cercando di non inventare nulla.
Se vogliamo andare ancora più indietro nel tempo il mio cognome in ebraico significa «superstite». Mio nonno si chiamava Yaakov Shneider ed era emigrato in Israele dalla Polonia negli anni 30. Faceva l’insegnante e, alla fine della Guerra, nel 1945, decise di tornare in Europa per insegnare ai bambini dei campi di transito e prepararli in vista dell’arrivo in Israele. Fu lì, in un villaggio dell’Ucraina (allora Polonia), che modificò il nostro cognome in Sarid. Anche da parte di mia madre, del resto, molti parenti furono sterminati. Si tratta dunque di un trauma famigliare, prima ancora che nazionale. Inoltre, il fatto di essere da sempre spettatore della manipolazione della memoria ha costituito un’ulteriore motivazione a scrivere. La memoria infatti non rimane congelata, bensì muta nel tempo e se ne fa uso in negativo.
La prospettiva scelta è davvero rappresentativa del suo pensiero sulla Shoah? Come si pone rispetto alla definizione di A.B. Yehoshua della Shoah come «sconfitta» del popolo ebraico?
La cosa bella della prosa è che puoi scrivere tanto le cose belle quanto quelle brutte, comprese cose che non dirò in questa sede. Non sono per forza le mie opinioni sul piano razionale, ma si tratta senz’altro di pensieri che mi sono passati per la mente. Per quanto riguarda l’affermazione di Yehoshua, non la condivido.
Gli ebrei non possedevano un esercito, né costituivano una nazione o un’entità dal punto di vista internazionale. Non avevano alcuna possibilità di opporsi, e non ritengo giusto attribuire loro colpe o responsabilità. Piuttosto, poiché si tratta di una ferita aperta, di un trauma irrisolto che ci domina sino a oggi, vi proiettiamo questioni come l’impotenza o il collaborazionismo al quale sono stati costretti gli ebrei con la forza.
Rimaniamo sul tema della responsabilità. Nel libro lei parla molto della responsabilità dei tedeschi, poco di quella dei polacchi e, solo raramente, fa accenno a un’eventuale responsabilità degli ebrei.
Ribadisco, oggettivamente non si può parlare di responsabilità degli ebrei. Dal Sonderkommando allo Judenrat, tutto faceva parte degli ingranaggi perversi del piano nazista che delegavano il lavoro sporco agli stessi ebrei. Per quanto riguarda i polacchi, non sono stati loro ad aver messo in atto la Shoah. In definitiva non si può sottrarre responsabilità ai tedeschi attribuendola ad altri. Per non parlare delle assurde proporzioni assurte dal «romanzo» Israele-Germania. Non che io sia contrario alla Realpolitik, né all’importanza di una riconciliazione, ma sorge la domanda come sia possibile che in pochi anni non abbiamo stabilito solo rapporti di amicizia, bensì una relazione d’amore sin troppo intima.
La capisco. A casa mia era proibito studiare il tedesco, così come comprare lavatrici o macchine tedesche, mentre oggi un israeliano su due si trasferisce a Berlino come se niente fosse. Mio padre si rivolterebbe nella tomba. D’altra parte i tedeschi non hanno agito da soli, penso ad esempio al mito del «bravo italiano» oggi finalmente rimesso in discussione dagli storici. Ma non va bene neppure la narrativa dell’ebreo come vittima eterna...
Certo che no, oggi poi oggettivamente non siamo più vittime, siamo forti e abbiamo un nostro Stato. In generale ritengo che, come tutti, l’ebreo possa essere tanto vittima quanto carnefice.
Uno dei temi centrali del libro è quello della didattica della Shoah, in particolare dei viaggi-studio organizzati dalle scuole israeliane per gli studenti di liceo.
Nel 1983 avevo 18 anni, frequentavo la classe dodicesima e ho partecipato al primo viaggio organizzato per adolescenti. La Polonia era allora sotto il regime comunista del generale Jaruzelski. La verità è che mi sono divertito molto, allora poi non si andava tanto all’estero come oggi, e tutto mi apparve sostanzialmente romantico e avventuroso. A quell’età si è anche un po’ immaturi, facilmente impressionabili o manipolabili.
Così, anche se avevamo studiato la storia, la visita non sortì in me neppure lontanamente l’impatto emotivo della seconda che ha preceduto la stesura del libro. Il messaggio che recepii come studente è che gli israeliani devono essere molto forti affinché la tragedia non accada di nuovo. Successivamente mi arruolai e frequentai il corso ufficiali. In totale ho servito nell’esercito per sei anni. Lo racconto perché, se da un lato sono convinto che sia meglio che siamo forti come nazione, nel libro mi chiedo se questo debba o possa essere l’unico lascito della Shoah a favore degli ebrei israeliani.
Nel Mostro lei si sofferma anche sulle sottili differenze tra studenti di origine ashkenazita, per i quali la Shoah fa parte della storia familiare, e quelli di origine sefardita orientale, le cui famiglie provengono per lo più dai paesi arabi. Vi è anche la questione dell’insegnamento della Shoah all’estero, ai non ebrei. Da una parte, da quando hanno stabilito il Giorno della Memoria vengono investiti grandi sforzi, tuttavia l’antisemitismo è in aumento in tutta Europa, Liliana Segre deve vivere sotto scorta e gruppi neonazisti fanno irruzione alla presentazione di libri sulla Shoah.
Prima del Covid ho avuto modo di viaggiare molto per la presentazione del libro. Sono stato in Germania, in Austria, Francia e Spagna. La mia impressione è che in Germania si studi la Shoah, ma che sia diventata una memoria congelata nel tempo, un argomento sacro che è meglio non toccare né indagare troppo. In questo senso la Shoah è sempre meno rilevante per i giovani tedeschi, che si rapportano agli anni della II Guerra mondiale come noi al XIX secolo, non comprendendone la rilevanza per la vita di tutti i giorni. Tale fenomeno, secondo me, spiega anche il ritorno dell’antisemitismo e dei vari fascismi in Europa.
A mia volta io sono israeliano e sionista, e penso che Israele abbia ragione e diritto di esistere. Tuttavia, negli incontri che ho avuto, il libro, grazie agli interrogativi in esso sollevati, ha sortito l’effetto di rendere l’argomento più attuale e rilevante per il presente. Non mi fermo al messaggio «c’erano una volta i tedeschi cattivi che hanno ucciso gli ebrei buoni», bensì porto l’attenzione sulla responsabilità di ognuno, sull’importanza di salvaguardare le istituzioni democratiche e di ribellarsi alle forze che cercano di imporsi.
Vorrei condividere con lei una percezione suscitatami dal suo libro. Per circa tre quarti della lettura avevo l’impressione di trovarmi di fronte a un’audace parodia critica di quella che in Israele è diventata una vera e propria industria della Shoah. L’ossessione per lo studio dei meccanismi di sterminio nei minimi dettagli, che avuto origine anche da considerazioni di natura puramente economica, conduce infatti lo storico israeliano protagonista sull’orlo del baratro. Tuttavia, verso la fine, ho avuto la sensazione che abbia fatto un passo indietro, dando una sorta di convalida all’inevitabile uso della forza, come se non vi fossero reali alternative in risposta all’antisemitismo, che quella di rinchiudersi in ghetti rafforzati e militarmente protetti. Penso anche al timore costante da parte degli ebrei della diaspora che, criticando Israele o le sue politiche della Memoria, non si faccia che alimentare l’antisemitismo. Si tratta di un atteggiamento pericoloso per l’ebraismo europeo che rischia di ripiegarsi su sé stesso impoverendosi culturalmente.
Questa è un’ottima domanda che non mi viene posta spesso. A Yad Vashem il libro non è stato gradito proprio perché è molto critico. Parla infatti del complesso che abbiamo come israeliani con l’uso della forza. Se si ricorda, uno degli studenti dice a un certo punto che per sopravvivere nel mondo «bisogna essere un po’ nazisti». Il problema è che la Shoah costituisce oggi la scusa e la giustificazione a ogni utilizzo della forza da parte degli ebrei e di Israele, a cominciare dall’occupazione che è di per sé negativa e contraria ai valori ebraici e universali.
Come pensa allora che si possa esercitare nella pratica un utilizzo critico della memoria?
Per quanto riguarda la memoria, proporrei, ad esempio, di non recarci solo negli ultimi luoghi della morte, come le rampe o le fosse delle uccisioni di massa, dove tutta l’attenzione dei visitatori è focalizzata sulla condotta dei tedeschi. Interessarci della vita degli ebrei in Europa prima della Shoah potrebbe essere un modo migliore di onorare le vittime, piuttosto che rivederle umiliate negli ultimi attimi come delle ombre impotenti. Altrettanto importante è insegnare ai bambini a opporsi a fascismi e razzismi di ogni sorta. Credo che politicamente si possa essere critici nei confronti di Israele scrivendo cose anche abbastanza pesanti come quelle del libro e, ciò nonostante, essere israeliani sionisti e patrioti.
Come si è sentito quando ha presentato il libro all’estero? E soprattutto, come pensa che il libro possa contribuire al discorso sulla memoria fuori da Israele?
Ogni posto è a sé, ma in generale il rapporto con il pubblico europeo o comunque non israeliano è molto importante per me, anche perché i miei potenziali lettori israeliani sono relativamente pochi. In Germania alcuni incontri si sono rivelati tesi, e non mi sono stati facili a livello personale. In altre parti del mondo, ho potuto parlare al pubblico più apertamente. Io non cerco né commiserazione né scuse. Sono critico verso tutte le parti in causa e propongo di parlarci alla stessa altezza.
L’intervista è terminata e a Tel Aviv siamo giunti al quarto lockdown. Pur non condividendo molte delle posizioni di Sarid, ritengo ancora che Il mostro della memoria offra forse per la prima volta al lettore di narrativa in lingua italiana una gamma più ampia di prospettive, che coniuga sapientemente razionali attribuzioni di responsabilità, retaggi emotivi e traumi irrisolti, consentendo di affrontare il Giorno della Memoria con rinnovata consapevolezza.