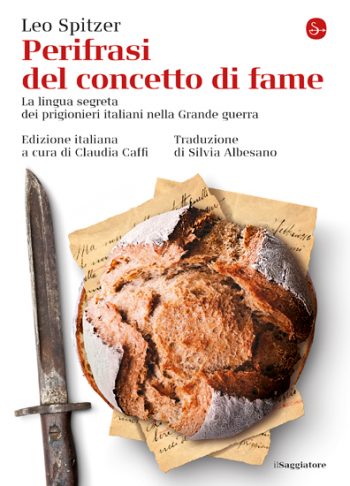«L’uso della lingua italiana, è cosa detta e ridetta, non esiste. Ne consegue che quel siciliano e quel piemontese non del tutto illetterati, messi insieme a parlare, dovranno accontentarsi di arrotondare alla meglio i loro dialetti».
Una polemica, sorda ma insistente, si aggira per la linguistica italiana. Ha origine da quella che fino a poco fa era considerata una certezza: la radicale distribuzione reciproca di ruoli e situazioni tra italiano e dialetti sul territorio nazionale, che risale ad asserzione storica di Tullio De Mauro, studioso e simbolica istituzione della disciplina, pilastro portante dai cui preavvisi passano gran parte delle conquiste della sociolinguistica del Paese, di ieri e di oggi. Per farla breve, per secoli e ancora per qualche decennio dopo l’Unità, il panorama linguistico avrebbe visto due sistemi, il dialettale e l’italiano, ben separati e specializzati: i dialetti sarebbero stati esclusivamente parlati (come oggi) e l’italiano quasi solo scritto; i primi appannaggio della quasi totalità dei parlanti, non alfabetizzati in lingua, il secondo a disposizione di classi, usi e abitudini comunicative alti. Da qui, tutta una serie di ricadute, di panorama linguistico e anche di struttura: il nascere e il crescere, una volta fatta l’Italia e gli italiani, di una serie di varietà di lingua contaminate, come gli italiani regionali, le varietà popolari, una generosa tastiera di registri e lingue speciali, ma anche una grafia per ragioni storiche non troppo lontana dalla pronuncia, che rende l’italiano di più facile scrittura.
Fin qui, appunto, il Verbo demauriano. Poi, però, da poco tempo invero, uno spettro si aggira per la disciplina: l’idea che le cose non stiano proprio così, che non è vero che parlare italiano sia abitudine recente. Alcuni storici della lingua, tra i più documentati e diffusi Enrico Testa, ma, nel nostro piccolo, anche il ticinese Sandro Bianconi, hanno creduto di individuare in una serie di documentazioni di vario tipo (verbali di processi, carte per i commerci, lettere e corrispondenze ma forse anche opere teatrali che riproducono il parlare del popolino) delle supertestimonianze che invece no, l’italiano lo si parlava eccome, anche nelle classi meno privilegiate, anche negli usi più quotidiani.
Il settore diventa ora un vero e proprio filone, a metà tra la sociolinguistica e la storia della lingua, che ha anche tra le ricadute più piacevoli le stesse campionature: liste di inventario delle botteghe di mugnai toscani, lettere a morose, strazianti dichiarazioni di streghe e stregoni, fino ai biglietti di ricatto dei briganti dell’Ottocento.
La genesi di questo filone ha ora una nuova e più matura puntata nel molto ricco e intenso Pocoinchiostro. Storia dell’italiano comune, di Pietro Trifone. L’interpretazione di questa faticosa conquista della lingua nazionale si arricchisce, nella consueta vivacità di documentazione originale, soprattutto di una dimensione tutta sociolinguistica, che tiene conto delle difficoltà spesso frustrate dei parlanti delle varie regioni italiane di condividere una lingua che superasse il contesto municipale e trovasse un modo di comunicare autenticamente nazionale.
Ci sono sì brandelli di lingua italiana, che è però fortemente piegata e marcata dal dialetto sottostante. Se si alza la prospettiva sopra le torri e le mura delle città e delle piccole patrie, «bisogna ammettere che fino all’Ottocento la lingua italiana non è che scritta». Ma soprattutto che «la lingua scritta d’Italia è anche lingua parlata a Firenze e a Roma, ma in tutte le altre parti d’Italia ci si serve sempre dell’antico dialetto locale, e parlare toscano nella conversazione risulta ridicolo». Lingua per tutti ma non di tutti, insomma; per avere la vera lingua nazionale che altri hanno avuto molto presto si aspetterà il pieno Novecento, l’unità politica, la scuola, e secondo acquisizione nota, la televisione.