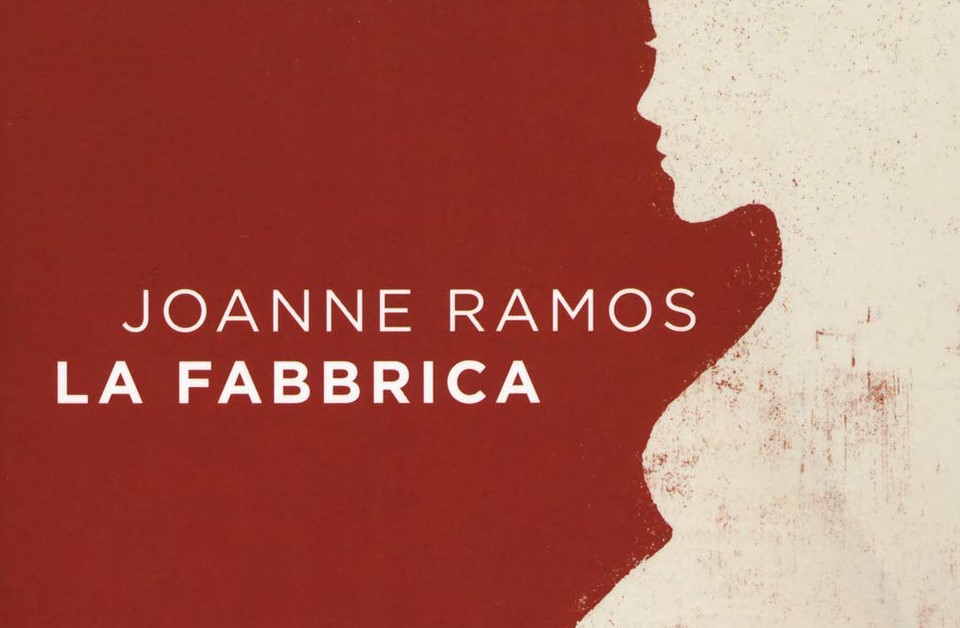Ogni questione sensibile merita di essere affrontata con rispetto e delicatezza direttamente proporzionali alla sua complessità. In questo, la letteratura gode di un singolare privilegio: la possibilità di trasfigurare la realtà e le sue problematiche, dando forma a contesti immaginari e personaggi d’invenzione, in modo da contemplare gli interrogativi di ieri e di oggi da una distanza salutare, senza restare prigioniera delle inquietudini presenti o affrettarsi a scagliare la prima pietra contro i presunti colpevoli.
È quel che accade, in modo molto evidente, nella fortunata tradizione del romanzo distopico, che descrive scenari futuri o alternativi in cui ideologie, conflitti e drammi reali vengono rispecchiati e deformati all’eccesso, in modo da rivelare tutto il loro potenziale negativo. Ai lettori verrà senz’altro alla mente l’esempio di 1984, capolavoro di George Orwell del 1949, in cui si immagina la sete di controllo assoluto dei regimi totalitari novecenteschi potenziata all’estremo da raffinati mezzi tecnologici. Va da sé che quanto più la narrativa distopica sa adombrare il volto del presente, pur rimodellandolo, tanto più ne guadagna in efficacia.
Il romanzo d’esordio di Joanne Ramos, autrice statunitense di origini filippine, si inserisce di diritto in questa tradizione, conseguendone gli obiettivi con una fortunata combinazione di grazia e incisività. In questo caso, la realtà parallela, tratteggiata con limitate licenze poetiche sullo sfondo della campagna newyorkese, è un contesto in cui la mercificazione della maternità surrogata ha ormai raggiunto un livello industriale.
Golden Oaks è una lussuosa clinica immersa in un paesaggio naturale idillico, dotata di ogni possibile confort materiale o gadget tecnologico per garantire il benessere delle Ospiti che vi trascorrono i mesi della gravidanza. Sono a disposizione palestre per praticare yoga e la dieta è scrupolosamente calibrata. Ma le Ospiti, selezionate e controllate con attenzione maniacale, sono identificate con numeri progressivi e portano in grembo i figli delle Clienti, a loro volta classificati secondo il potere d’acquisto della madre biologica. A Golden Oaks si nasce in serie e di serie, esattamente come in una fabbrica.
A differenza di una normale catena di montaggio, però, al processo (ri)produttivo concorrono in modo eccezionale le esistenze e le motivazioni, estremamente diverse fra loro, di chi gravita attorno a Golden Oaks come Cliente, Ospite, dirigente o semplice lavoratore. Si deve alle identità sfaccettate e complesse dei personaggi lo scenario chiaroscurale del romanzo, che evita una netta, immediata demarcazione tra abuso e innocenza, e legittima il dispiegarsi della vicenda e il progredire della riflessione che ne deriva.
C’è Jane, docile e spaventata Ospite filippina, che accetta il contratto per offrire un futuro migliore alla sua bambina di pochi mesi: una delle tante passate dall’accudire al mettere al mondo i figli degli altri per tirar grandi i propri. C’è Reagan, giovane americana che aderisce al programma per puro idealismo, convinta di contribuire a realizzare un desiderio di maternità che altrimenti resterebbe insoddisfatto. C’è anche la sua amica Lisa, totalmente disillusa nei confronti di Golden Oaks e decisa soltanto a sfruttare i vantaggi economici del suo accordo, che prevede un pacchetto di tre figli in tre anni. E poi c’è Mae, che dirige la clinica con abilità manipolatoria e assenza di scrupoli mentre progetta il suo matrimonio e il futuro della sua famiglia.
Ci sono Clienti premurose, ed altre totalmente assenti, sostituite da figuranti. Ci sono personalità dominanti e altre soggiogate, e ci sono i nascituri, inevitabilmente considerati come una merce di scambio dalle une e dalle altre.
Non ci sono interrogativi espliciti né risposte dirette, mancano concessioni al patetismo e sfoggi di retorica, persino nel finale. Joanne Ramos restituisce piuttosto immagini, scene che s’impongono per il loro nitore e costringono alla riflessione. In una di queste, Reagan è sottoposta a un’ecografia tridimensionale, ma, per quanto provi ad allungarsi, dal lettino su cui è sdraiata non riesce a vedere lo schermo dell’ecografo, rivolto verso un computer per permettere alla madre biologica di seguire l’esame in streaming. Un’altra descrive un servizio fotografico destinato a immortalare i primi due figli dei Clienti mentre «interagiscono […] con la pancia nuda di Lisa», che darà alla luce il terzo fratello.
Spetta al lettore interrogarsi sulla verosimiglianza di tali scene, e su ciò che, per lo meno nella finzione romanzesca, le rende credibili. A partire dalla distorsione del linguaggio, che traduce la provvisorietà del ruolo materno dei surrogati con la definizione “Ospite” e mette al riparo le madri dietro la maschera di “Clienti”; o dagli slogan di cui si serve la direttrice della clinica, che assicura alle proprie dipendenti che i genitori biologici sono «persone che stanno cambiando il mondo», anche se in alcuni casi si tratta semplicemente di una modella non disposta a prendere peso. Tocca alle donne e alla società intera domandarsi quanto di tutto questo potrebbe davvero accadere e quanto stia già accadendo; dove abbiamo rivolto lo sguardo mentre succedeva e a quali slogan abbiamo prestato l’orecchio.
La fabbrica dei nascituri
Un romanzo distopico sulle derive della maternità surrogata
/ 28.09.2020
di Federica Alziati
di Federica Alziati