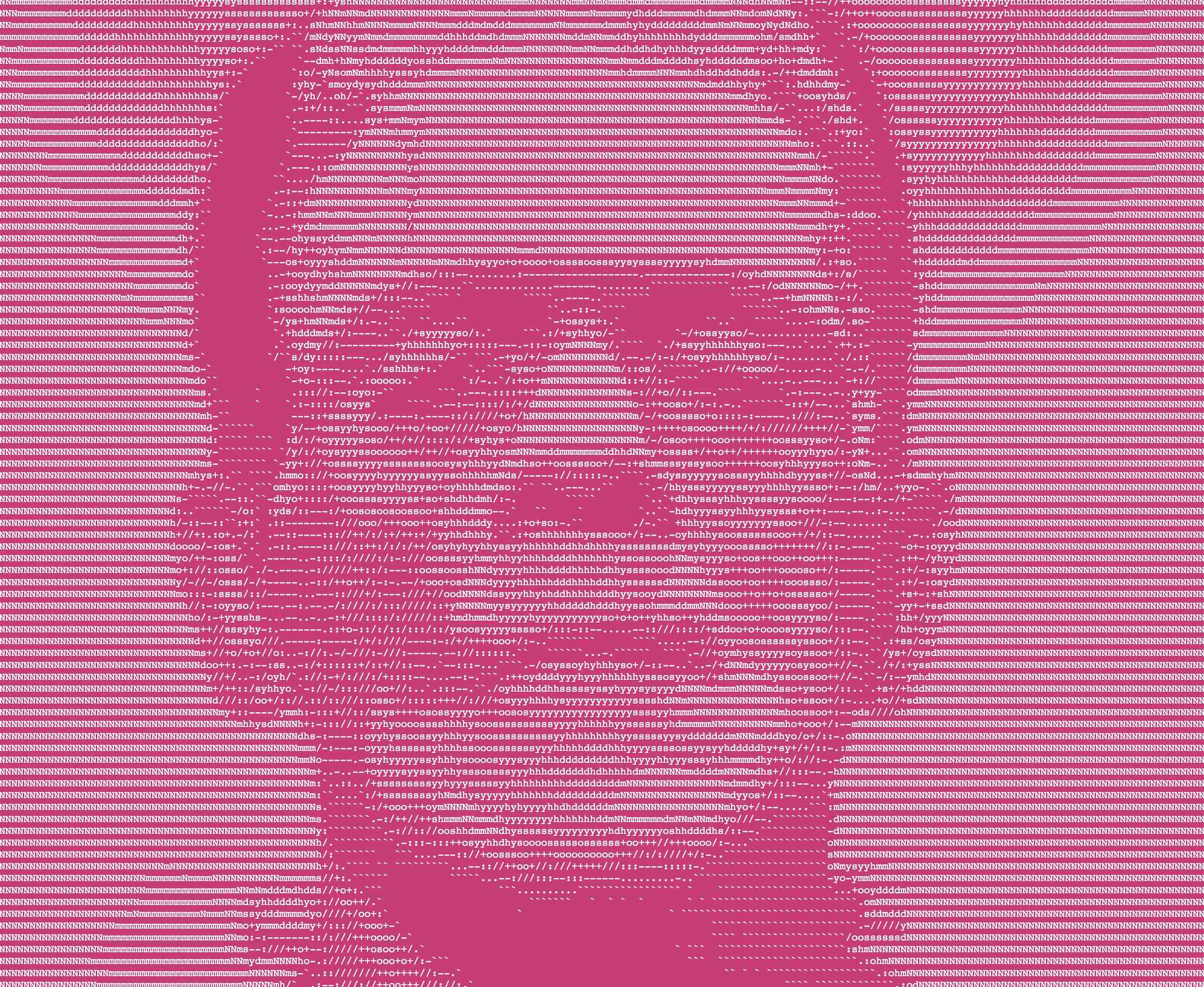Il buio, reale e metaforico, da sempre alimenta le nostre paure, dà forma ai nostri incubi. Anche la scienza, si sa, ha il suo lato oscuro, spesso più immaginario che reale. E se i tempi cambiano, e i progressi della conoscenza galoppano, paure e timori, a quanto sembra, si rinnovano. Da qui la necessità di interrogarsi, di riflettere, di confrontare il passato con il presente, e viceversa. È quanto ha deciso di fare il Museum Strauhof di Zurigo, con un’intrigante proposta: un itinerario tematico che, partendo dal romanzo Frankenstein di Mary Shelley – inizialmente pubblicato nel 1819 – arriva dritto nel cuore della contemporanea Silicon Valley, tempio mondiale dell’intelligenza artificiale.
Se è vero che da quel lontano 1819 il sapere ha fatto passi da gigante, non si può certo dire che le scoperte scientifiche abbiano smesso di destare preoccupazioni, nutrire dubbi, e animare paure che ci prospettano un futuro quantomeno rannuvolato. Con il romanzo del 1819, Mary Shelley inaugura un genere, quello della fantascienza, e dà forma a un personaggio il cui destino non ha mai smesso di essere attuale, come testimoniano le molte trasposizioni teatrali prima e poi cinematografiche di Frankenstein nel XIX e nel XX secolo.
A dare impeto all’appassionante vicenda narrata nel romanzo, e ad animare incubi di più di una generazione, è l’azione sconsiderata del Dottor Frankenstein che, assemblando parti del corpo provenienti da diversi cadaveri, infonde la vita a una creatura che gli sfuggirà di mano, diventando una potenziale minaccia per il genere umano. Senza nome, l’essere prodotto dal dottor Frankenstein verrà indicato, lungo la narrazione, con una serie di epiteti denigranti che attingono tanto alla semantica del mostro quanto a quella e del diavolo.
Se, da una parte, l’assenza del nome agevola la sovrapposizione metonimica della creatura al creatore (nell’immaginario collettivo il nome Frankenstein designa la creatura piuttosto che il creatore), d’altra parte quell’assenza si configura come un luogo simbolico in cui si insinua una paura irrazionale, indefinita, che incessantemente si rinnova, e che si tramanda di generazione in generazione: fino a giungere ai giorni nostri dove, sotto il sole della California, prendono forma le moderne «creature» dotate di intelligenza artificiale. Sarà che forse, oggi come allora, ci si prospetta un mondo nel quale non siamo più noi a controllare la scienza e la tecnologia, ma sono la scienza e la tecnologia a controllarci? O sarà che forse il laboratorio (un luogo chiuso, protetto, appartato), vero e proprio dispositivo della modernità, finisce per essere associato, oggi più che mai, al potere demiurgico dell’essere umano?
È noto infatti che tanto più le ricerche sono di punta e si annunciano innovative, tanto più vengono svolte lontano dagli sguardi indiscreti dei diretti concorrenti, dei media o di altri agenti. Inevitabilmente, quindi, chi non manipola direttamente il sapere, si ritrova vittima e complice di una doppia lontananza. È infatti lontano dai nostri sguardi che si consumano le fasi decisive delle sperimentazioni scientifiche. Nel migliore dei casi, si tratta di laboratori ben forniti o, nel caso dell’intelligenza artificiale, di moderni centri informatici. Può capitare però che, complici anche i timori e le paure che alimentano il lato oscuro della scienza, l’immaginazione ci prospetti luoghi nascosti che ospitano esperimenti clandestini: magari degli scantinati, o dei magazzini abbandonati, dove scienziati dissennati minacciano di combinare chissà quali disastri planetari, come nelle avventure di James Bond, o nella saga di Mission Impossible. Oppure, più prosaicamente, la fantasia ci suggerisce dimore private trasformate in laboratori improvvisati. Avete presente il film La mosca di David Cronenberg?
La seconda lontananza, invece, è simbolica. Oggi forse più che in passato, la specializzazione del sapere rende sempre più difficile, per non dire impossibile, una conoscenza organica e comprensiva del mondo. Ecco che allora si fa strada il timore che il progresso finisca nelle mani di robot superintelligenti – moderni pronipoti della creatura del dottor Frankenstein –, che potrebbero porre fine al mondo così come lo conosciamo.
Siamo, lo ripetiamo, sul terreno dell’immaginario: un insieme di narrative, immagini, sogni e timori che definiscono un’epoca, e che tanto la letteratura, il cinema, la politica, il marketing, quanto la scienza più avanzata contribuiscono a creare. Poiché, in fondo, tutto è appeso a qualche fragile domanda: chi siamo? dove andiamo? cosa desideriamo e cosa, invece, temiamo? Con delle domande così importanti, è facile immaginarsi che qualcosa, ogni tanto, possa andare storto.