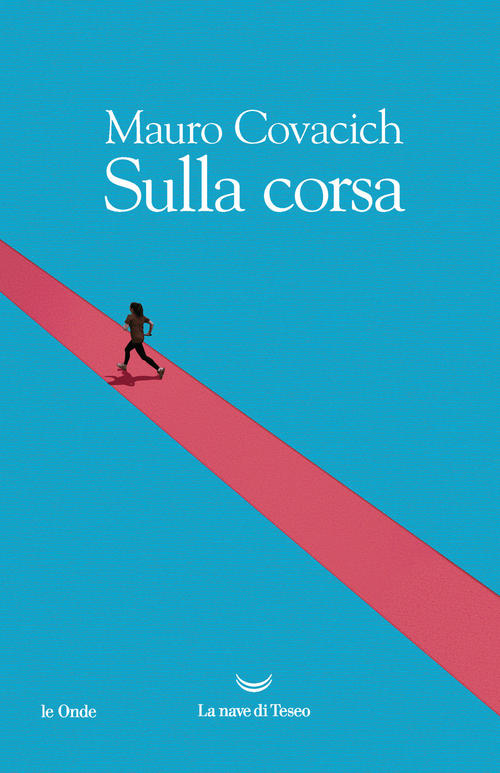La maratona, e comunque la corsa in genere, è lo sport più individualistico e interiore, una lotta contro il tempo e lo spazio dove si misurano le forze, ma anche quello più olimpico in assoluto e il più classico ed economico di tutti. Basta indossare un buon paio di scarpe, una tuta, e mettersi su strada, correre nei boschi o lungo il bagnasciuga, nei prati o nei campi sportivi, spingersi in luoghi abituali che alla fine si conoscono a memoria. Ma presto quella che è da tutti considerata un’attività salutare per eccellenza, usata per fare cure dimagranti o per abbassare drasticamente i valori del colesterolo, rimediare all’invecchiamento delle cellule, si trasforma in qualcosa d’altro, di più introspettivo e profondo, una vertigine che diventa anche «una scelta estetica».
Almeno a detta di Mauro Covacich, romanziere di lungo corso e tra i migliori della sua generazione, autore di un piccolo intrigante libro, Sulla corsa (La nave di Teseo, 2021) che mette insieme momenti, pezzi di memoria tra il 1976 e il 2019, un racconto di formazione di quarant’anni di autobiografia atletica vissuti sulle strade del mondo. Una memoria che ha già prodotto un romanzo tra i migliori dello scrittore triestino, di rara calibratura e forza espressiva, A perdifiato (sempre La nave di Teseo, i delfini) di ambientazione ungherese, dal quale è partito per il video-romanzo L’umiliazione delle stelle, una performance dove Covacich ha corso su un tapis roulant la distanza classica della maratona, 42 chilometri e 192 metri, un video dove per tre ore ripete gli stessi gesti atletici. La sua è soprattutto una riflessione di un intellettuale su una pratica sportiva ormai diventata di massa, una attività che somiglia «più a un arte marziale che a uno sport», confessa l’autore, oppure «la cosa più bella che una mente umana possa produrre», o ancora «il più alto grado di bellezza nella corsa» che il corpo possa raggiungere.
Lui la scopre ragazzino in un sabato di dicembre a Trieste a una gara del dopolavoro, la città dove è nato, e mentre corre pensa di morire «in mezzo alla strada sgombrata per la corsa, davanti a pochi curiosi infreddoliti». Alla fine, arriverà solo terzo, vincendo un panettone e L’allegro chirurgo. Ma ha già incubato quella che considera una malattia o addirittura una «intossicazione», una assoluta dipendenza, la vertigine introspettiva che gli farà trovare dentro in sé stesso il proprio avversario da superare, e poi «i limiti del corpo, i limiti della mente, è questo che intende forzare, qualunque sia il suo livello».
Una esperienza (che l’autore vive la prima volta da ragazzo in una «pulsione di morte») che il maratoneta tenderà a ripetere come una ricerca di estasi, «una forza irresistibile che produce quella condizione di annullamento simile all’orgasmo in cui la coscienza si scioglie nell’indistinto, così come le molecole di glucosio si scindono nella produzione di energia e gli acidi grassi si ossidano», la petite morte dell’atto sessuale, il suo erotismo panico. Anche Filippide, ci ricorda, il primo di tutti, corre ad Atene da Maratona dopo la battaglia e muore subito dopo l’annuncio, «una missione estrema» la sua, «e in effetti mortale, compiuta in uno stato di esaltazione».
Con una lingua colloquiale, e molto spesso in presa diretta, la lingua del reportage o del racconto intimo, Covacich ci porta dentro il mondo complesso dell’uomo che corre, disegnandone anche la fisionomia simbolica e antropologica, ma anche sociologica di certi rituali uguali per tutti, come quelli esilaranti e massificati dei partecipanti alla maratona di New York, le «tre ore di fila al marathon expo per ritirare il pacco gara», oppure la piccola gita in pullman prima di essere scaricati sul ponte di Verrazzano «tre ore prima della partenza, insieme agli altri cinquantamila concorrenti».
Covacich racconta la sua New York, corsa nel 1999, la «disperazione del benessere» di una popolazione occidentale abbiente, «quei tizi che sembrano miserabili moribondi e sono consumatori di amminoacidi ramificati a un euro a pillola», così come alcuni alcuni campioni come Merlene Ottey, che vede come «una Venere callipigia uscita da un poema di Derek Walcott. Omerica e nera», oppure Haile Gebreselassie, campione olimpico etiope che incontra ad Addis Abeba, un moderno Abebe Bikila. Naturalmente nel libro rimette in circolo anche la memoria di alcuni libri, Correre di Echenoz, biografia letteraria del più grande maratoneta di tutti i tempi, Emil Zatopek, «la locomotiva», che per tutta la vita «non smetterà mai di misurarsi con sé stesso», e L’arte di correre di Murakami Haruki, che però lo lascia insoddisfatto, sente che «non è riuscito a interrogare fino in fondo la sua passione prediletta». Ma lo scrittore giapponese coglie, comunque, una cosa che apparenta, come in Covacich, letteratura e corsa: «Scrivere un libro» afferma, «è un po’ come correre una maratona, la motivazione in sostanza è della stessa natura: uno stimolo interiore silenzioso e preciso, che non cerca conferma in un giudizio esterno».
La corsa è un romanzo
L’ultimo libro di Mauro Covacich racconta la storia di una passione capace di diventare una mania
/ 19.07.2021
di Angelo Ferracuti
di Angelo Ferracuti