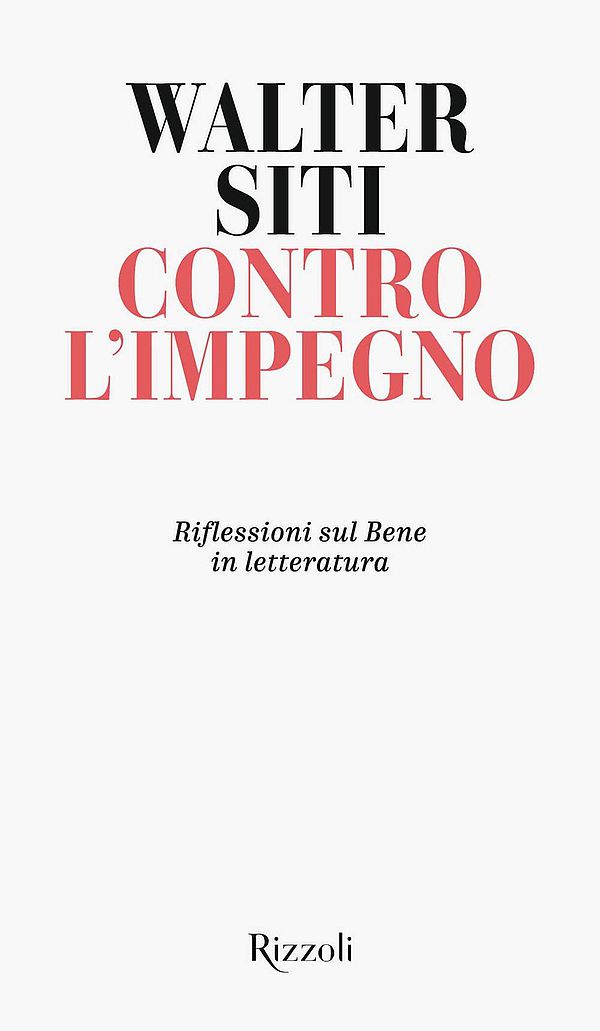Era il 2008 quando Barack Obama coniò il famoso slogan «Yes, we can repair the world», che oggi trova un corrispettivo nel valore terapeutico e ricostruttivo di tanta letteratura: se il mondo è malato, la letteratura, «come una brava infermiera», deve contribuire a risanarlo attraverso messaggi rassicuranti, rafforzando il Bene e condannando il Male. È questa la questione su cui poggia l’ultimo pamphlet di Walter Siti, il cui titolo è già una dichiarazione di intenti (Contro l’impegno), dal carattere assertivo appena smorzato dal tono più disteso del sottotitolo (Riflessioni sul Bene in letteratura).
Siti vede una buona porzione del campo letterario (specie italiano) colonizzata da un «neo-impegno» che si sarebbe sviluppato a seguito di alcuni sconvolgimenti storico-politici: il crollo del Muro di Berlino, la fine dell’Unione Sovietica, le guerre in Jugoslavia, ma soprattutto l’abbattimento delle Torri gemelle nel 2001. Per carità: niente di male se gli strali degli scrittori si acuminano nel denunciare surriscaldamento climatico, discriminazioni, sfruttamenti, populismi di varia natura, nuovi schiavismi. Il problema si pone nel momento in cui il (ripeto: legittimo) sentimento di sentirsi in obbligo di difendere una democrazia sotto attacco coincide con una sorta di vergogna per il formalismo e si codifica, infine, in un ostentato disprezzo per la cura stilistica, perché «in trincea non stai a vedere come sei pettinato».
Al contrario, ed era ora che qualcuno tornasse ad affermarlo con garbata risolutezza, la forma del testo non può essere svilita a semplice abbellimento, a zuccherino (con buona pace di Tasso, aggiunge Siti) capace di far ingerire la medicina amara del messaggio edificante. Il lavoro sulla parola è indispensabile per rivelare i contenuti più complessi e più difficilmente attingibili, magari proprio quelli che lo scrittore sotto sotto voleva evitare. Proprio ciò che Siti ha saputo fare come romanziere, offrendoci le migliori cose della narrativa italiana degli ultimi anni.
Il maggiore obiettivo della letteratura non è «la testimonianza», ma «l’avventura conoscitiva»: obiettivo che solo la parola letteraria può perseguire, perché è l’unica, come la nostra psiche, a essere ambigua, capace cioè di affermare una cosa e contemporaneamente di negarla; di costruire un terreno in cui le idee contrastanti possono «incarnarsi senza escludersi». E ciò a differenza di quel che accade nel giornalismo (per tornare a una questione da sempre al centro della riflessione di Siti), che non può permettersi di «dare cittadinanza a Satana». Rinunciare ai tempi lunghi del romanzo e della poesia aderendo a forme testuali più semplificate porta solo all’illusione di opporsi al Potere e non fa altro che omologarvisi. E su questo punto Siti apre a una discussione, qui appena accennata, sul ruolo delle strutture economiche nella costruzione delle forme artistiche di una certa epoca. Questione certo non nuova, ma necessaria se non urgente dopo i crolli dei Muri e delle Torri.
Evidentemente, non mancano i nomi. A Roberto Saviano, tanto per cominciare, è dedicato un vero e proprio saggio, che muove dalle esplicite critiche dell’autore di Gomorra nei confronti degli scrittori che si arroccano sulla torre d’avorio mentre il mondo brucia. Posizione in realtà controproducente, argomenta Siti, dato che sminuisce il valore profondo della letteratura e le sue possibilità conoscitive, finendo per rinfrancare i lettori nelle loro posizioni iniziali anziché destabilizzarli. A Gianrico Carofiglio l’autore rimprovera una «elegante postura antitragica»; ad Alessandro D’Avenia, tra le altre cose, «un antropocentrismo infantile e poetico». Tutti autori (e relativi testi di riferimento) analizzati con strumenti critici affilati e dovizia di argomenti convincenti, che mettono impietosamente a nudo (e qui, aggiungo io, Siti avrebbe anche potuto affondare il colpo) processi di semplificazione disarmanti, fatti di trame godibili, posizioni (troppo) nette, metafore facili facili, ironie più o meno stucchevoli.
Sta forse tramontando, conclude Siti, anche certa critica letteraria, «fatta di competenza tecnica e quindi elitaria»: ormai vale il principio per cui nella cultura umanistica si può giudicare senza conoscere e tutte le opinioni (impressioni?) hanno pari cittadinanza. Cosa non del tutto slegata da una sorta di «fuga nella scrittura, come se si scrivesse per essere chiamati scrittori e non per la passione di esporsi a un trauma».