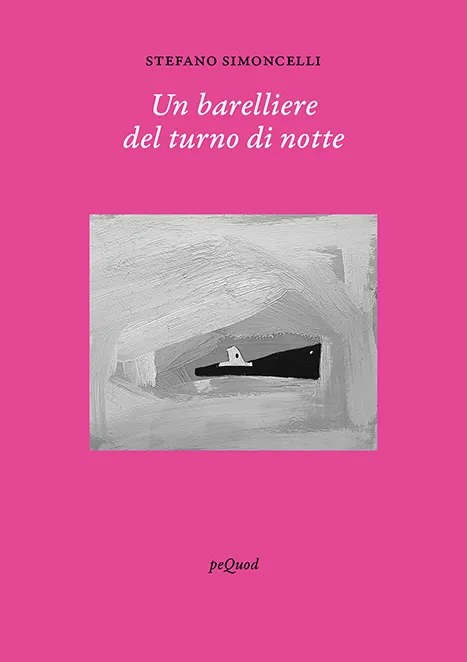Torna Stefano Simoncelli con una piccola ma preziosa raccolta di poesia edita dall’editore Italic Pequod dal titolo molto indicativo, Un barelliere del turno di notte, che ci riporta visivamente e anche emozionalmente, all’immane tragedia degli ultimi due anni che ognuno ha in qualche modo toccato. In questo aureo libriccino, come d’altronde in tutta la sua opera, il poeta, partendo appunto dalla quotidianità, fa scorrere sottotraccia qualcosa d’altro, forse per parafrasare Shakespeare, quella stessa materia di cui son fatti i sogni.
Ecco allora correre paralleli nel verso i giorni oscuri nei quali lo scrittore dà prova di entrare con l’occhio lucido e impietoso del cronista ma anche il loro risvolto metafisico, attraverso certe magistrali fughe oniriche, che si distendono nella pagina creando realtà parallele alla nostra e rafforzate: «Per le strade qui fermano tutti» / mi hanno scritto… / e all’alba ho sognato periferie / che sparivano nella nebbia / e fanali di posti di blocco / che illuminavano il niente // da dove usciva mia madre / con il cappottino rattoppato / e le scarpe distrutte dei giorni / in cui fuggiva dai rastrellamenti / tedeschi. Veniva avanti pregando // e si copriva gli occhi con le mani./»
L’intersezione dei tempi quindi è il tratto caratteristico della scrittura di Simoncelli, che per originalità e ampiezza costituisce un unicum nel panorama contemporaneo; e allora è difficile non avvicinarla, per forza visionaria, anche alla grande tradizione romagnola del Novecento, non solo poetico-letteraria, e penso su tutti a Raffaello Baldini, ma anche cinematografica. Difatti gli incontri che il libro porta in scena, sono vere e proprie epifanie laiche, apparizioni, che ci scuotono, facendo rielaborare in un attimo il vissuto e la realtà che ci circonda.Gli uomini e le donne che compaiono in questo libro, al di là di poche eccezioni, tra le quali gli illustri amici del poeta, come Enzo Siciliano e Ferruccio Benzoni, appartengono alla folta schiera di figure anonime ma esemplari per aver vissuto autenticamente, senza infingimenti, ogni loro giorno e certo sembrano affacciarsi dal lumicino flebile del passato e rianimare proprio loro, per paradosso, questo presente che sembra da molto tempo oramai in uno stato di cronica infelicità: «… / …ho visto mio padre senza cappotto nella neve / che gli arrivava sino al ginocchio / …caricando il peso sulla gamba buona, / … // …Chiedeva che lo andassi a prendere / e me lo caricassi sulle spalle / che non ce la faceva più, / … / e non aveva fatto in tempo / … // … a costruire una carrucola di canne … / che lo tirasse di peso con corde, liane / … / fino al terrazzo del secondo piano / da dove guardava il mare d’inverno».
Figure che nelle loro fuggevoli apparizioni, portando con sé un gesto, un sorriso, una incolmabile malinconia, riempiono ancora una volta di significato altro il tempo pandemico, che vorrebbe invece ingoiare in un buco nero la storia dell’individuo e delle sue relazioni, dandogli un punto di caduta definitivo. Ecco invece al contrario affiorare in Simoncelli, attraverso la continua costruzione dell’altro tempo, quello poetico, una diversa percezione del mondo, quasi un pensiero applicabile alla vita, che ogni lettore dovrebbe far suo.
Il libro è quindi un naturale crocevia e punto di intersezione tra i vivi e i morti che rievocati, appaiono più vivi dei vivi stessi; dal limbo onirico del poeta, tutti fuoriescono e tornano a camminare nel verso in una lunga schiera vociante, a volte silenziosa, nella gran via rattristata dei nostri giorni e talvolta, l’incontro tra certe figure memoriali e il virus produce strane dissociazioni e nuove realtà, tutte da interpretare: «Mi piacevano da morire le piazze / e le strade deserte nel periodo / del lockdown. Potevo vedere / chi volevo incontrare: figure / di persone scomparse da anni / … // Alla fine, oscillando sui tacchi, ecco mia moglie / che illuminava il buio che la nasconde / … / ma bella come sempre, esile ed elegante. / Aveva i guanti… e il cappello di rafia / che portava d’estate,… / e veniva su la nebbia dal fiume, tanta nebbia, // un mare di nebbia, e non vedevo più niente».
E le intersezioni temporali e spaziali di cui si accennava, avvengono talvolta coinvolgendo non solo i grandi autori letti, da Simenon a Tolstoj, da Celine a Dostoevskij ma anche quelli conosciuti fraternamente, che con le loro esistenze sembrano portare qualcosa che resiste e sostiene, innanzi al grande buio contemporaneo: la luce dell’arte, sempre dispensatrice delle umane sofferenze: «Non vedo più il paese come prima, / … / …Niente, proprio niente, // è come lo vedevo quando passeggiavo con Ferruccio / parlando di Holderlin-Scardanelli dal bar Campari / fino al molo. Qualche gauloise ed un abbraccio / …».
Questo mette in scena il libro, un variegatissimo coro di voci e quella magari anonima del barelliere del turno di notte, con le tante altre che si affacciano nel verso, sono lì a restituirci l’esperienza di ognuno, sempre in bilico tra dolore e ricerca della sfuggente felicità. Ecco, oltre questo mondo monocorde, asfittico in cui tutti siamo finiti, Stefano Simoncelli ne pensa e mette in scena altri, dove finalmente ritrovare ossigeno ma anche nuove ragioni di vita, in questa vita oramai inesorabilmente altra: «C’è un angolo di questa vecchia casa / in via dei platani, una rientranza / tra muri portanti con il lavello / e il rubinetto dove l’acqua / che scorre odora di mia madre / mentre mi lavo la mani e la faccia».